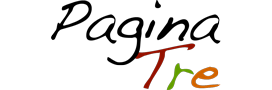Oltre la tela, oltre il mercato.
L’arte contemporanea, per quanto vibrante e ricca di espressioni, si trova oggi a un crocevia critico. Ho passato anni a riflettere su un paradosso che mi sembra sempre più evidente: l’arte, nata come specchio dell’anima e motore di cambiamento, rischia di smarrire la sua funzione sociale, rinchiusa in mercati autoreferenziali o ridotta a puro esercizio estetico. Per me, l’arte che davvero conta è quella che si confronta con le sfide del nostro tempo e che agisce. Questo mi ha portato a un percorso di ricerca personale che ha dato vita a un concetto che ritengo fondamentale: la sociurgia.
Il Mio Itinerario: Dalla Sociatria alla Sociurgia
La mia riflessione non è nata da un’astrazione teorica, ma da un percorso empirico, da un “vissuto” che si è intrecciato con le vite e le opere di alcuni artisti straordinari. Ho frequentato, ascoltato e osservato persone che, con la loro arte, non cercavano la notorietà o il successo commerciale, ma un contatto profondo e autentico con la realtà. Questo approccio, che ho chiamato “dianoetico”, mi ha permesso di unire il rigore del pensiero logico con la ricchezza dell’esperienza diretta.
Nel corso di questo viaggio, ho iniziato a distinguere due forme di azione artistica. La prima, che ho chiamato “sociatria”, è un’arte che “cura” le ferite della società. È un’arte terapeutica, che interviene sulle fratture esistenti, offrendo conforto o sollievo. È importante, ma mi sono reso conto che non era sufficiente. La seconda, la sociurgia, va oltre: è un’arte che non solo ripara, ma genera nuovi tessuti sociali. È un’azione proattiva, un atto di creazione che produce nuove forme di vita comunitaria e nuove possibilità di relazione. La sociurgia non interviene sul passato, ma costruisce il futuro.
Due Maestri, Due Approcci: La Fenomenologia della Sociurgia
La mia comprensione della sociurgia si è cristallizzata grazie a due figure artistiche che, pur molto diverse, ne incarnano i principi fondamentali.
Il primo è l’eroe solitario e visionario, un artista che con le sue opere crea mondi interiori così potenti da scuotere le coscienze. La sua arte non è immediatamente partecipativa, ma è profondamente sociurgica perché, agendo sull’individuo, innesca una trasformazione interiore che si irradia poi nella comunità. La sua opera è una pietra grezza che contiene in sé un universo di possibilità, che chiede a chi la osserva di farsi a sua volta costruttore del proprio significato e della propria visione.
Il secondo è il costruttore di comunità e custode della memoria, un artista la cui pratica è intrinsecamente relazionale. La sua arte non si trova in una galleria, ma nell’incontro, nel dialogo, nella condivisione di storie e nel rafforzamento dei legami sociali. Utilizza l’arte come un veicolo per tessere relazioni e per recuperare memorie collettive che rischiano di andare perdute. Le sue opere non sono oggetti, ma processi che rigenerano il senso di appartenenza e la coesione sociale.
Entrambe queste figure dimostrano che la sociurgia non è un fenomeno monolitico, ma un campo d’azione ampio, che può manifestarsi in modi diversi, ma sempre con un unico intento: generare vita.
L’Arte come Rivoluzione Antropologica
La sociurgia è un appello a una nuova forma di arte che non si accontenta di essere un prodotto da consumare, ma si fa processo da vivere. È un’arte che non mira a essere “bella” nel senso tradizionale, ma “utile” nel senso più profondo e vitale del termine.
Ho cercato di chiarire che la sociurgia non ha nulla a che fare con la propaganda o con la strumentalizzazione politica. Al contrario, è un’azione che rispetta l’autonomia della comunità in cui opera e che mira a liberarne il potenziale creativo. Essa si pone come uno strumento per quella che chiamo una “rivoluzione antropologica”: un profondo cambiamento nel modo in cui percepiamo noi stessi e le nostre relazioni con gli altri. Non si tratta di curare sintomi, ma di creare le condizioni per una società più sana, più coesa e più umana.