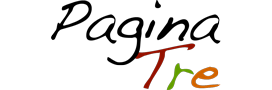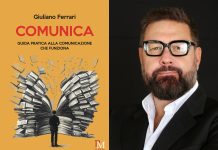Che fare? Nel 1901, quando il socialdemocratico Vladimir Ilich Lenin si pose questo interrogativo elementare, trovò una risposta comunista che avrebbe cambiato la storia della sinistra mondiale, ma oggi quell’enigma somiglia al rovello che interpella tanti socialisti democratici in uno dei tornanti più bruschi della storia degli ultimi cento anni. Mai nel passato una destra reazionaria – dagli Stati Uniti, all’Europa sino alla Russia – aveva esercitato una così estesa influenza e mai le forze del socialismo democratico avevano ridotto in modo così palpabile la propria incidenza.

Che fare? Le riflessioni proposte da Bobo Craxi e Franco Garofalo nel loro “Per un socialismo adatto ai tempi” hanno il dono della tempestività, contribuendo anche ad evidenziare il vuoto concettuale e politico che in questa fase storica accompagna la sinistra socialista. Craxi e Garofalo non rivendicano alcuna “pretesa di scientificità” e propongono una ricognizione critica su passato e presente, indicando alcuni sentieri che potrebbero portare verso territori nuovi, di nuovo fecondi.
Di nuovo fecondi, perché non si parte da zero e semmai è curioso quanto si fatichi a concettualizzare e trasformare in moneta corrente una verità storica evidente: il socialismo democratico europeo, nel promuovere l’evoluzione sociale e civile delle democrazie da fine Ottocento ad oggi, è stata la più incisiva tra tutte le forze politiche europee, contribuendo a migliorare le vite di centinaia di milioni di persone. Soltanto i Democratici americani, grazie al New Deal, grazie all’ingresso nella Seconda guerra mondiale e grazie al salvifico Piano Marshall, hanno prodotto risultati altrettanto incisivi nella storia politica degli ultimi due secoli.
E guardando al futuro, il passato conta. A cominciare dalle lezioni attualissime che vengono dalla prima, grande ondata socialista, quella di fine Ottocento. Allora i partiti socialdemocratici, laburisti, socialisti e i sindacati a loro collegati hanno contribuito a migliorare la vita di tantissimi sfruttati, sino ad allora inconsapevoli del proprio diritto alla dignità. Quelle condizioni così diffuse di miseria in tanti Paesi non esistono più e tuttavia un nuovo socialismo non può che partire, come a fine Ottocento, dagli ultimi e dai penultimi, dai tanti che soffrono spesso per ragioni che non riguardano solo la sopravvivenza.
Ma anche la seconda potente ondata socialista può essere fonte di ispirazione per il futuro. Dai primi anni Trenta fino agli anni Cinquanta e in Italia dal 1962 in poi, i socialisti sono determinanti nella nascita dello Stato sociale. In Svezia, Norvegia e Danimarca pieno impiego e sicurezza dal bisogno vengono raggiunti grazie ad una rete sociale imperniata sul movimento cooperativistico tra consumatori e agricoltori, una rete che potrebbe rivelarsi di nuovo utile. Dal 1945 il premier laburista Clement Attlee istituisce in Gran Bretagna il National Health Service, pietra miliare della sanità pubblica in tutto il mondo e la tardiva adozione in Italia, semmai, ha un vizio – l’universalismo – che ne depotenzia l’efficacia per i meno abbienti, Dunque, tra il 1930 e il 1950, e dal 1960 in Italia si dipana un trentennio sociale che precede – e si intreccia – con i “Trenta gloriosi” del boom di tutto l’Occidente: trent’anni di Stato sociale, nel corso dei quali i socialisti, contribuendo a rendere meno diseguali le società nelle quali operavano, a loro volta cambiarono; diventarono forze di riferimento per un arco sociale più largo di quello proletario, operaio e bracciantile delle origini. I socialisti diventano i partiti dell’alternativa progressista.
E per ultimo arriva il ventennio che va dal 1974 al 1996, con la singolare concentrazione di personalità carismatiche, da Mitterrand a Schmidt, da Craxi a Gonzalez, da Palme a Soares che contribuiscono a determinare un’autentica egemonia in quella fase di costruzione europea: tra il 1979 e il 1994 il Pse è il primo partito e nel vertice di Nizza del 2000, 12 Paesi su 15 sono a guida socialista. Dopo quell’Europa sarebbe arrivata l’Europa del rigore che tanti guai ha provocato, al netto degli imbrogli contabili di qualche Paese disinvolto.
Dunque, che fare? Craxi e Garofalo non propongono panacee e d’altra parte la configurazione di un nuovo socialismo è impresa titanica. Nel dialogo si intrecciano spunti teorici e l’esempio di buone e cattive pratiche. Si dà conto della crisi del capitalismo democratico, anche se per il momento i richiami sentimentali a Marx, che qua e là tornano a riecheggiare, non si sostanziano con rigorosi e concreti rilanci. Anche perché la Cina, il Paese emergente, che già contende il primato del mondo agli Stato Uniti, avanza proprio con una variante del capitalismo: il capitalismo alla cinese, autoritario.
Chiunque si cimentasse in una definizione teorica di una nuova frontiera socialista, non potrà non partire dalla differenza tra sinistra e destra, enucleata una volta per sempre da Norberto Bobbio. Il vero crinale si riassume nel diverso atteggiamento verso l’ideale di eguaglianza. La destra è più disposta ad “accettare ciò che è naturale e quella seconda natura che è la consuetudine, la tradizione, la forza del passato”, mentre la sinistra ha sempre lottato per accorciare le diseguaglianze e quella resta la sua missione sociale.
Le società più avanzate, quelle che avanzano e quelle che avanzeranno, non hanno gli stessi problemi. In Italia ci sono tanti ragazzi tra i 18 e i 24 anni che non studiano né lavorano, i sociologi li hanno battezzati “Neet” ma nessuno pensa a loro; tanti ragazzi e anche meno giovani soffrono pene laceranti per una condizione psicologica difficile ma soltanto chi ha i mezzi economici e culturali, può provare ad uscirne. In tanti guadagnano troppo poco. In tanti faticano a curarsi. Condizioni verso le quali tutte le forze politiche affettano preoccupazione, ma in modo paternalistico. Col contagocce. Un nuovo umanesimo socialista non potrà non ripartire da un imperativo categorico, sempre lo stesso: lottare per una piena autodeterminazione. Dei popoli, ovviamente, Ma anche dei singoli: dentro una città, un Paese e una comunità più giusti di quelli che abbiamo trovato quando siamo nati. In questo senso il vecchio adagio marxiano, “ad ognuno secondo i propri meriti, ad ognuno secondo i propri bisogni”, anche se dovesse apparire un’utopia, può però costituire un’aspirazione, un traguardo per un socialismo degno di questo nome.
Acquisto
Per un socialismo adatto ai tempi
Un dialogo su passato e futuro
di Bobo Craxi e Franco Garofalo
prefazione di Fabio Martini
Biblion Edizioni, 2025
ISBN 978-88-3383-464-1
Bobo Craxi
Vittorio “Bobo” Craxi, nato a Milano nel 1964, è uomo politico, dirigente socialista, già parlamentare ed esponente di Governo (al Ministero degli affari esteri nel dicastero di Centrosinistra guidato da Romano Prodi), esperto di politica internazionale. Ha vissuto a Milano, a Hammamet, per brevi periodi a Trapani e a Barcellona. Attualmente vive a Roma. Per i tipi di Biblion Edizioni ha pubblicato Lettere da Barcellona (2018) e Nuove Lettere da Barcellona (2021).
Franco Garofalo
Franco Garofalo, nato a Bari, è autore di testi letterari, teatrali, saggistici e di arti visive. Insegna Filosofia e Storia, per dieci anni con incarico di missione nelle Scuole Italiane all’estero. Ha lavorato come regista per RAITRE e RAI UNO nell’85 e nell’87. Come autore di testi è stato recensito sui più diffusi quotidiani nazionali. Attivo fra gli anni ’80 e ’90 sulla scena romana del teatro di ricerca, è stato anche sceneggiatore. Tra le pubblicazioni si ricordano: Antiestetica (2000), L’amore eterno (2020), Racconti degli anni impossibili (2021), Terminal Nebulosa (2022).
Fabio Martini
Dal 1989 segue per “La Stampa” i principali eventi politici. Autore, tra gli altri, di L’opposizione al governo Berlusconi (Laterza), La fabbrica delle verità (Marsilio), Controvento (Rubbettino), Nathan e l’invenzione di Roma (Marsilio). Per il “Mulino” e “Problemi dell’informazione” ha scritto saggi sulla natura “tifosa” dei giornalisti italiani. Insegna “Giornalismo politico” all’Università di Tor Vergata.