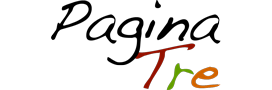Tra Bruxelles e Washington, Roma si trova costretta a ridefinire se stessa: mentre Metsola rassicura gli industriali italiani, l’ombra lunga della nuova politica estera americana impone nuove domande e antiche inquietudini.
Le due Europe dell’Italia: quella che promette e quella che manca
C’era una volta l’Europa. Non quella dei padri fondatori o degli ideali kantiani che sognavano la pace perpetua, bensì l’Europa reale, tangibile e tattile, fatta di fagioli troppo piccoli per essere accettabili e di tappi di plastica troppo attaccati per sembrare intelligenti. In questa Europa entra in scena Roberta Metsola, figura simbolica e programmatica di una Unione che si vuole alleata e non nemica, facilitatore e non ostacolo, e che lo dichiara davanti a un pubblico strategico: l’assemblea di Confindustria.
Atto Primo: l’Europa che promette
La visita di Metsola è insieme teatrale e politica, o, se si vuole, “performativa” nel senso più foucaultiano del termine: il suo esserci è già un atto di governo. Parlare accanto a Giorgia Meloni – la cui parabola va oggi compresa più nella sua tensione rappresentativa che nelle sue contraddizioni – equivale a suggellare un’alleanza: l’Europa non è solo Bruxelles, ma anche Bologna, non solo Trattati, ma anche Tazzine di Caffè. Un continente che abbraccia il Made in Italy come se volesse profumarsi di Parmigiano Reggiano e Ferragamo.
Eppure, nell’elogio della manifattura, nel parlare di barriere da abbattere e dazi da evitare, affiora una domanda: può un’Europa così, tenera come un tortellino e sorridente come un’eurodeputata maltese, reggere l’urto di un mondo che si disintegra nelle sue alleanze tradizionali?
Atto Secondo: l’America che si disinnamora
Nel frattempo, sull’altra sponda dell’Atlantico, il sipario si chiude su un’America che, pur non dichiarando apertamente il divorzio, ha già preso a dormire in un’altra stanza. L’analisi della nuova postura americana – più interessata al Pacifico che all’Adriatico – mette in discussione proprio quella sintonia che Metsola proclama come “la più profonda della storia moderna”. In realtà, l’Italia si scopre sola nella propria fedeltà: l’alleato storico si distrae, si decentra, si de-atlantizza.
Il problema non è solo esterno: Roma, dice l’analisi geopolitica, è attraversata da una crisi interna che non è più solo ideologica ma quasi ontologica. Se un tempo l’identità internazionale era il riflesso di un’identità politica interna relativamente coesa, oggi l’instabilità partitica si riflette come dissonanza strategica. La politica estera italiana rischia di diventare, come l’Enigma di Saussure, un significante senza significato.
Dialettica: due mappe incompatibili
Ecco allora la dialettica: da un lato Metsola offre una visione di un’Europa che non solo accoglie, ma esalta l’identità italiana; dall’altro, l’analisi geopolitica svela un contesto globale in cui l’Europa stessa è incerta, confusa, forse persino irrilevante. Come si coniugano queste due visioni? Possono davvero convivere la rassicurazione simbolica della Presidente del Parlamento europeo con il realismo disilluso di una politica americana che guarda altrove?
Eco avrebbe forse sorriso di fronte a questa contraddizione. La semiotica delle istituzioni ci insegna che ogni gesto politico è un segno, e che ogni segno, se privato di contesto, diventa superstizione. Il discorso di Metsola è necessario, ma forse insufficiente: un elogio dell’Europa come “migliore sé stessa”, mentre fuori, nel mondo reale, si combatte per la sopravvivenza delle alleanze e della stessa idea di Occidente.
La “nuova America” non è più quella del Piano Marshall, e nemmeno quella del “presidente amico”: è una potenza che ragiona in termini funzionali, non affettivi. E se l’America cambia, l’Italia è costretta a interrogarsi: quanto vale oggi l’Europa per Roma? E soprattutto: quale Europa?
Conclusione: tra l’identità e l’autonomia
Il bivio è quindi esistenziale, più che strategico: o l’Italia decide di accettare la nuova Europa come propria patria politica, facendo di essa non solo un’alleanza commerciale ma una dimensione morale e storica; oppure dovrà trovare una nuova postura intermedia, più autonoma, più rischiosa, più ambigua.
Nel frattempo, il Papa resta – sorprendentemente – l’unico soggetto dotato di autorevolezza trasversale. Un’anomalia, certo. Ma anche un segnale: quando le potenze si distraggono e le istituzioni balbettano, tocca alla metafisica rimettere ordine. E forse, in tutto questo, l’Italia non ha bisogno di scegliere tra Metsola e la nuova America, ma di ricostruire un’idea di sé che sia all’altezza del proprio passato e non in ostaggio del presente.
Perché, come avrebbe detto il professore di Alessandria, Umberto Eco, “siamo nani sulle spalle di giganti, ma con il torcicollo della cronaca.”