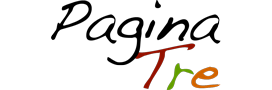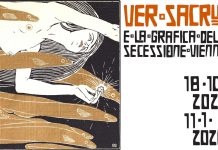LA NASCITA DELLA SOCIURGIA: UNA TRATTAZIONE SCIENTIFICA
Premessa metodologica
Il presente testo costituisce un’analisi introduttiva alla genesi della sociurgia, concetto che si propone come categoria interpretativa dei fenomeni artistico-sociali contemporanei. L’approccio adottato è di tipo storico-critico e teorico-concettuale, finalizzato a tracciare l’evoluzione delle funzioni dell’opera artistica e a identificare le discontinuità epistemologiche che conducono all’emergere di nuovi paradigmi interpretativi.
1. Le origini dell’espressione artistica e la struttura quadripartita dell’opera d’arte
1.1 Contesto cronologico e antropologico
L’espressione artistica intenzionale, definita come la produzione di artefatti con finalità che trascendono la mera funzionalità utilitaristica, emerge approssimativamente 40.000 anni fa, durante il Paleolitico superiore. In questo periodo coesistono due specie del genere Homo: l’Homo sapiens (l’uomo anatomicamente moderno) e l’Homo neanderthalensis (l’uomo di Neanderthal). Entrambe le specie manifestano capacità simboliche e comportamenti culturali complessi, come attestato da reperti archeologici quali pitture rupestri, incisioni e oggetti ornamentali.
1.2 Definizione di “opera artistica” e “medium dell’arte”
Per opera artistica si intende un manufatto o una performance che si colloca all’interno di quello che può essere definito medium dell’arte, vale a dire lo spazio concettuale, sociale e culturale che conferisce all’oggetto o all’azione lo statuto di “arte”. Il medium non è semplicemente il supporto materiale (pietra, tela, ecc.), ma l’insieme di convenzioni, pratiche istituzionali, aspettative culturali e sistemi di riconoscimento che permettono a un artefatto di essere percepito e valutato come artistico.
1.3 I quattro fattori costitutivi dell’opera artistica
Dalla preistoria fino alla metà del XIX secolo (circa 1850), l’opera artistica nelle arti visive (pittura, scultura, architettura decorativa) si struttura su quattro funzioni fondamentali, che operano in modo interconnesso e spesso simultaneo:
1.3.1 Catarsi
La catarsi (dal greco kátharsis, “purificazione”) designa la funzione rigenerativa, di natura spirituale e psicologica, che l’opera esercita sia sul creatore sia sul fruitore.
- Per il creatore: la catarsi si manifesta come ispirazione, processo attraverso il quale l’artista attinge a dimensioni emotive, spirituali o immaginative profonde, traducendole in forma espressiva. Questo atto creativo produce un effetto liberatorio e trasformativo sulla psiche dell’artista.
- Per il fruitore: la catarsi si realizza come appagamento, una risposta emotiva che può includere identificazione, empatia, sublimazione di conflitti interiori o esperienza di trascendenza. Il concetto ha radici nella Poetica di Aristotele, dove la catarsi designa la purificazione delle passioni (pietà e paura) suscitate dalla tragedia.
1.3.2 Estetica
L’estetica (dal greco aísthēsis, “percezione sensibile”) indica la tendenza dell’opera verso il bello, inteso non come categoria assoluta ma come valore culturalmente determinato.
- Criterio estetico soggettivo: il giudizio di bellezza dipende dalla sensibilità individuale, plasmata da fattori psicologici, esperienziali e culturali.
- Modelli culturali e temporali: ogni epoca e civiltà elabora canoni estetici specifici (proporzione armonica nel classicismo greco, prospettiva nel Rinascimento, decorativismo nell’arte islamica, ecc.).
- Opera d’arte come valore assoluto: quando un’opera raggiunge un livello di perfezione formale e significato culturale tale da essere riconosciuta come eccellenza nel suo contesto storico, assurge alla dignità di opera d’arte in senso pieno. Questa consacrazione comporta l’ingresso dell’opera nella memoria storica, dove diventa modello di riferimento per le generazioni successive.
1.3.3 Rappresentazione della realtà e testimonianza fattuale
Questa funzione definisce l’opera come mimesi (dal greco mímēsis, “imitazione”), ovvero riproduzione del dato reale attraverso mezzi artistici.
- Rappresentazione della realtà: l’opera riproduce aspetti del mondo visibile, della natura, dell’anatomia umana, degli eventi storici o della vita quotidiana, secondo diversi gradi di fedeltà o interpretazione.
- Testimonianza fattuale: l’opera assume valore documentario, registrando informazioni su persone, luoghi, costumi, eventi storici. Prima dell’avvento della fotografia, l’arte visiva costituisce il principale mezzo di documentazione visuale.
- Relazione con il dato reale: questa funzione presuppone un rapporto referenziale tra l’opera e il mondo esterno, dove l’arte funge da mediazione tra realtà e rappresentazione simbolica.
1.3.4 Evocazione, celebrazione e commemorazione
Questa funzione attribuisce all’opera una dimensione rituale e memoriale, connessa a sfere sacrali, politiche e sociali.
- Evocazione delle divinità: l’opera invoca la presenza del sacro, fungendo da medium tra dimensione terrena e trascendente (icone religiose, statue cultuali, architetture templari).
- Celebrazione del potere: l’arte glorifica sovrani, figure politiche, élite dominanti, legittimandone l’autorità e magnificandone le virtù.
- Commemorazione di eventi: l’opera perpetua la memoria di battaglie, vittorie, catastrofi, riti di passaggio, inscrivendoli nella coscienza collettiva.
Questa funzione è particolarmente evidente nell’arte sacra medievale, nei monumenti commemorativi romani, nei ritratti dinastici e nelle opere commissionali del Rinascimento.
2. La crisi della struttura tradizionale: modernità e innovazioni tecnologiche
2.1 Contesto storico-sociale: la nascita della società moderna
La metà del XIX secolo (1850 circa) segna una cesura epocale nella storia dell’arte, coincidente con trasformazioni socio-economiche profonde:
- Industrializzazione: la Rivoluzione Industriale sposta masse di popolazione dalle campagne alle città, alterando radicalmente i ritmi di vita e le relazioni sociali.
- Secolarizzazione: il progressivo declino dell’autorità religiosa e la diffusione del pensiero scientifico e positivista riducono la pervasività della dimensione sacrale nella vita quotidiana.
- Reificazione dell’uomo: il termine reificazione (da res, “cosa”) indica, nella critica marxista e nella sociologia, il processo attraverso cui l’essere umano diventa oggetto, alienato dalla propria essenza creativa e ridotto a ingranaggio del sistema produttivo. Questa condizione esistenziale compromette la funzione celebrativa religiosa dell’arte, che presuppone un rapporto vitale con la dimensione trascendente.
- Svincolamento dalla natura: l’ambiente urbano industriale separa l’uomo dai cicli naturali, modificando la percezione del tempo, dello spazio e della propria collocazione cosmica.
2.2 L’avvento della fotografia e la crisi della funzione rappresentativa
L’invenzione della fotografia (ufficializzata nel 1839 con il dagherrotipo di Louis Daguerre) costituisce uno shock tecnologico per le arti visive:
- Immediatezza: la fotografia cattura la realtà istantaneamente, senza richiedere le lunghe ore di lavoro necessarie per un dipinto o una scultura.
- Economia: il costo di produzione di un’immagine fotografica è drasticamente inferiore rispetto alla commissione di un’opera pittorica.
- Precisione documentaria: la fotografia offre un grado di fedeltà alla realtà superiore a qualsiasi opera pittorica, esautorando parzialmente l’arte dalla sua funzione testimoniale.
Questa innovazione provoca una crisi della funzione rappresentativa e di testimonianza fattuale dell’arte, costringendo gli artisti a ridefinire il proprio ruolo sociale e la specificità del proprio linguaggio.
2.3 Le avanguardie come reazione alla crisi
Le avanguardie artistiche (termine militare che indica le truppe d’avanguardia, metaforicamente applicato ai movimenti artistici innovativi) emergono come risposta alla compromissione della funzione mimetica.
2.3.1 Dall’Impressionismo alle avanguardie storiche
- Impressionismo (1870-1880 circa): abbandona la rappresentazione dettagliata per catturare l’impressione soggettiva della luce e del colore in un dato momento.
- Post-Impressionismo, Espressionismo, Fauvismo: accentuano la deformazione espressiva e l’autonomia del colore rispetto al dato naturale.
- Cubismo: frantuma la prospettiva unitaria, rappresentando gli oggetti simultaneamente da molteplici punti di vista.
- Astrattismo: elimina completamente il riferimento figurativo, concentrandosi su forme, colori e composizioni pure.
- Dadaismo, Surrealismo: introducono l’irrazionale, l’inconscio, il non-senso come dimensioni estetiche legittime.
2.3.2 Caratteristiche delle avanguardie
- Instabilità formale: i movimenti si susseguono rapidamente, ciascuno proponendo linguaggi radicalmente diversi.
- Emancipazione dal dato reale: l’arte rivendica la propria autonomia rispetto alla natura, privilegiando la concettualizzazione (primato dell’idea sulla rappresentazione).
- Alienazione dalla coerenza espressiva: la molteplicità di linguaggi e la rapida obsolescenza dei movimenti compromettono la possibilità di elaborare una concezione universalistica dell’arte, ovvero un sistema di valori e criteri condivisi che trascenda le contingenze storiche e culturali.
2.4 La crisi generale dell’arte contemporanea
La perdita della funzione rappresentativa e il depotenziamento della funzione evocativa generano una crisi identitaria dell’arte contemporanea, caratterizzata da:
- Pluralismo senza sintesi: coesistenza di linguaggi eterogenei senza un principio unificante.
- Perdita di consenso sui criteri di valore: difficoltà nel definire cosa costituisca “buona arte” o nel distinguere l’arte dalla non-arte.
- Contraddizioni interne: tensione tra rivendicazione di autonomia estetica e dipendenza da fattori extra-artistici (mercato, istituzioni, critici).
2.5 Il potenziamento della funzione catartica e l’emergere della psicologia
Paradossalmente, mentre le altre funzioni declinano, la funzione catartica si intensifica, per diverse ragioni:
- Nascita della psicologia scientifica: Wilhelm Wundt fonda il primo laboratorio di psicologia sperimentale nel 1879; Sigmund Freud elabora la psicoanalisi alla fine del XIX secolo.
- Valorizzazione dell’interiorità: la psicologia porta attenzione ai processi inconsci, alle emozioni, ai conflitti interiori, dimensioni che l’arte può esplorare ed elaborare.
- Arte come terapia: si sviluppa la consapevolezza che la creazione e la fruizione artistica possano avere effetti terapeutici, anticipando discipline come l’arteterapia e lo psicodramma.
3. Dalla sociatria alla sociurgia: l’emergere di nuovi paradigmi
3.1 Jacob Levi Moreno e la sociatria
Jacob Levi Moreno (1889-1974) è uno psichiatra e psicologo rumeno-austriaco-americano, fondatore dello psicodramma, una forma di psicoterapia di gruppo che utilizza tecniche teatrali.
3.1.1 Definizione di sociatria
Sociatria (dal latino societas, “società”, e dal greco iatrós, “medico”) è un termine coniato da Moreno per designare la “cura della società”. Moreno concepisce la società come un organismo che può ammalarsi e necessitare di interventi terapeutici collettivi, non limitati al singolo individuo.
3.1.2 Lo psicodramma
Lo psicodramma è una metodologia terapeutica in cui i partecipanti mettono in scena aspetti della propria vita, conflitti, traumi o relazioni, interpretando ruoli in un contesto teatrale strutturato. Attraverso la rappresentazione e la spontaneità creativa, i pazienti acquisiscono insight, elaborano emozioni e sperimentano nuove modalità relazionali.
Elementi centrali dello psicodramma:
- Spontaneità: capacità di rispondere in modo creativo e adeguato a situazioni nuove.
- Tele: connessione empatica reciproca tra individui.
- Catarsi drammatica: liberazione emotiva attraverso l’azione scenica.
- Role playing: interpretazione di ruoli diversi dal proprio per esplorare prospettive alternative.
3.1.3 Dalla sociatria alle arti visive
Moreno applica la sociatria prevalentemente in contesti teatrali e terapeutici, ma i principi sottostanti – l’uso dell’espressione artistica per fini terapeutici collettivi – possono essere mutuati (trasferiti per analogia) alle arti visive. Se lo psicodramma utilizza il teatro, altre forme d’arte (pittura, scultura, installazioni) possono analogamente diventare strumenti di intervento sociale e terapeutico.
3.2 Evoluzione delle funzioni dell’opera nell’arte contemporanea
3.2.1 Depotenziamento della funzione evocativa/commemorativa/celebrativa
La funzione evocativa non scompare completamente, ma subisce un significativo depotenziamento (riduzione di efficacia e intensità) dovuto a:
- Secolarizzazione avanzata: ulteriore declino dell’esperienza religiosa collettiva.
- Frammentazione delle identità collettive: crisi delle grandi narrazioni (nazioni, religioni, ideologie) che un tempo fornivano riferimenti condivisi.
- Scomparsa della connessione con la funzione rappresentativa: senza un linguaggio figurativo condiviso, è difficile rappresentare e celebrare divinità, eroi o eventi in modo universalmente riconoscibile.
3.2.2 Persistenza e problematizzazione della funzione estetica
La funzione estetica permane “pressoché integralmente”, nel senso che persiste il desiderio di appagamento dei sensi (piacere visivo, emotivo, intellettuale). Tuttavia, emergono problematiche nuove:
- Precarietà dei criteri estetici: senza la funzione rappresentativa come riferimento stabile e con la molteplicità di linguaggi delle avanguardie, diventa difficile stabilire criteri condivisi di bellezza o qualità artistica.
- Relativizzazione: i criteri estetici diventano sempre più soggettivi e contestuali, perdendo pretese di universalità.
- Influenza di fattori extra-estetici:
- Mercato dell’arte: le dinamiche commerciali (gallerie, case d’asta, collezionisti) influenzano pesantemente quali opere vengono valorizzate, spesso indipendentemente dalla qualità estetica intrinseca.
- Critica militante: i critici d’arte non si limitano a valutare, ma promuovono attivamente certi movimenti o artisti, contribuendo a costruire il valore simbolico ed economico delle opere.
3.2.3 Perdita della vocazione all’opera d’arte
La vocazione dell’opera artistica, intesa come aspirazione intrinseca a “assurgere alla dignità di opera d’arte” (raggiungere lo status di capolavoro storico), viene meno perché:
- Punto di svolta epistemologico: i fondamenti stessi dell’arte sono stati messi in discussione.
- Futilità dell’operazione: inseguire i criteri tradizionali di perfezione formale sarebbe anacronistico, “fine a sé stesso”, privo di senso nel contesto contemporaneo.
- Mutazione degli attributi: le caratteristiche che definivano l’opera artistica si sono trasformate o dissolte, richiedendo nuove categorie interpretative.
3.3 La modernità liquida e la rivoluzione antropologica
3.3.1 Modernità liquida (Zygmunt Bauman)
Zygmunt Bauman (1925-2017), sociologo polacco-britannico, elabora il concetto di modernità liquida per descrivere la condizione contemporanea, contrapposta alla precedente modernità solida.
- Modernità solida (fine XIX – metà XX secolo): caratterizzata da strutture stabili, istituzioni durevoli, identità collettive forti, progetti a lungo termine, certezze ideologiche.
- Modernità liquida (dalla fine del XX secolo): caratterizzata da fluidità, precarietà, instabilità delle relazioni, flessibilità estrema, consumismo, individualizzazione, erosione delle certezze.
Nella modernità liquida, tutto ciò che era solido “si dissolve” (riprendendo Marx), comprese le forme artistiche, le istituzioni culturali, le identità professionali.
3.3.2 Rivoluzione antropologica
La società contemporanea attraversa una rivoluzione antropologica, definita come trasformazione radicale delle strutture fondamentali dell’esistenza umana: percezione di sé, relazioni sociali, rapporto con il corpo, concezione del tempo e dello spazio, valori etici.
Caratteristiche distintive:
- Non violenta e non manifesta: a differenza delle rivoluzioni storiche (Francese, Russa, ecc.), non si realizza attraverso eventi traumatici concentrati, ma è pervasiva (diffusa capillarmente in ogni aspetto della vita) e graduale.
- Portata comparabile: può essere accostata per impatto alla Rivoluzione Industriale (trasformazione dei modi di produzione e organizzazione sociale) o alle grandi rivoluzioni religiose (Cristianesimo, Islam, Riforma Protestante).
- Ridefinizione delle dinamiche: la rivoluzione antropologica modifica radicalmente:
- Dinamiche sociali: modalità di formazione dei gruppi, forme di solidarietà, strutture familiari.
- Dinamiche culturali: produzione e trasmissione di significati, sistemi simbolici, pratiche estetiche.
- Dinamiche istituzionali: funzionamento e legittimità di istituzioni politiche, educative, religiose, artistiche.
3.4 Le sei dimensioni del mutamento globale
La rivoluzione antropologica contemporanea si articola in sei dimensioni principali, che operano in modo interconnesso e sinergico:
3.4.1 Globalizzazione
Globalizzazione indica l’intensificazione dell’interconnessione mondiale tra economie, culture, società, resa possibile da tecnologie di comunicazione e trasporto, liberalizzazione commerciale, flussi migratori.
Effetti:
- Ridefinizione dei confini: i confini nazionali perdono rilevanza come barriere economiche e culturali.
- Relazioni umane transnazionali: identità e appartenenze non sono più esclusivamente legate al territorio.
- Complessità trascendente: i fenomeni globali non possono essere compresi attraverso le tradizionali categorie di analisi nazionali o regionali, richiedendo nuovi paradigmi interpretativi.
3.4.2 Antropocene vs. Capitalocene
Antropocene (dal greco ánthropos, “uomo”, e kainós, “recente”) è un termine proposto da Paul Crutzen nel 2000 per designare una nuova epoca geologica, caratterizzata dall’impatto dominante dell’attività umana sul sistema Terra (clima, biodiversità, cicli biogeochimici).
Capitalocene è una categoria critica alternativa, proposta da studiosi come Jason W. Moore, che attribuisce la responsabilità delle trasformazioni ecologiche non all’umanità in modo indifferenziato, ma specificamente al sistema capitalistico.
Differenze concettuali:
- Antropocene: presuppone una responsabilità generica della “specie umana”, senza distinguere tra diversi sistemi economici, classi sociali o aree geografiche.
- Capitalocene: identifica nel capitalismo – con le sue logiche di:
- Crescita illimitata: espansione perpetua della produzione e del consumo.
- Sfruttamento: estrazione intensiva di risorse naturali e lavoro umano.
- Disuguaglianza: distribuzione asimmetrica delle risorse e degli impatti ambientali (i paesi ricchi consumano di più ma i paesi poveri subiscono maggiormente le conseguenze climatiche).
La prospettiva del Capitalocene è più critica e politicamente orientata, evitando di diluire le responsabilità storiche e strutturali.
3.4.3 Ipermediatizzazione
Ipermediatizzazione (da iper-, “oltre”, e “mediatizzazione”, dal latino medium, “mezzo”) designa la saturazione della vita quotidiana da parte di informazioni e media digitali.
Caratteristiche:
- Ubiquità dei media: smartphone, social network, piattaforme streaming, Internet of Things pervadono ogni momento della giornata.
- Ridefinizione dell’interazione sociale: le relazioni si mediano sempre più attraverso schermi e interfacce digitali, modificando modalità comunicative, costruzione dell’intimità, forme di socialità.
- Alterazione della percezione della realtà: il confine tra esperienza diretta e esperienza mediata si assottiglia; la realtà viene sempre più percepita attraverso filtri tecnologici, algoritmi, narrazioni mediatiche.
Implicazioni:
- Sovraccarico informativo: difficoltà nel processare e gerarchizzare la quantità di informazioni disponibili.
- Frammentazione dell’attenzione: erosione della capacità di concentrazione prolungata.
- Costruzione algoritmica della realtà: i contenuti che riceviamo sono sempre più personalizzati da algoritmi, creando “bolle informative” che rinforzano pregiudizi esistenti.
3.4.4 Dinamiche di genere e biotecnologie
Questa dimensione comprende due fenomeni interconnessi:
Ridefinizione delle dinamiche di genere:
- Evoluzione culturale: i movimenti femministi, LGBTQ+, e gli studi di genere hanno messo in discussione i tradizionali ruoli sociali associati al genere biologico.
- Evoluzione demografica: cambiamenti nei tassi di natalità, strutture familiari, partecipazione femminile al lavoro.
- Identità di genere: crescente riconoscimento di identità non binarie, fluide, che trascendono la dicotomia maschio-femmina.
Biotecnologie:
- Sviluppo tecnologico: ingegneria genetica, medicina riproduttiva (fecondazione assistita, utero artificiale), terapie geniche, editing genetico (CRISPR).
- Sfide etiche: questioni sulla manipolazione del genoma umano, eugenetica, definizione di “naturale” vs. “artificiale”, diritti riproduttivi.
- Modificazione della percezione del corpo: il corpo non è più dato biologico immutabile, ma può essere tecnologicamente modificato (chirurgia estetica, protesi, terapie ormonali per transizione di genere).
- Ridefinizione della vita: questioni su quando inizia e finisce la vita, statuto dell’embrione, morte cerebrale vs. morte biologica.
3.4.5 Transumanesimo
Transumanesimo è un movimento intellettuale e culturale che promuove l’uso delle tecnologie per superare i limiti biologici umani, migliorando capacità fisiche, cognitive e emotive, e potenzialmente estendendo la durata della vita o raggiungendo l’immortalità.
Prospettive transumaniste:
- Potenziamento cognitivo: farmaci nootropi, interfacce cervello-computer, intelligenza artificiale integrata.
- Potenziamento fisico: esoscheletri, organi artificiali, nanotecnologie mediche.
- Estensione della vita: terapie anti-invecchiamento, crionica.
- Upload mentale: ipotetica trasferimento della coscienza su supporti digitali.
Interrogativi profondi:
- Identità: cosa significa essere umani se superiamo i limiti tradizionali della specie?
- Disuguaglianza: chi avrà accesso a questi potenziamenti? Rischio di una “biforcazione” dell’umanità tra potenziati e non potenziati.
- Etica: è moralmente accettabile modificare radicalmente la natura umana?
- Futuro della specie: verso quale forma di esistenza ci stiamo dirigendo?
3.4.6 Percezione del rischio e ansia sociale
La percezione del rischio è la valutazione soggettiva della probabilità e gravità di minacce, che può divergere significativamente dai rischi oggettivi misurati statisticamente.
Fenomeni amplificatori:
- Eventi globali: pandemie (COVID-19), cambiamenti climatici (eventi meteorologici estremi), instabilità economica (crisi finanziarie), conflitti geopolitici.
- Amplificazione mediatica: la copertura continua e spettacolarizzata di eventi catastrofici aumenta la percezione di vulnerabilità.
- Complessità sistemica: l’interdipendenza dei sistemi globali rende difficile prevedere e controllare i rischi, generando sensazione di impotenza.
Ansia sociale è una condizione di ansia diffusa e incertezza pervasiva che caratterizza la società contemporanea.
Effetti sui comportamenti:
- Individuali: aumento di disturbi d’ansia, depressione, comportamenti di evitamento, consumismo compensativo.
- Collettivi: polarizzazione politica, ricerca di capri espiatori, fascino per soluzioni autoritarie promettenti sicurezza, movimenti negazionisti o complottisti come meccanismo di riduzione della complessità.
4. L’emergere della sociurgia come categoria interpretativa
4.1 Trasformazione del medium dell’opera
Nel contesto della rivoluzione antropologica, il medium in cui si muove l’opera subisce una trasformazione radicale:
- Non più prettamente artistico: l’opera non è più definita esclusivamente dalle convenzioni e istituzioni del mondo dell’arte tradizionale.
- Non più prettamente sociale: sebbene abbia sempre avuto una dimensione sociale, ora questa diventa costitutiva piuttosto che accessoria.
- Ibrido e liquido: il nuovo medium è fluido, attraversa confini disciplinari, integra arte, psicologia, sociologia, terapia, attivismo.
4.2 Superamento dell’opera d’arte come valore-limite
- L’opera d’arte non è più il valore: il conseguimento dello status di “capolavoro” riconosciuto storicamente non è più l’obiettivo primario.
- L’opera d’arte non è più il limite: non costituisce più il confine aspirazionale dell’attività artistica.
- Estensione della ricerca di senso: la ricerca di significato attraverso l’espressione artistica, innata nell’uomo (radicata nella natura umana come bisogno antropologico fondamentale), si estende oltre i confini tradizionali dell’arte.
4.3 Dal livello intrapsichico al livello sociale
Questa estensione comporta un passaggio cruciale:
- Livello intrapsichico: dimensione interna, individuale, della psiche (emozioni, pensieri, conflitti inconsci, processi creativi personali).
- Livello sociale: dimensione collettiva, relazionale, delle interazioni tra individui, gruppi, comunità, istituzioni.
L’opera non è più concepita solo come espressione dell’interiorità dell’artista o come esperienza estetica privata del fruitore, ma come intervento nel tessuto sociale, con funzioni che possono includere:
- Terapia collettiva: elaborazione di traumi sociali, conflitti comunitari.
- Costruzione di identità: definizione di appartenenze, narrazioni condivise.
- Critica sociale: denuncia di ingiustizie, mobilitazione per il cambiamento.
- Creazione di spazi relazionali: facilitazione di incontri, dialoghi, esperienze condivise.
4.4 Sociurgia: definizione e funzione
Sociurgia (dal latino societas, “società”, e dal greco érgon, “opera, azione”) è il termine che designa questa nuova categoria interpretativa.
Per analogia con:
- Sociatria (iatrós = medico): cura della società.
- Sociurgia (érgon = opera): operazione, azione trasformativa sulla società.
La sociurgia indica:
- Pratiche artistico-sociali: attività che integrano linguaggi artistici con finalità di intervento sociale.
- Paradigma interpretativo: categoria teorica per comprendere fenomeni contemporanei in cui arte e azione sociale convergono.
- Strumento analitico: framework per analizzare opere, progetti, movimenti che trascendono i confini tradizionali dell’arte.
4.5 Essenzialità delle nuove categorie
Sociurgia (e prima sociatria) “diventano essenziali” per:
- Affrontare i fenomeni contemporanei: comprendere pratiche artistiche che non si esauriscono nelle categorie estetiche tradizionali (arte partecipativa, arte relazionale, community art, artivismo).
- Interpretare fenomeni riferibili all’arte: il testo specifica “almeno quelli riferibili all’arte”, riconoscendo che non tutti i fenomeni sociali contemporanei possono essere letti attraverso queste categorie, ma per quelli che hanno una componente artistica o espressiva, esse sono indispensabili.
- Colmare il vuoto teorico: fornire strumenti concettuali adeguati alla complessità e alla natura ibrida delle pratiche contemporanee, superando l’inadeguatezza delle tradizionali categorie critiche (belle arti, avanguardie, postmodernismo).
5. Approfondimenti teorici e implicazioni epistemologiche
5.1 La dissoluzione dei confini disciplinari
La nascita della sociurgia segnala un fenomeno più ampio: la dissoluzione dei confini disciplinari che caratterizzavano la modernità solida.
5.1.1 Specializzazione moderna vs. ibridazione postmoderna
Nella modernità solida, il sapere era organizzato in discipline separate, ciascuna con:
- Oggetto di studio definito: l’arte studiava il bello e le opere estetiche; la psicologia la psiche individuale; la sociologia le strutture sociali.
- Metodologie specifiche: tecniche di indagine proprie e non trasferibili.
- Comunità professionali distinte: artisti, psicologi, sociologi operavano in ambiti separati con scarsa comunicazione interdisciplinare.
Nella modernità liquida, emerge invece una tendenza all’ibridazione:
- Contaminazione metodologica: le pratiche artistiche incorporano metodi delle scienze sociali (ricerca sul campo, interviste, statistiche); le scienze sociali utilizzano forme espressive artistiche (etnografia visuale, sociologia performativa).
- Oggetti di studio transizionali: fenomeni che non appartengono interamente a nessuna disciplina tradizionale, ma si collocano nelle zone di confine.
- Figure professionali ibride: operatori che non sono né puri artisti né puri operatori sociali, ma integrano competenze multiple (arteterapeuti, facilitatori culturali, ricercatori-artisti).
5.2 La sociurgia nel panorama delle pratiche artistiche contemporanee
Per comprendere pienamente la sociurgia, è utile collocarla nel contesto di movimenti e concetti affini emersi dalla fine del XX secolo.
5.2.1 Arte relazionale (Nicolas Bourriaud)
Nicolas Bourriaud, critico d’arte francese, nel 1998 pubblica Esthétique relationnelle (Estetica relazionale), introducendo il concetto di arte relazionale.
Definizione: arte che prende come orizzonte teorico la sfera delle relazioni umane e il suo contesto sociale, piuttosto che uno spazio simbolico autonomo e privato.
Caratteristiche:
- L’opera come situazione: l’opera d’arte non è più un oggetto ma una situazione, un evento, un contesto relazionale.
- Intersoggettività: l’enfasi è posta sulle interazioni tra le persone che partecipano all’esperienza artistica.
- Estetica dell’incontro: il valore estetico risiede nella qualità delle relazioni che si generano.
Esempi: opere di Rirkrit Tiravanija (che organizza cene collettive nelle gallerie), Philippe Parreno, Liam Gillick.
Relazione con la sociurgia: l’arte relazionale anticipa alcuni aspetti della sociurgia, ma rimane ancorata al contesto istituzionale dell’arte (gallerie, musei, biennali). La sociurgia radicalizza questa prospettiva estendendola esplicitamente alla dimensione terapeutica e di trasformazione sociale.
5.2.2 Estetica dialogica (Grant Kester)
Grant Kester, teorico americano, nel 2004 pubblica Conversation Pieces, elaborando il concetto di estetica dialogica.
Definizione: forma d’arte basata sul dialogo esteso e collaborativo tra artisti e comunità, che privilegia l’ascolto, la negoziazione, il processo collaborativo rispetto al prodotto finale.
Caratteristiche:
- Processo vs. prodotto: l’accento si sposta dall’oggetto artistico concluso al processo di interazione che lo genera.
- Collaborazione autentica: gli artisti non impongono una visione ma co-creano significati con le comunità coinvolte.
- Empatia e comprensione reciproca: obiettivo principale è costruire ponti tra soggetti con esperienze e prospettive diverse.
Esempi: progetti di Suzanne Lacy, WochenKlausur, Group Material.
Relazione con la sociurgia: l’estetica dialogica condivide con la sociurgia l’enfasi sul processo e sulla dimensione collettiva, ma la sociurgia esplicita maggiormente la componente terapeutica (derivata dalla sociatria) e la funzione di “operazione” trasformativa sulla società.
5.2.3 Arte partecipativa e socially engaged art
Arte partecipativa indica pratiche in cui il pubblico non è passivo fruitore ma attivo co-creatore dell’opera.
Socially engaged art (arte socialmente impegnata) designa pratiche artistiche orientate verso questioni sociali, politiche, ambientali, spesso in collaborazione con comunità specifiche.
Caratteristiche comuni:
- Dematerializzazione dell’opera: riduzione dell’importanza dell’oggetto artistico fisico.
- Contesti extra-istituzionali: operano frequentemente fuori dai tradizionali spazi dell’arte (spazi pubblici, quartieri periferici, contesti marginali).
- Intenzionalità sociale: aspirazione a produrre cambiamenti concreti nelle comunità, non solo esperienze estetiche.
Esempi: Theaster Gates (rigenerazione urbana attraverso l’arte), Tania Bruguera (concetto di “Arte Útil”, arte utile), Rick Lowe (Project Row Houses).
Relazione con la sociurgia: queste pratiche costituiscono il terreno empirico su cui la sociurgia opera come categoria interpretativa. La sociurgia non è tanto una pratica specifica quanto un framework teorico che permette di leggere e comprendere queste diverse manifestazioni in modo unitario, evidenziando la loro comune radice nella crisi delle funzioni tradizionali dell’arte e nella convergenza tra espressione artistica e intervento sociale.
5.3 Differenze tra sociatria e sociurgia
Benché strettamente connesse, sociatria e sociurgia presentano sfumature distintive:
5.3.1 Sociatria
- Etimologia: societas + iatrós (medico).
- Paradigma: medico-terapeutico.
- Presupposto: la società è “malata” e necessita di cura.
- Funzione: diagnosticare patologie sociali e intervenire terapeuticamente.
- Modello: relazione asimmetrica terapeuta-paziente (anche se Moreno enfatizza la co-creazione).
- Ambito originario: psicoterapia di gruppo, psicodramma, interventi psicosociali strutturati.
5.3.2 Sociurgia
- Etimologia: societas + érgon (opera, azione).
- Paradigma: operativo-trasformativo.
- Presupposto: la società è un campo di forze in continua trasformazione che può essere modellato attraverso azioni intenzionali.
- Funzione: operare trasformazioni nel tessuto sociale attraverso pratiche artistico-espressive.
- Modello: relazione orizzontale, co-creazione, empowerment.
- Ambito: pratiche artistiche contemporanee con dimensione sociale, interventi culturali, progetti comunitari.
Sintesi: la sociatria ha un’impronta più clinica e terapeutica; la sociurgia un’impronta più estetico-politica e trasformativa. La sociurgia eredita dalla sociatria la consapevolezza del potere terapeutico dell’espressione artistica, ma lo estende oltre il contesto clinico verso la dimensione della trasformazione sociale collettiva.
5.4 Funzioni della sociurgia nell’era della rivoluzione antropologica
Nell’attuale contesto di rivoluzione antropologica, la sociurgia può assolvere diverse funzioni complementari:
5.4.1 Funzione elaborativa
Elaborazione (dal latino elaborare, “lavorare intensamente”) indica il processo psicologico e sociale attraverso cui esperienze traumatiche, conflitti, transizioni vengono metabolizzate, integrate, dotate di senso.
La sociurgia opera come dispositivo di elaborazione collettiva di:
- Traumi storici: genocidi, guerre, migrazioni forzate, colonialismo.
- Transizioni epocali: le sei dimensioni della rivoluzione antropologica (globalizzazione, crisi ecologica, ipermediatizzazione, ecc.).
- Conflitti comunitari: tensioni etniche, economiche, generazionali all’interno di comunità specifiche.
Modalità:
- Creazione di spazi simbolici dove il trauma può essere rappresentato senza essere rivissuto traumaticamente.
- Costruzione di narrazioni collettive che integrano memoria e prospettiva futura.
- Rituali laici che sostituiscono i riti religiosi tradizionali nella marcatura di passaggi esistenziali.
5.4.2 Funzione rigenerativa
Rigenerazione (da re-generare, “generare nuovamente”) indica il processo di rinnovamento, rivitalizzazione, ricostruzione.
La sociurgia opera rigenerazione su diversi piani:
- Tessuto sociale: ricostruzione di legami comunitari in contesti di frammentazione e atomizzazione.
- Spazi urbani: trasformazione di luoghi degradati o abbandonati in spazi di aggregazione e significato (rigenerazione urbana attraverso l’arte).
- Immaginari collettivi: rinnovamento delle narrazioni, simboli, rappresentazioni che una comunità ha di sé.
- Soggettività: empowerment degli individui, recupero di agency (capacità di azione) in contesti di marginalizzazione.
Questa funzione riprende e amplifica la funzione catartica tradizionale, estendendola dal piano individuale a quello collettivo.
5.4.3 Funzione conoscitiva
La sociurgia può generare forme di conoscenza situata, incarnata, collettiva, che complementano la conoscenza scientifica astratta.
Modalità cognitive specifiche:
- Conoscenza incarnata (embodied knowledge): sapere che passa attraverso il corpo, le emozioni, l’esperienza sensibile, non riducibile a proposizioni verbali.
- Conoscenza tacita (Michael Polanyi): sapere implicito, non formalizzabile, che emerge dalla pratica condivisa.
- Intelligenza collettiva: capacità di un gruppo di risolvere problemi e generare innovazione attraverso la collaborazione, superiore alla somma delle intelligenze individuali.
Epistemologia alternativa: La sociurgia propone implicitamente un’epistemologia che riconosce validità a forme di conoscenza tradizionalmente escluse dal paradigma scientifico positivista, allineandosi con tendenze contemporanee come la ricerca artistica (artistic research) e la ricerca basata sulla pratica (practice-based research).
5.4.4 Funzione prefigurativa
Prefigurazione indica la pratica di creare nel presente istanze, relazioni, modalità operative che anticipano la società futura desiderata.
Il concetto, elaborato in sociologia dei movimenti sociali, si applica alla sociurgia nel senso che:
- Prototipi sociali: i progetti socio-artistici funzionano come laboratori sperimentali di forme di convivenza, organizzazione, relazionalità alternative a quelle dominanti.
- Dimostrazione di possibilità: rendono tangibili e sperimentabili configurazioni sociali che altrimenti rimarrebbero astratte utopie.
- Pedagogia dell’alternativa: educano i partecipanti a immaginare e costruire realtà diverse, contrastando il realismo capitalistico (Mark Fisher), ossia l’incapacità di concepire alternative al sistema attuale.
5.4.5 Funzione di mediazione simbolica
In un contesto di frammentazione dei linguaggi e delle comunità, la sociurgia può operare come mediatore simbolico, costruendo ponti tra:
- Differenti codici culturali: migranti e nativi, generazioni diverse, subculture.
- Saperi specialistici e senso comune: traducendo conoscenze tecniche in forme accessibili e significative.
- Passato e futuro: reinterpretando tradizioni in chiave contemporanea, costruendo continuità identitarie in contesti di rapido cambiamento.
6. Problematizzazioni critiche e limiti
Una trattazione scientificamente rigorosa deve riconoscere anche le problematiche e i limiti del costrutto della sociurgia.
6.1 Rischio di strumentalizzazione
La convergenza tra arte e funzioni sociali apre al rischio di strumentalizzazione:
- Subordinazione dell’arte: l’arte diventa mero strumento per fini esterni (terapia, coesione sociale, politiche pubbliche), perdendo la propria specificità e autonomia.
- Gentrificazione culturale: progetti artistici in quartieri degradati possono involontariamente innescare processi di gentrificazione, espellendo proprio le comunità che dovrebbero beneficiarne.
- Cooptazione istituzionale: la sociurgia può essere incorporata da istituzioni pubbliche o private come forma di controllo sociale soft, pacificazione dei conflitti senza affrontare le cause strutturali.
6.2 Ambiguità dei criteri di valutazione
Se l’opera non aspira più allo status di opera d’arte, quali criteri di valutazione si applicano?
- Efficacia sociale vs. qualità estetica: un progetto sociurgico di successo sociale può essere esteticamente banale? Viceversa, un progetto esteticamente sofisticato ma inefficace socialmente è valido?
- Misurabilità degli impatti: come si valuta se un intervento ha “rigenerato il tessuto sociale” o “elaborato un trauma collettivo”? Rischio di vaghezza e autolegittimazione acritica.
- Pluralità di stakeholder: artisti, comunità, committenti, critici possono avere criteri di valutazione radicalmente divergenti.
6.3 Tensione tra processo e documentazione
Le pratiche sociurgiche enfatizzano il processo, l’esperienza vissuta, la dimensione temporale. Questo crea problemi di:
- Documentazione: come si documenta un’esperienza relazionale senza tradirne la natura? Le fotografie, i video, le descrizioni testuali sono sempre rappresentazioni parziali e mediate.
- Trasmissione storica: se l’opera è l’esperienza vissuta dai partecipanti, cosa resta per le generazioni future? Rischio di irrilevanza storica.
- Legittimazione istituzionale: le istituzioni dell’arte (musei, mercato) faticano a integrare pratiche che per natura resistono all’oggettificazione e alla mercificazione.
6.4 Questioni di competenza e formazione
Le figure che operano nella sociurgia necessitano di competenze multiple:
- Artistiche: capacità espressive, creative, tecniche specifiche.
- Psicologiche: comprensione delle dinamiche di gruppo, capacità di ascolto, gestione delle emozioni.
- Sociologiche: analisi dei contesti, comprensione delle strutture sociali, sensibilità alle differenze culturali.
- Etiche: consapevolezza delle implicazioni etiche del lavorare con comunità vulnerabili, rispetto dell’autonomia dei partecipanti.
Problemi:
- Superficialità: rischio di dilettantismo in ambiti che richiederebbero competenze professionali specifiche (ad esempio, lavorare con persone traumatizzate senza adeguata formazione psicologica).
- Mancanza di percorsi formativi: carenza di istituzioni che formino specificamente figure con questo profilo ibrido.
6.5 Limiti della generalizzabilità
Il concetto di sociurgia, elaborato principalmente in riferimento alle arti visive e performative occidentali contemporanee, può avere limiti di applicabilità:
- Specificità culturale: pratiche artistico-sociali in contesti non occidentali possono non riconoscersi in questa categoria, avendo genealogie e concettualizzazioni proprie.
- Specificità disciplinare: quanto la sociurgia è applicabile ad altre forme artistiche (musica, letteratura, cinema)? Richiede adattamenti concettuali?
- Limiti storici: la sociurgia è categoria specificamente contemporanea o può retroattivamente interpretare pratiche passate (ad esempio, il teatro politico degli anni ’60-’70, l’arte murale messicana)?
7. Prospettive future e sviluppi necessari
7.1 Necessità di una teoria sistematica
Il presente testo ha “funzioni introduttive ad una più completa trattazione sistematica”. Una teoria compiuta della sociurgia dovrebbe sviluppare:
7.1.1 Ontologia
Definizione chiara dello statuto ontologico dell’opera sociurgica:
- Cosa è: evento, processo, relazione, dispositivo, ecosistema?
- Dove esiste: nello spazio fisico, nelle relazioni tra persone, nella memoria collettiva, nei documenti?
- Quanto dura: il tempo dell’evento, gli effetti prolungati, la memoria storica?
7.1.2 Epistemologia
Elaborazione di un’epistemologia specifica:
- Quali forme di conoscenza genera la sociurgia?
- Come si validano queste conoscenze (se non attraverso i criteri tradizionali della scienza o dell’arte)?
- Quale rapporto con altre forme di sapere (scientifico, esperienziale, tradizionale)?
7.1.3 Metodologia
Sviluppo di metodologie operative:
- Framework progettuali: modelli per progettare, implementare, valutare interventi sociurgici.
- Strumenti di ricerca: metodi di indagine qualitativa e quantitativa appropriati alla natura delle pratiche.
- Protocolli etici: linee guida per operare responsabilmente con comunità, soprattutto in condizioni di vulnerabilità.
7.1.4 Assiologia
Esplicitazione dei valori e criteri di valutazione:
- Quali valori la sociurgia promuove (emancipazione, inclusione, creatività, etc.)?
- Come si valuta il successo o il fallimento di un intervento?
- Quali principi etici guidano la pratica?
7.2 Dialogo interdisciplinare
Lo sviluppo della sociurgia richiede dialogo costante con:
- Psicologia: approfondimento delle dinamiche catartiche, terapeutiche, trasformative.
- Sociologia: analisi delle strutture sociali, dei movimenti, delle dinamiche di potere.
- Antropologia: comprensione della diversità culturale, dei sistemi simbolici, dei rituali.
- Filosofia: riflessione sui fondamenti ontologici, epistemologici, etici.
- Studi urbani e territoriali: per progetti di rigenerazione spaziale.
- Pedagogia: per la dimensione educativa e formativa della sociurgia.
- Studi sui media: per comprendere l’ipermediatizzazione e le sue implicazioni.
7.3 Costruzione di reti e istituzioni
Per consolidarsi come campo, la sociurgia necessita di:
- Reti di pratiche: connessioni tra operatori, scambio di esperienze, piattaforme di documentazione.
- Percorsi formativi: corsi universitari, master, workshop specializzati.
- Spazi di legittimazione: riviste, convegni, premi che riconoscano specificamente questo ambito.
- Finanziamenti dedicati: linee di finanziamento pubblico e privato che riconoscano la specificità della sociurgia rispetto sia all’arte tradizionale sia al lavoro sociale convenzionale.
7.4 Ricerca empirica
Necessità di ricerche empiriche rigorose:
- Studi di caso: analisi approfondite di progetti sociurgici specifici.
- Studi comparativi: confronto tra diversi approcci, contesti, esiti.
- Valutazione d’impatto: sviluppo di metodologie per valutare gli effetti a breve, medio e lungo termine.
- Ricerca partecipativa: coinvolgimento delle comunità come co-ricercatori.
7.5 Consapevolezza dei limiti e umiltà epistemologica
Lo sviluppo futuro della sociurgia dovrebbe mantenere:
- Consapevolezza critica: riconoscimento continuo dei propri limiti, contraddizioni, rischi.
- Apertura al fallimento: accettazione che non tutti gli interventi saranno efficaci, con capacità di apprendere dagli insuccessi.
- Resistenza alla reificazione: evitare che la sociurgia si cristallizzi in formule, ricette, ortodossie, mantenendo flessibilità e apertura sperimentale.
- Umiltà nei confronti delle comunità: riconoscimento che le comunità hanno proprie risorse, saperi, capacità di agency, e che l’intervento sociurgico non porta “salvezza” dall’esterno ma facilita processi endogeni.
8. Conclusioni: la sociurgia come risposta alla crisi e come orizzonte di senso
8.1 Ricapitolazione del percorso argomentativo
Il percorso delineato può essere sintetizzato nei seguenti passaggi logici:
- Struttura originaria: per 40.000 anni, l’opera artistica si fonda su quattro funzioni (catarsi, estetica, rappresentazione, evocazione).
- Crisi storica: metà XIX secolo, la società moderna e la fotografia compromettono le funzioni rappresentativa ed evocativa.
- Reazione delle avanguardie: tentativi di ridefinire l’arte attraverso emancipazione dal dato reale e concettualizzazione, con esiti contraddittori e frammentari.
- Potenziamento catartico: parallelo emergere della psicologia e valorizzazione della funzione terapeutica dell’arte (sociatria di Moreno).
- Rivoluzione antropologica: la modernità liquida e le sei dimensioni del mutamento globale ridefiniscono radicalmente il contesto.
- Trasformazione del medium: l’opera non si muove più in un medium prettamente artistico ma in uno spazio ibrido artistico-sociale.
- Emergere della sociurgia: nuova categoria interpretativa che estende la ricerca di senso attraverso l’arte dal livello intrapsichico a quello sociale, assolvendo funzioni elaborative, rigenerative, conoscitive, prefigurative, di mediazione simbolica.
8.2 La sociurgia come sintomo e come risposta
La sociurgia può essere letta in duplice chiave:
Come sintomo: la sociurgia è manifestazione della crisi profonda delle istituzioni e dei linguaggi tradizionali (arte, religione, politica, comunità). Emerge perché questi sistemi non assolvono più adeguatamente alle funzioni di costruzione di senso, coesione sociale, elaborazione dell’esperienza collettiva. In questo senso, testimonia una mancanza, un vuoto che cerca di colmare.
Come risposta: simultaneamente, la sociurgia costituisce un tentativo creativo di adattamento alla nuova condizione antropologica. Non restaura nostalgicamente le strutture perdute, ma elabora nuove forme, pratiche, linguaggi adeguati alla complessità e alla liquidità contemporanee.
8.3 L’irriducibilità del bisogno espressivo-simbolico
Il testo afferma che la “ricerca di senso attraverso l’arte” è “innata nell’uomo”. Questa affermazione, benché non empiricamente dimostrabile in senso stretto, si fonda su evidenze antropologiche convergenti:
- Universalità: tutte le culture umane conosciute producono forme espressive simboliche (arte visiva, musica, danza, narrazione).
- Precocità: i bambini manifestano spontaneamente comportamenti creativi ed espressivi.
- Persistenza: nonostante rivoluzioni tecnologiche e sociali, il bisogno di espressione artistica persiste.
Questo suggerisce che l’espressione simbolica-artistica risponde a bisogni antropologici profondi:
- Costruzione di significato: dare senso all’esperienza, elaborare il caos in cosmos.
- Comunicazione di stati interiori: esprimere emozioni, visioni, esperienze non riducibili al linguaggio proposizionale.
- Costruzione di legami: creare identità collettive, appartenenze, memorie condivise.
- Esplorazione delle possibilità: immaginare alternative al dato, espandere l’orizzonte del possibile.
La sociurgia riconosce questa irriducibilità e la onora estendendone l’ambito di operatività.
8.4 Orizzonte di senso nella frammentazione
In un’epoca caratterizzata da:
- Frammentazione dei linguaggi (proliferazione di codici artistici non comunicanti).
- Crisi delle grandi narrazioni (fine delle ideologie totalizzanti, delle utopie).
- Individualizzazione estrema (atomizzazione sociale, erosione delle comunità tradizionali).
- Ansia pervasiva (percezione diffusa di rischio e incertezza).
La sociurgia offre un potenziale orizzonte di senso non attraverso:
- Nuove ortodossie: non propone un nuovo canone estetico universale.
- Nuove certezze ideologiche: non promette soluzioni totali ai problemi sociali.
- Restaurazione del passato: non cerca di ripristinare le funzioni perdute dell’arte tradizionale.
Ma attraverso:
- Pratica situata: interventi contestuali, adattati a specifiche comunità e problematiche.
- Costruzione processuale: elaborazione collettiva di significati attraverso la partecipazione.
- Riconnessione: tessere legami tra individui, tra passato e presente, tra emozione e razionalità.
- Embodiment: valorizzazione dell’esperienza incarnata contro la virtualizzazione della vita.
- Agency collettiva: riconoscimento che i soggetti possono intervenire attivamente nella costruzione della realtà sociale.
8.5 Considerazione finale: la sociurgia tra utopia e realismo
La sociurgia oscilla necessariamente tra tensione utopica e pragmatismo realista:
Dimensione utopica:
- Aspira a trasformare la società, a rigenerare comunità, a curare ferite collettive.
- Immagina forme di convivenza alternative, più autentiche, eque, creative.
- Rivendica il potere trasformativo dell’espressione artistica.
Dimensione realista:
- Opera con risorse limitate, in contesti strutturalmente condizionati da rapporti di potere.
- Riconosce la parzialità e la fragilità dei propri interventi.
- Accetta la complessità irriducibile dei fenomeni sociali e l’impossibilità di soluzioni definitive.
La produttività teorica e pratica della sociurgia risiede probabilmente nella capacità di mantenere questa tensione senza risolverla, operando negli interstizi tra aspirazione e concretezza, tra arte e vita, tra individuale e collettivo, tra espressione e azione.
Bibliografia essenziale (per approfondimenti)
Fondamenti filosofico-estetici:
- Aristotele, Poetica
- Kant, I., Critica del Giudizio
- Benjamin, W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica
- Adorno, T.W., Teoria estetica
Sociologia e modernità:
- Bauman, Z., Modernità liquida
- Marx, K., Il Manifesto del Partito Comunista (per il concetto di dissoluzione)
- Giddens, A., Le conseguenze della modernità
Psicologia e sociatria:
- Moreno, J.L., Manuale di psicodramma
- Freud, S., L’interpretazione dei sogni (per i fondamenti della psicoanalisi)
Arte contemporanea e teorie sociali:
- Bourriaud, N., Estetica relazionale
- Kester, G., Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art
- Bishop, C., Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship
Antropocene e critica ecologica:
- Moore, J.W., Anthropocene or Capitalocene?
- Crutzen, P., “Geology of Mankind” (articolo fondativo sull’Antropocene)
Transumanesimo:
- Bostrom, N., “A History of Transhumanist Thought”
Questa trattazione ha cercato di mantenere il rigore scientifico richiesto, definendo ogni concetto introdotto, esplicitando i passaggi argomentativi, contestualizzando storicamente e teoricamente i fenomeni descritti. La sociurgia emerge come categoria interpretativa necessaria per comprendere le trasformazioni dell’opera artistica nel contesto della rivoluzione antropologica contemporanea, proponendosi come sintesi tra l’eredità catartica della sociatria e le esigenze di intervento trasformativo sulla società.