Podcast: Apple Podcasts | RSS
(voce di Luca Grandelis)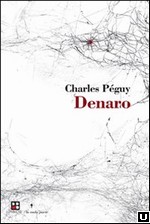
Charles Péguy, Denaro, traduzione di Martina Grassi, collana «La mala parte» n° 13, Piano B Edizioni, Prato 2011, pp. 94, € 10,00. ISBN: 8896665299
Strano, questo libro.
Péguy lo scrisse l’anno prima di morire (verrà ucciso il 5 settembre 1914 a Villeroy, nel primo giorno della battaglia della Marna, partito quarantunenne volontario), in un periodo fecondo ma anche di grande isolamento dal mondo intellettuale francese. Apparve su i «Cahiers de la Quinzaine», la rivista della quale era fondatore, editore e factotum. E apparve come «prefazione» del saggio Depuis 1880. L’enseignement primaire et ce qu’il devrait être, che sarebbe stato pubblicato sul fascicolo successivo. L’autore: Théophile Naudy. Lo stesso che, molti anni prima – come direttore della Scuola Normale per maestri di Loiret, cui era annessa la scuola elementare frequentata dal giovane Péguy – ebbe fiducia nell’intelligenza e dedizione del piccolo e povero Charles e convinse sua madre a fargli frequentare il liceo, ottenendogli una borsa di studio. Uno di quei particolari «incroci», capaci di determinare l’esito di una vita. «Per me fu maestro e padre [ […]] l’uomo al quale devo di più» (Péguy era rimasto orfano di padre a soli dieci mesi).
Ora il poeta e saggista francese ne pubblicava una riflessione generale sulla scuola, frutto di trent’anni di lavoro sul campo.
Strano, questo libro. Il titolo inganna: del denaro si parla solo tangenzialmente. Neanche del saggio di Naudy entra troppo in merito. Piuttosto si tratta di una straordinaria riflessione sulla modernità, su quello che eravamo e su ciò che siamo divenuti. Con vivacità e grande forza (qualcuno lo considera l’apice stilistico e concettuale di tutta l’opera di Péguy), alternando il registro autobiografico a quello saggistico, lo scrittore francese descrive con sconcertante chiarezza lo sfaldarsi della società tradizionale in un passaggio epocale nella cultura e nella civiltà europea; un’analisi che nella nostra società post-moderna mantiene tutta la sua attualità preveggente.
«Si potrà anche non crederlo, ma noi siamo cresciuti in mezzo a un popolo allegro. A quei tempi, un cantiere era un luogo della terra in cui gli uomini erano felici [ […]]. Non si guadagnava quasi nulla. Non si ha neppure idea di quanto fossero bassi i salari. Eppure tutti mangiavano [ […]]. Non si facevano i conti. E non c’era bisogno di contare. Ma si potevano crescere i figli. E se ne crescevano. [ […]] Lo si creda o no, fa lo stesso, abbiamo conosciuto operai che avevano voglia di lavorare [ […]]. C’era un onore incredibile, nel lavoro, il più bello degli onori, il più cristiano. [ […]] Abbiamo conosciuto questo amore per il lavoro ben fatto che si spingeva, si manteneva fino alla più estrema esigenza. Durante tutta la mia infanzia ho visto impagliare sedie [era il mestiere che prese a fare sua madre, rimasta vedova, per mantenere i figli. NdR], esattamente con lo stesso spirito, con lo stesso cuore e con la stessa mano con i quali quel popolo aveva innalzato le proprie cattedrali» (pp. 18-20).
Poi era avvenuto un cambiamento epocale, che da tempo la demagogia intellettuale borghese andava preparando. E così si è iniziato a trattare il lavoro umano come un valore di borsa. E il lavoratore, da libero che era benché povero, è diventato uno schiavo. Prima, «quando un operaio accendeva una sigaretta, quello che stava per dire non era quello che aveva letto sul giornale del mattino» (p. 17).
un cambiamento epocale, che da tempo la demagogia intellettuale borghese andava preparando. E così si è iniziato a trattare il lavoro umano come un valore di borsa. E il lavoratore, da libero che era benché povero, è diventato uno schiavo. Prima, «quando un operaio accendeva una sigaretta, quello che stava per dire non era quello che aveva letto sul giornale del mattino» (p. 17).
Di questo meraviglioso suo popolo, i migliori – sostiene Péguy – erano i maestri elementari. Anche se erano le scuole della laicizzazione. Charles rievoca con dolcezza i suoi insegnanti, l’affetto e la fiducia ricevuti. Ben diverso il clima universitario, fatto di docenti inaciditi, rancorosi: «Dovevo arrivare alla Sorbona per conoscere, per scoprire, con ingenuo stupore, cosa sia un maestro che nutre rancore verso i propri allievi, che si consuma d’invidia e di gelosia, dal bisogno di esercitare un dominio tirannico» (pp. 53-54). Le ultime pagine del saggio sono occupate da una feroce polemica letteraria contro uno di loro, lo storico Charles-Victor Langlois, che di questa categoria sembra fosse un eminente esponente.
Ma, tornando ai maestri e agli insegnanti, Péguy accenna a un progetto di riforma (evidentemente discusso nel saggio che presenta). Alla profonda crisi dell’istruzione francese. E, alieno da intellettualismi, invita: «Facciano dunque scuola, non c’è niente di più bello al mondo. Che non si sbaglino: fanno il più bel mestiere del mondo. Solo loro hanno allievi» (p. 59). E lo ripete: «E dunque, è come dire che il più bel mestiere del mondo, dopo il mestiere del genitore (e d’altronde è il mestiere più simile a quello di genitore) è il maestro di scuola» (p. 60).
Anche, e forse soprattutto, su questo tema il Péguy di un secolo fa ha molto da dire alla nostra società, figlia della sua, anche se così diversa.





