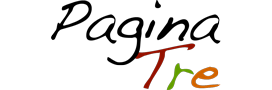È veramente un dispiacere che di Gaetano Barbieri (1767 o 1775 – 1853) si sia trovato solo questo testo, questa novella storica. L’opera, databile al 1837, è di una straordinaria modernità, non solo per la forma letteraria (comunque tenendo conto dei quasi due secoli trascorsi e quindi la presenza a volte di termini desueti, es. armatetta come flottiglia, palischermo come barca o scialuppa), ma anche e soprattutto per la definizione delle situazioni e dei personaggi.
Nel testo Barbieri cita Gli ultimi giorni di Pompei di Bulwer Lytton e il Guido Mannering di Walter Scott, che confermano le sue molte letture e soprattutto, come indicato nella biografia, la sua appassionata attività di traduttore.
Federico d’Aragona, che regnava su Napoli, è morto da una manciata di anni e la popolazione ancora lo rimpiange. Il regno è governato ora – e lo sarà fino alla fine della Guerra di Successione spagnola nel 1713 – da viceré sotto il controllo diretto dei reali di Spagna. Ferdinando il Cattolico, Re di Napoli e di Sicilia dopo Federico, nomina viceré, con gli stessi poteri del re, Gonzalo Fernández de Córdoba (nella novella di Barbieri Gonzalvo di Cordova), fino ad allora Gran Capitano dell’esercito napoletano, uomo per fortuna di gran valore, saggezza e rettitudine. Qui, se non erro, è una piccola imprecisione dell’autore che considera, nel 1510, anno in cui è collocata la vicenda, il viceré Gozalo ancora in carica quando in realtà il suo incarico a Napoli era terminato nel 1506.
Nella novella entrano temi come l’Inquisizione, l’amministrazione della Giustizia e il brigantaggio. Sappiamo, e Barbieri lo ricorda, che più volte furono fatti tentativi per introdurre nel Regno di Napoli l’Inquisizione, ma, se:
«la popolazione del regno di Napoli è forse l’unica fra le nazioni cattoliche presso cui nè sovrani nativi nè stranieri nè pontefici arrivarono mai ad introdurre il tribunale dell’inquisizione, questa popolazione ha forse superate per lungo tempo tutte l’altre nelle superstiziose credenze.»
In quel tempo le Corti di giustizia calabre tendevano a:
«riguardare i delitti umani come campo di ricca messe a chi li giudica, con che davano l’aspetto d’inique alle cause anche le più giuste.»
Si sarebbe dovuti arrivare a Filangeri o Beccaria:
«per comprendere come il reo caduto in mano della giustizia, e durante l’esame e nell’atto della sentenza e fin sul palco di morte, debba divenire un sacro oggetto di dignitoso riguardo pel giudice.»
Ci troviamo in quella zona del Sud d’Italia, ai piedi della Sila, chiamata, a quel tempo, Calabria Citeriore. È l’8 settembre 1510 e la scena si apre nei pressi di una chiesuola isolata, intitolata alla Natività della Vergine, in occasione della fiera annuale. Ma quell’anno, come da alcuni anni, è una ‘magra fiera’. Non c’è più l’abbondanza e la spensieratezza di un tempo.
A guastare la fiera paesana è la banda ‘d’assassini della Bocca del Lupo’ e non riesce a liberare le Calabrie da questo flagello neanche “il viceré attuale, il magnifico don Gonzalvo di Cordova, che non è, per Dio! uno stupido”.
Vicino alla chiesa della Natività della Vergine, vive la bellissima diciottenne Maria Solis, dolce fanciulla orfana di rispettata famiglia, della quale il viceré è stato padrino di battesimo. Ella è innamorata, ricambiata, del capitano delle guardie Luigi Grifone, giovane tanto bello quanto serio e stimabile, di nobile casato, essendo stato il suo defunto padre consigliere del re Federico e poi caduto in disgrazia per il cambio di regime. Le nozze sono imminenti. Ma ecco che le cose sono complicate dall’arrivo nella scena del terribile Leone o “Gran capitano degli Apennini” come è chiamato il capo della banda degli spietati briganti, che per alcuni in realtà sembra più un benefattore che toglie ai ricchi per dare ai poveri. E ci si mette anche un’astrologa da fiera con una infausta predizione, alla quale Maria oppone però come talismani il “suo retto discernimento” e la “purezza del proprio cuore”.
Tutti i personaggi in scena, Maria, la sua nutrice Concezione, il capitano Luigi Grifone, Padre Venanzio, i paesani sono molto ben tratteggiati, quasi li vediamo in azione; ma in particolare Maria, modesta ma decisa, retta e compassionevole, intelligente e risoluta risulta una figura moderna e straordinariamente viva.
La novella risulta di gradevolissima lettura.
Sinossi a cura di Claudia Pantanetti, Libera Biblioteca PG Terzi
Scarica gratis: Virtù e delitto o La famiglia del masnadiero di Gaetano Barbieri.