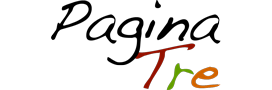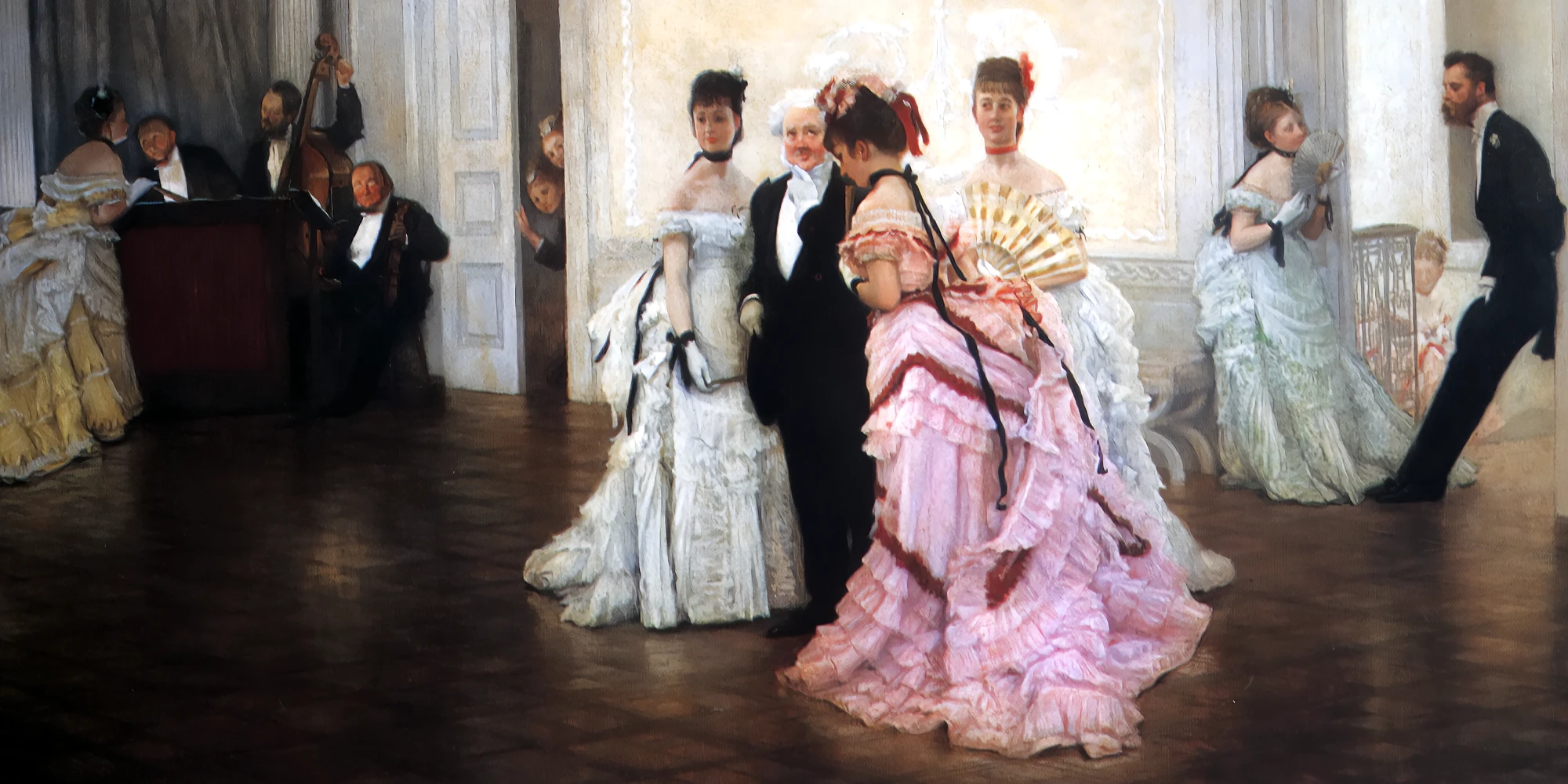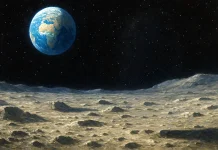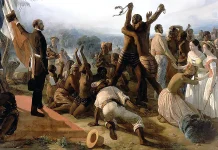Nel 1952 un piccolo editore cuneese diede alle stampe questo romanzo in seguito all’insistenza, sembra, del fratello dell’autore. Ne vendette un centinaio di copie prevalentemente a Palermo e provincia. Critica e pubblico ignorarono quindi quasi completamente quest’opera e certamente i poco edificanti trascorsi politici dell’autore, in anni nei quali le ferite portate dal fascismo e il disgusto per il razzismo erano ancora palpabili, non furono certo ininfluenti per rendere invisibile un’opera letteraria importante e che nulla aveva che potesse far trasparire il passato razzista di Giuseppe Maggiore. Ma qualche anno dopo la notorietà, almeno negli ambienti letterari, giunse ugualmente anche se per via indiretta e, forse, non servì gran che a far sì che l’opera fosse finalmente letta con l’attenzione che avrebbe meritato. Nel 1958 fu pubblicato, postumo, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; sulle traversie editoriali di questa pubblicazione non è il caso di soffermarci in questa sede.
Prontamente gli ambienti della cultura e dell’ideologia, che non amarono certo, almeno in prima battuta, questo romanzo, lo accusarono di plagio, proprio di quel Sette e mezzo che qualche anno prima avevano ostentatamente ignorato. Le similitudini esistono, certamente: un certo impianto narrativo, il nome – Fabrizio – del personaggio centrale, l’ambientazione storica e la “sicilianità”. Altrettanto certamente Tomasi di Lampedusa conosceva Maggiore – frequentavano la stessa libreria Flaccovio – e aveva letto Sette e mezzo che ebbe a definire “interessante ma un po’ ingenuo”. La molla che spinse entrambi a scrivere i romanzi di cui parliamo fu probabilmente simile: il desiderio di parlare di un periodo travagliato della storia siciliana, cioè quello del risorgimento e della contraddittoria adesione dell’isola alle pulsioni unitarie. Ma la descrizione e la prospettiva appaiono poi del tutto diverse. In particolare l’idea di un movimento indipendentista che permea tutto l’impianto narrativo di Sette e mezzo e sulle ragioni del quale Maggiore pone con insistenza l’accento, non traspare per nulla ne Il Gattopardo.
Il romanzo di Maggiore pone in primo piano i caratteri politico-sociali del momento storico che caratterizzò gli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia. Questi vengono visti attraverso lo sguardo del nobile marchese Fabrizio Cortada:
«Se la storia, avvelenata dal vino troppo forte di perverse ideologie, si era data ad una corsa scervellata rovesciando i Borboni, avrebbe pensato la Giustizia, la Nemesi, a farla retrocedere, come si manda a ritroso, verso l’ora giusta, un orologio impazzito. Non è vero che la storia sia irreversibile, che abbia un unico senso di marcia.»
Il tricolore è un estraneo per il nobile siciliano che lo vede solo come illecito usurpatore dello stemma borbonico delle due Sicilie. Nonostante il romanzo possa essere letto intravedendo la prospettiva filofascista dell’insigne giurista che ne fu autore, attraverso una storia di potere vista in un’ottica reazionaria, non si può non constatare che la descrizione che viene proposta della politica dell’epoca non è poi troppo dissimile da quella che sembra egemone ai giorni nostri. La rivoluzione del sette e mezzo – detta così perché la rivolta di Palermo del 15 settembre 1866 durò appunto sette giorni e mezzo, prima di essere brutalmente soffocata dalla sanguinosa repressione guidata da Raffaele Cadorna – che all’epoca suscitò persino uno sguardo benevolo da parte di Marx («l’ebreuccio tedesco di cui non ricordo il nome”, così lo menziona Tomasi di Lampedusa in Il Gattopardo) è stata definita da Mario De Mauro «rivoluzione politica anticoloniale e proletaria» (A Palermo riscoprendo la rivoluzione del settembre 1866 nel 2017 su sito web www.terraeliberazione.net), concetti che erano già stati espressi da Ignazio Coppola nel suo articolo Quella del sette e mezzo fu una rivolta popolare («Repubblica» 18 settembre 2011). Certo si può dire che la storiografia ufficiale ha praticamente cancellato la memoria della Comune palermitana. Difficile accedere a fonti storiche che non siano palesemente inquinate. Lo stesso Maggiore sottolinea, cercando di fare un bilancio di quanto narrato:
«La storia – scritta dagli uomini – è verità mentitrice e menzogna veritiera. Erma bifronte, che piange del suo riso e ride dei suo pianto.»
Ma, come spesso accade, la letteratura in questo caso colma, almeno in parte, le manchevolezze della storiografia: Camilleri in Biografia del figlio cambiato descrive la rivolta con il suo linguaggio colorito da termini quasi dialettali ma denso di ironia («Raffaele Cadorna sparato di corsa nell’Isola a palla allazzata…» senza mancare di sottolineare «la politica economica dissennata nei riguardi del Mezzogiorno d’Italia»). Leonardo Sciascia scrive la prefazione al libro di Mauro De Mauro Sette giorni e mezzo di fuoco a Palermo e non manca di sottolineare la ventata innovativa che mirava a un reale cambiamento pur se confusa tra pulsioni rivoluzionarie e rimpianti borbonici. E anche Maggiore, anche se non può non far trasparire la sua idea reazionaria che avrebbe forse incontrato maggiore attenzione in un periodo storico che voleva ingigantire ad ogni costo il “pericolo rosso”, fornisce una ricostruzione storica attendibile, con una descrizione attenta ai reali ruoli svolti dai principali protagonisti della vicenda, facendo emergere nitidamente che la caratteristica di quell’insurrezione fu di essere una rivolta senza capi. E senza mancare, ovviamente, di porre l’accento su quanto pensa lui delle rivoluzioni, dell’idea stessa di ribellione all’ingiustizia e al sopruso:
«Le rivoluzioni! Servono a fare arricchire i vetrai, che rimettono, dopo le rotture, i vetri nuovi, o vanno a beneficio dei tintori, che tingono vecchi stracci con nuovi colori: del resto, lasciano tutto come si trova.»
«Scateniamo la rivoluzione economica e all’uomo vecchio si sostituirà l’uomo nuovo. No, mio caro. Bisogna prima riformare l’uomo e poi il mondo. Che te ne fai di un mondo trasformato nel modo migliore, secondo il tuo senno, se l’uomo rimane lo stesso: con i suoi vizi mediocri, i suoi insaziabili appetiti, livido d’invidia e giallo di odio per il suo simile?»
« […] teorie sulle rivoluzioni: quello della perfetta irrazionalità dei grandi sommovimenti popolari. I quali vengono fatti da pochi individui che sragionano seguiti da imponenti moltitudini, che non ragionano affatto. Là dove i filosofi si affannano a ricercare motivi e interessi più o meno ideali, non c’è che un fluire e rifluire di forze istintive, di bestialità ancestrali, di odi e cupidigie aizzate da sadica voluttà di sangue.»
Però nei dialoghi l’autore permette anche di dare spazio a un punto di vista più radicale:
«Appunto per ripulire il mondo del marcio, ogni tanto ci vuole una rivoluzione.»
La forza del romanzo risiede appunto nella capacità di dare spazio alle varie interpretazioni della realtà dell’epoca secondo punti di vista diversi. La francese donna Ortensia («Il mio primo maestro è Rousseau corretto da Voltaire, il secondo è Stendhal» afferma) ha tre figli: Fabrizio, che pensa e trama per la restaurazione borbonica, Federico, un sognatore che conobbe Pisacane e prova sulle orme di suggestioni bakuniane e proudhoniane a costruire una “comune” (la colonia Astrea) mettendo le sue proprietà a disposizione di contadini fittavoli e braccianti con la prospettiva di mostrare la strada per il superamento dell’ingiustizia, e Ramiro “scavezzacollo” e garibaldino che trasmette al figlio Goffredo la passione ardente sia per la nuova patria (purtroppo sabauda…) che per l’orgogliosa sicilianità. Goffredo partecipa quindi sia alle vicende garibaldine di Aspromonte che alla rivolta del sette e mezzo.
Donna Ortensia, in un romanzo di rivolte ribellioni e marce verso l’utopia, rappresenta la madre di ogni rivoluzione, la Rivoluzione francese, interpretando le vicende che vive con indomito spirito liberale e volteriano. Definisce “scioani” (così i giacobini definivano i vandeani) i velleitari restauratori borbonici che fanno da contorno alle iniziative antiunitarie e antisabaude di Fabrizio.
La prima e la terza parte del romanzo sono quindi incentrate sul contrasto rivoluzione-reazione impersonate dalle pulsioni di Goffredo e dall’aristocratica velleità restauratrice di Fabrizio. Qui forse possiamo trovare analogie con il contrasto gattopardiano tra il Principe di Salina e Tancredi. In quest’ultimo però l’ardore rivoluzionario che in Goffredo resta fiammeggiante si appiattisce rapidamente nella convenzionalità e nell’immutabilità della politica delle istituzioni). La parte centrale è dedicata invece ai tentativi utopici di Federico che nei suoi viaggi, oltre all’incontro già menzionato con Pisacane, ad Albaro “presso Genova” conobbe pure Marx del quale Maggiore non ostenta almeno di essersi dimenticato persino il nome…:
«Tra una selva di bandiere rosse, il Leone di Treviri parlava. Una criniera di capelli fluidi nerissimi, commista alle tempie con una gran barba abbaruffata; una fronte procellosa bucata da due occhi malinconici da profeta del vecchio Testamento. Un’espressione, nell’insieme, di can barbone, senza la bontà canina, anzi inagrita da una sfumatura di risentimento e di pessimismo.»
Dopo il disgusto per il “socialismo ateo” di Pisacane subentra l’entusiasmo per Il manifesto dei comunisti. «un razzo luminoso in un cielo velato da una cortina di nebbia». Nei sogni utopici di Federico viene coinvolto anche Goffredo che trova in questa marcia verso l’utopia una strada, almeno provvisoria, per la rivoluzione. Per questo Goffredo può rappresentare in un certo senso lo spirito di una permanente rivoluzione contro ogni ingiustizia. Lo ribadisce nel finale del romanzo il frate al quale Goffredo si rivolge:
«marcerai, lotterai, combatterai, cadrai, ti rialzerai… e verrai alla conclusione che la vita, meglio che un’avventura terrestre, è un dovere, anzi un servizio, un servizio divino…»
Goffredo dubita adesso:
«E che venga il regno della giustizia. Ma verrà davvero?»
Ed ecco che Maggiore ci offre anche la prospettiva ecclesiastica, cristiana:
«Il regno della giustizia non verrà mai, finchè l’uomo non divenga giusto. Ma basta intanto con le lotte, con le violenze, col sangue, basta con le rivolte e con le guerre. Non tentiamo oltre l’ira del Signore. Trionfi finalmente la carità. Essa sola ci potrà dar la pace.»
Un breve accenno merita anche la figura di Teodora, moglie di Fabrizio. In anni nei quali l’adulterio era un reato e la riprovazione sociale pesantissima, Maggiore scrive:
«Quando ero la moglie onesta, irreprensibile, nessuno si occupava di me, nemmeno per compiangermi: ero una insignificante ochetta senza temperamento e senza calore. Ora che ho acquistato coscienza della mia libertà, e mi sono svegliata al senso della mia bellezza, ogni donna, che vorrebbe essere al mio posto, si rode di rabbia e sprizza veleno. C’è qualcuna che agogna di fare quel che fo io? Mi imiti. Mi superi. Il mondo è largo. C’è posto per tutti. Che fo io? Mi godo la mia libertà.»
Credo, per concludere, che questo romanzo vada rivalutato e che la nostra edizione elettronica venga a cercare di surrogare la sua scarsa diffusione nel mercato editoriale cartaceo (dopo la prima edizione di Ghibaudo, il palermitano Flaccovio lo ha pubblicato in edizioni successive a partire dal 1963). È in sintesi un’opera notevole, di piacevole e scorrevole lettura e capace di accompagnare chi legge non solo nei percorsi storici delle spinte autonomiste ma anche nei labirinti delle pulsioni umane, astenendosi generalmente da giudizi perentori su queste (persino l’adulterio, come si è visto, è presentato con sobrietà e non ignorando il punto di vista femminile), ma sforzandosi di presentarle in tutte le loro sfaccettature.
Sinossi a cura di Paolo Alberti
Dall’incipit del libro:
Il calendario segnava: 16 gennaio. L’anno era sottinteso. È costume dei lunari di ricordare una volta sola – alla prima pagina – che un altro ciclo della nostra vita è franato nel nulla. Poi comincia la piccola contabilità dei mesi e dei giorni: febbraio, marzo, aprile… martedì, mercoledì, giovedì… tutti eguali. Sufficit enim diei malitia sua, dice il Vangelo.
Quel 16 gennaio cadeva nel 1864, genetliaco di Sua Maestà Borbonica Francesco II, Re delle due Sicilie. Un Re senza regno. Francesco era detronizzato da quattro anni. Detronizzato da chi? Dalla Provvidenza? Dalla Storia? Neanche per sogno. Solo dalla forza bruta alleata della fellonia e del tradimento. Se la storia, avvelenata dal vino troppo forte di perverse ideologie, si era data ad una corsa scervellata rovesciando i Borboni, avrebbe pensato la Giustizia, la Nemesi, a farla retrocedere, come si manda a ritroso, verso l’ora giusta, un orologio impazzito. Non è vero che la storia sia irreversibile, che abbia un unico senso di marcia. Tutto sta che il buon Dio abbassi il suo dito. Non si erano visti i Borboni di Francia, dopo il cataclisma della Rivoluzione, risalire sul trono dei Capeti? E i gigli d’oro in campo bianco spazzare via il tricolore, simbolo del Peccato e dell’Ira? E il beneamato Ferdinando I, avo dell’infelice Francesco, non era due volte sormontato al potere, dopo i funesti episodi della Repubblica partenopea e dell’usurpazione napoleonica?
Scarica gratis: Sette e mezzo di Giuseppe Maggiore.