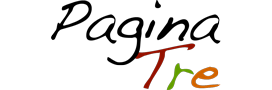Margherite e Rosolacci raccoglie il rimanente delle poesie rimaste inedite dopo la pubblicazione della raccolta È fatto giorno. Fu pubblicato nel 1978 da Mondadori nella collana “Lo Specchio. I poeti del nostro tempo” e poi riproposto nelle edizioni delle Opere complete.
Il substrato umano, ma anche etnografico e geografico, di quest’opera resta quello della Lucania mitica e della sua gente. Quando Scotellaro iniziava a pubblicare i suoi versi e via via che questi venivano conosciuti era iniziata la restaurazione politica e letteraria, il che poteva condurre a collocare queste poesie nell’ambito di un generico e lamentoso meridionalismo e di un generico ribellismo. Certamente egli poeticamente è nato e cresciuto nel solco di un ampio movimento espressivo che coinvolse numerosi giovani autori meridionali e che non poteva rimanere estraneo alle esperienze che attraversavano le vecchie strutture sociali e di costume delle loro terre.
Non possiamo dimenticare che Scotellaro è stato certamente un letterato ma anche un uomo politico e la sua esperienza di scrittore è anche protesa a provare a fondare una nuova realtà, o quantomeno a far emergere realtà complesse. Anche la sua poesia può essere letta in quest’ottica. Rocco Scotellaro non indulge tuttavia a lasciarsi coinvolgere da esperienze dialettali e neppure si lascia sedurre da facili neoclassicismi e non tesse mitologie sulla sua materia letteraria. Il suo passato non ha necessità di diventare un pretesto letterario come è capitato ad altri letterati meridionali passati al Nord, (ad esempio Vittorini, Gatto, Quasimodo, Marotta) e non ha avuto bisogno di trasformare il ritorno al paese in una leggenda o un rimorso.
Quindi la sua poesia va o resta senza stravolgersi e questo lo dovette alla sua coscienza e alla sua esperienza politica. Forse questo non è direttamente leggibile nei suoi versi ma si avverte e si percepisce secondo me in maniera evidente se prendiamo questi nel loro complesso, se li consideriamo nel loro insieme. È legato e coinvolto al tempo stesso ai problemi letterari del mondo europeo e ai problemi politico-sociali del sud italiano e si distingue in maniera netta dalla poesia neo-populista. Pasolini nel suo articolo la Poesia e il sud rileva che i poeti meridionali ripropongono una visione statica di un Sud mitologico e infantile collocata all’interno di una cornice stilistica decadente e artificiosa. «Se la nuova poesia si limita a denunciare in falsetto le ovvie miserie dei pastori e dei contadini a che cosa serve? Ormai son cose che si sanno. Denunci, invece, quel proprio interno vizio conformistico: cambi tono, rinunci alle facili esaltazioni dell’inno e dell’oscura minaccia, dell’avvenirismo patetico, e cominci a ragionare». Ma in quest’orizzonte culturale nel quale Pasolini vorrebbe collocare Scotellaro, nonostante gli riconosca poi una certa importanza almeno simbolica, è in questo caso troppo angusto.
È invece Carlo Levi che esamina a fondo la relazione complessa tra l’attività politica di Scotellaro e la sua lingua letteraria: l’idea di Levi è che il sindaco-poeta si adoperò per rappresentare un mondo culturale e sociale che gli era prossimo per nascita e ceto, ma anche lontano grazie al privilegio conseguente ad una educazione borghese. Gian Luigi Beccaria presentando il volume nel 1978 scrisse: «preziose margherite un po’ di serra ermetica e rosolacci di campo; per un verso lo Scotellaro ricerca la poesia ellitticamente compatta, l’immagine scorciata e per l’altro quella più cordiale rivolta a un pubblico non elitario». Inquadrandola in questo modo mi pare che siamo più vicini a vedere queste poesie per quello che sono realmente: un canto di fedeltà di un intellettuale moderno al suo paese d’origine, la sottolineatura di alcuni dei momenti più significativi della vita collettiva di una classe che prova a prendere coscienza di sé, lo scompenso per la perdita dell’idillio e dell’infanzia, il disorientamento per un passaggio a una realtà dove la fraternità non basta e dove la lotta, anche interiore, è così complessa. Scaturisce da questo il senso di genuinità e di compiutezza che va ricercato più nella soggettività lirica che negli slanci di bellicosa denuncia.
Sinossi a cura di Paolo Alberti
Dall’incipit del libro:
Piangermi d’affanni
o di gioia
un tempo il mio cuore solea.
Sentimenti, passione
dolore
erano lacrime di cui gli occhi
mi luccicavano.
Un tempo.
Il poverello che tende la mano
il fanciullo che geme dal gelo
una mamma che il bimbo
non consola con moine affettuose
e il tramonto
la sera…
e anche tu notte
una lacrima strapparmi non sai.
Scarica gratis: Margherite e rosolacci di Rocco Scotellaro.