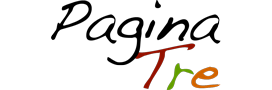Le vicende narrate in questo libro si concentrano intorno agli anni 1570-1573, anni in cui emerge la figura del Colonna, condottiero della Marina Pontificia e uno dei protagonisti della vittoria di Lepanto. Egli fu artefice primo di una coalizione navale, al fine di combattere l’Impero Ottomano nel corso della guerra per difendere l’isola di Cipro, avamposto cristiano in generale e veneziano nello specifico. La lotta fu in realtà un capitolo della guerra per il controllo del commercio nel Mediterraneo, ancorché papa Pio V, dopo la strage compiuta sui Veneziani a Famagosta, la trasformasse con toni da crociata in una guerra di religione tra Cristiani e Musulmani.
La capacità militare del Colonna fa il paio con la sua pazienza diplomatica, perché la Lega Santa che il papa convocò per la difesa di Cipro si valeva di navi e truppe provenienti da diversi paesi, tutt’altro che fiduciosi l’uno nella buona fede dell’altro. I Veneziani, i Genovesi, i Savoia, il Granduca di Toscana, il Regno di Napoli e la Spagna, al di là delle inevitabili rivalità di carattere fra i rispettivi condottieri, avevano infatti profonda sfiducia reciproca, e Colonna rinunciò al comando in favore di Giovanni d’Austria per diminuire gli attriti. Molte pagine del libro sono dedicate a queste schermaglie diplomatiche che precedettero la fatidica giornata del 7 ottobre 1571. Scrive infatti Guglielmotti (Libro Secondo, pag. 124 e 133):
«Sin dal primo giorno i ministri spagnuoli con gran sicumèra e con sospettosa alterigia presero a mandar le cose per le lunghe, ed a trattar co’ Veneziani piuttosto da superiori che da compagni. …. Volevano costoro che la lega si dichiarasse soltanto difensiva dal sultano di Costantinopoli, offensiva contro i Barbareschi: e che fosse scomunicato dalla Chiesa chi rompendola si pacificasse con loro. Ma i Veneziani, sostenuti dal Papa, vinsero il partito che l’alleanza mirasse sin dal principio a guerra offensiva contro il gran Turco e suoi dipendenti: e quanto al secondo, contentandosene il Papa, non vollero mai sentire parola di censure.»
Il volume presenta queste vicende con numerose fonti, di tutte le parti in causa, e se è chiaro fin dal titolo che la tesi del libro è assolutamente favorevole al Colonna, pure sono raccolte tutte le voci dell’epoca che ne parlarono; anche perché una consistente parte del libro è dedicata a ciò che accadde dopo la vittoria, e a come le nuove divergenze tra i partecipanti alla Lega fecero sì che la portata della vittoria di Lepanto fosse grandemente diminuita negli anni successivi; e tutto ciò nonostante la lealtà profonda che Colonna pose nel suo incarico. Si veda p. 317, Libro terzo:
«Marcantonio ebbe ordine di allestirsi alla partenza. Sapeva bene quanta invidia fosse cresciuta dalla plebe dei cortigiani sino al trono di Filippo contro di sè. Sapeva le querele tra Spagnuoli e Veneziani, e pensava come, dovendo star tra loro nel mezzo, sarebbe stato afflitto o dalle esorbitanze degli uni, o dalle esigenze degli altri. Ciò non pertanto, ripigliato animosamente il governo della spedizione, e pronto a soffrire tutto anzichè fallire alla fiducia del Papa, si dette a provvedere quello che bisognava per la campagna.»
L’importanza del libro, scritto dal religioso domenicano Guglielmotti nel 1862, trascende la vicenda storica che ne costituisce l’oggetto. Questa fu infatti considerata la prima rivendicazione, dopo l’unità d’Italia, delle glorie della marineria nazionale, costituendo così la base della nascente Marina da guerra Italiana, che a differenza dell’Esercito, non poteva basarsi su gloriose tradizioni del Regno Sardo. Il libro ebbe in breve tempo ben 15 ristampe ed il suo autore fu da allora considerato il padre della storia navale italiana. Questa edizione presente su Liber Liber è stata digitalizzata a partire appunto dalla prima edizione (Firenze 1862).
Sinossi a cura di Gabriella Dodero
Dall’incipit del libro:
La vita degl’imperî nel successivo procedimento del sorgere, del crescere e del cadere fu sempre paragonata alla vita degli uomini per i tempi della gioventù, della virilità e della vecchiaia: e sempre si è detto che quelli al paro di questi scadono o per lunga decrepitezza, o per interna corruzione, o per esterna violenza. Al quale ultimo modo di scadere vanno più spesso soggetti gl’imperî dei conquistatori: perchè costoro a lungo andare devono finalmente venire in parte ove la natura (che ha definiti i termini alle nazioni co’ monti co’ mari e co’ fiumi) arduità di rupi e profondità di acque lor contrapone; e dall’altra parte i popoli schivi di servaggio tanto li contrastano che o rottili tra le balze, o sommersili nell’acque, li riducono contro lor voglia a declinare. L’impero ottomano, fondato e mantenuto da’ conquistatori, condotto nel secolo decimoquinto all’altezza di Costantinopoli, non era nel decimosesto nè decrepito nè corrotto; ma in quella vece florido di giovanil vigoria, per terra e per mare potentissimo, e geloso mantenitore degli ordini civili e religiosi onde era salito a tanta potenza. Ciò non pertanto in quel torno medesimo di tempo e quando vagheggiava maggiori conquiste, cominciò ad abbassarsi: donde è forza concludere che nell’ultimo modo, e per violenza di esterna percossa fosse da altri condotto a rovinare.
Scarica gratis: Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto di Alberto Guglielmotti.