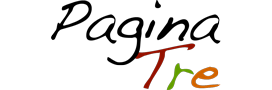«… né bello né brutto, né grasso né magro, né vecchio né giovane. Il suo arrivo non destò nessun rumore né fu contrassegnato da speciali incidenti.»
Così entra in scena il protagonista del romanzo, in perpetuo movimento e senza fissa dimora, ma vagheggiante una vita tranquilla in campagna: è “Paolo Cicicoff di Giovanni, consigliere di collegio, proprietario, viaggia per affari”, come si fa registrare nella non meglio identificata “locanda della città di NN”, NN di cui a sua volta solo al capitolo X veniamo a sapere che “non distava molto da Pietroburgo e da Mosca”. Gogol’ sceglie di descriverci Cicicoff con un periodo fitto di negazioni, una sequenza di litoti che evoca l’immagine di un individuo insignificante, il cui arrivo in città passa inosservato. Il lettore, così come gli abitanti di NN, viene lasciato completamente all’oscuro su carattere, storia e intenti del picaresco personaggio e del suo inusitato commercio, che gli verranno rivelati solo al capitolo XI, a più di trecento pagine dall’inizio del romanzo. Accompagnano Cicicoff il cocchiere Selifan, loquace solo con i propri cavalli, e “il lacchè Pietruccio”, caratterizzato da “una certa sua particolare atmosfera, impregnata del proprio odore che sentiva alquanto di abitato”.
L’immagine iniziale di Cicicoff trova conferma nelle sue interazioni dapprima con il cameriere della locanda, poi con i maggiorenti del paese, dai quali senza indugio si reca in visita: estremamente parco di notizie su di sé (si limita a definirsi “una nave in balia dei flutti”), bersaglia invece i suoi interlocutori con domande sui possidenti locali, dei quali è ansioso di conoscere l’estensione delle terre e soprattutto il numero di “anime” (così erano definiti in Russia i contadini, parte integrante del feudo prima dell’emancipazione dei servi della gleba del 1861). In base alle informazioni ricevute, Cicicoff intraprende quindi i suoi viaggi d’affari con lo scopo di assicurarsi il maggior numero possibile di quelle “anime morte” che danno il titolo al romanzo, i servi deceduti che però non risultano tali fino alla registrazione della morte nel successivo censimento. Adeguando abilmente le proprie strategie comunicative alle caratteristiche di ciascun possidente, Cicicoff, gran conoscitore della natura umana, cerca di convincere i suoi interlocutori, di volta in volta stupiti, increduli o diffidenti di fronte ad una richiesta tanto insolita, a regalargli o a vendergli al prezzo più basso possibile la “merce” da lui ambita.
Il motivo di questi acquisti, apparentemente insensati, non ci viene per ora svelato, ma la situazione paradossale, vissuta con simulata naturalezza dal protagonista, consente all’autore di esplorare i caratteri del popolo russo ed in particolare degli amministratori pubblici in città e dei proprietari terrieri in campagna, con cui Cicicoff interagisce e che spesso lo ospitano. Si susseguono così i vivaci e realistici ritratti, resi talora caricaturali dall’umorismo di Gogol’, dell’avaro Pliusc’kin, trasformatosi dopo la disgregazione della sua famiglia da “avveduto e parsimonioso proprietario” ad accumulatore compulsivo, incurante dei propri beni; delgaudente Sobachevic, “molto somigliante ad un orso di mezzana grandezza”; di Nosdrioff, il bugiardo patologico, giocatore e “grande amatore di bagordi”; dell’ignavo Maniloff, l’uomo senza qualità; di Coròboc’ca, l’anziana possidente dapprima “trasecolata” di fronte all’affare propostole da Cicicoff, poi ossessionata dal timore di essere stata frodata; dell’inefficiente Cosc’carioff, che annega nella burocrazia; di Costangioglo, il possidente ideale, “raggiante, come un imperatore nel giorno dell’incoronazione” nel contemplare i frutti delle sue cure, terre prospere dove “perfino il maiale aveva aria di signore”… In città troviamo invece i borghesi, il cui benessere s’incarna nell’aspetto florido delle “facce tonde e levigate”, gli impiegati corrotti e sfaticati ma pieni di sé, strumenti di una burocrazia farraginosa e inefficiente come il cancelliere che accompagna Cicicoff dal presidente del tribunale, sul quale Gogol’ ironizza utilizzando, con procedimento antifrastico, un paragone alto (l’amato Dante!) per definire un’azione di nessun conto:
«Questi rese ai nostri due amici lo stesso servigio che Virgilio a Dante, e li guidò nella sala di udienza……»
Ne emerge una società senza valori, corrotta dai suoi strati più alti (formalismo, ipocrisia, vanità e superficialità raggiungono l’apice nell’evento clou del bel mondo cittadino, il ballo) agli infimi, accomunati dalla “smania del possedere”, dall’attaccamento ai beni materiali, da cibo e alcolici a denaro e terra; Cicicoff ne è il tipico esemplare, in grado di destreggiarsi con abilità fra i suoi simili, catalizzando l’attenzione di uomini e donne e riuscendo a farsi benvolere da tutti i notabili, fino a quando…..
«Tale fu l’opinione, certo molto lusinghiera, che il novello arrivato conquistò e mantenne, fino a che una sua strana particolarità e una più strana intrapresa non vennero a gettare l’intera città in un mare di dubbi.»
I borghesi della cittadina e le loro mogli iniziano ad affastellare le più disparate congetture sull’anonimato di Cicicoff e sulla stranezza dei suoi affari: il suo arrivo dapprima inavvertito mette in subbuglio una cittadina in precedenza fin troppo tranquilla e “il nostro eroe”, che prima tutti “portavano, come si suol dire, in palma di mano” vede mutare radicalmente la propria immagine….
Fin dalle prime pagine possiamo cogliere quella nota di amara ironia, frutto di una visione disincantata della società e della vita, che percorre l’intero romanzo. Fanno eccezione gli spazi che l’autore si ritaglia rivolgendosi ai lettori per trarre dalle vicende spunti di riflessione sul carattere del popolo russo o sugli effetti nefasti degli influssi stranieri («migliaia di libri, diffusi negli ultimi tempi a fine d’inoculare ogni sorta d’inutili bisogni al genere umano», «Ci salta il grillo del progresso, dei lumi, come li chiamano»), oppure sostituendosi temporaneamente al suo “eroe” (come Manzoni a Lucia nel celebre “Addio monti…”) per passare dal tono ironico al lirismo romantico nel descrivere il paesaggio della steppa russa:
«La vettura scende per una china: in giù, una larga diga e un limpido stagno che ha dei riflessi di rame; ville, capanne sulla costa del monte; da un lato brilla come una stella la croce della chiesetta; cicaleccio di contadini e insopportabile appetito nello stomaco…. Dio, Dio! come sei bella, o lunga strada interminabile! Quante volte, come un naufrago, io mi afferrai a te, e tu magnanima mi portasti e mi salvasti! E quante idee belle, quanti sogni di poesia mi germogliarono dentro, quante sovrumane emozioni mi commossero!»
Come l’autore esplicitamente riconosce, si tratta di una descrizione ben lontana dallo spirito prosaico di Cicicoff: Gogol’ infatti ha posto deliberatamente al centro di quello che lui definisce un poema in prosa non l’eroe classico, modello di virtù, portatore di valori e di ideali, ma un antieroe (che spesso nel romanzo egli chiama ironicamente “il nostro eroe”), prodotto e nel contempo emblema della società del suo tempo:
«Felice lo scrittore, che torcendo gli occhi dai tipi gretti, ripugnanti, tristemente reali, prese a modello caratteri nobili e degni; […] Non cosí purtroppo lo scrittore, che osò trarre alla luce le piú frequenti e piú umili forme dell’esistenza di tutti i giorni, le quali sfuggono agli occhi sbadati della gente; che smuova e rivolti la melma nauseabonda delle miserie che irretiscono la nostra vita, che scruti sino in fondo le creature esangui, fragili, triviali di cui brulica il cammino terrestre spesso ingrato e doloroso, e che con spietato scalpello le scolpisca e le esponga alla folla. Egli non raccoglierà il plauso dei suoi fratelli; […] non a lui sarà dato […] sottrarsi al giudizio contemporaneo, ipocrita tribunale inesorabile, che bollerà come volgari e nulle le figure da lui modellate, gli assegnerà il piú spregiato cantuccio fra gli scrittori che oltraggiarono il genere umano, gl’imputerà i vizi degli stessi tipi da lui messi in scena, gli negherà il cuore, l’anima, la sacra scintilla dell’ingegno.»
Il progetto di Gogol’ è molto ampio: con Le anime morte, ispirandosi al capolavoro dantesco, egli ambisce a realizzare un poema in prosa, un monumentale affresco della società zarista che parta dai “tipi gretti, ripugnanti, tristemente reali” del primo volume, per sollevarsi nel secondo (con figure positive come il milionario Murasoff o il possidente Costangioglo e con una prospettiva di redenzione per Cicicoff e il dissipatore Clobuioff) ed arrivare finalmente nel terzo ai “caratteri nobili e degni”. Il primo volume, la cui trama fu ispirata da un fatto di cronaca narrato a Gogol da Puškin, venne pubblicato nel 1841 con il titolo Le avventure di Čičikov, imposto dalla censura in quanto Le anime morte pareva negare il dogma ortodosso dell’immortalità dell’anima. Del secondo volume, iniziato nel 1840, ci sono pervenuti solo i manoscritti di quattro capitoli, presenti fra le carte lasciate da Gogol alla sua morte, avvenuta il 4 marzo 1852 mentre era ospite del conte Aleksandr Petrovich Tolstoj, suo esecutore testamentario. Sul resto del volume sono state formulate ipotesi più o meno fantasiose: una è che Gogol, morente, il 12 febbraio l’abbia distrutto o perché non ne era soddisfatto o perché, ormai poco lucido, l’aveva erroneamente gettato nelle fiamme assieme agli appunti preparatori ormai inutili; l’altra, che abbia bruciato i soli appunti e che il manoscritto sia finito nelle mani del conte Tolstoj (e da lì se ne sarebbero perse le tracce). Il terzo volume non fu nemmeno iniziato.
La traduzione, del 1918, è di Federico Verdinois, del quale è presente qui una biografia curata da Paolo Alberti e Catia Righi, e comprende la prima parte del romanzo e la seconda, nella versione elaborata da Tichenravoff e Scenrok. Alla lettura risulta un po’ datata, in quanto presenta, come è inevitabile, numerosi arcaismi, ma anche termini gergali, usati probabilmente per rendere con efficacia il realismo petroniano di Gogol ma talora per noi incomprensibili, come ad esempio babboriveggoli. Non mancano errori ortografici (“abborisse”, “inaffiarli”, “vermicciattolo”, “legicchiava”), o morfosintattici (“Questa specie d’illustrazioni piacciono”, “non gli ho mai visti”) ed un uso talora disinvolto delle virgole.
Sinossi a cura di Mariella Laurenti
Dall’incipit del libro:
Al portone d’una locanda della città di NN, si fermò uno sterzo a mezzo mantice, a molle, abbastanza vistoso, uno di quei veicoli nei quali sogliono viaggiare gli scapoli, i tenenti colonnelli al riposo, i capitani in seconda, i proprietari che hanno un centinaio di coloni, e insomma tutti i cosí detti signori di mezza carata. Un passeggero vi sedeva dentro, né bello né brutto, né grasso né magro, né vecchio né giovane. Il suo arrivo non destò nessun rumore né fu contrassegnato da speciali incidenti; soltanto due contadini russi, ritti sulla soglia di un’osteria di faccia alla locanda, fecero alcune osservazioni, che però si riferivano piú alla vettura che al passeggero. “Vedi veh, che legno!” disse l’uno; “o che ti pare, ce la fa con quelle ruote lí fino a Mosca?” “Ce la fa” l’altro rispose. “Ma a Kasan non ci arriva, dico io.” “A Kasan no” rispose l’altro. Qui la conversazione ebbe termine. Inoltre, avvicinandosi la vettura alla locanda, un giovane veniva in senso inverso, in calzoni bianchi di tela, corti e attillati, soprabito con mostre alla moda, di sotto al quale spiccava il petto della camicia, fermato da uno spillo di bronzo a foggia di pistola. Il giovane si voltò, guardò allo sterzo, mantenne con la mano il berretto che il vento voleva portar via, e andò pei fatti suoi.
Entrato lo sterzo nella corte, venne incontro al passeggero un servo cosí vivace e di tanta mobilità, che non si riusciva a distinguere che viso avesse.
Scarica gratis: Le avventure di Cicicoff, o Le anime morte di Nikolaj Vasilevič Gogol.