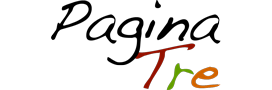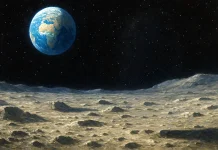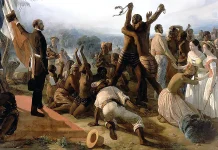Pubblicato nel 1902, questo saggio esamina la cosiddetta “questione femminista” mostrando come ormai non si possa più parlare di “femminismo” ma di “femminismi”. Vi è infatti ormai una vasta differenza fra le posizioni sostenute da alcune femministe, e quelle sostenute da altri gruppi; e la Labriola non esita a mostrare quelle che lei personalmente condivide e quelle che non approva, e trova anzi controproducenti. L’ottica in cui la discussione si sviluppa, pur ricca di elementi storici e filosofici, è indiscutibilmente quella di una studiosa di diritto, del rapporto fra diritto e società, e della coerenza “interna” tra i principi ispiratori della giurisprudenza, tra “regole” ed “eccezioni”.
Partendo dalla società romana del tardo Impero, in cui le donne avevano iniziato a svolgere ruoli estranei alla cerchia familiare (e non più solo dove il mondo orientale, greco e romano le aveva sempre tenute) e con le idee di pari dignità ed uguaglianza di fronte a Dio delle persone, propugnate dal Cristianesimo, si dovettero attendere gli anni della Rivoluzione Francese per vedere sorgere nuove idee sulla parità tra tutti gli esseri umani (Mensch per i pensatori germanici) e con esse rivendicazioni rivolte esplicitamente alle donne.
Tuttavia Labriola nota come anche il Codice Civile italiano, così ispirato al concetto di uguaglianza, riesca a peccare di discriminazione nei confronti delle donne, anche se fortunatamente non in ogni circostanza. Dal punto di vista penale, non ci sono “scusanti” per i crimini commessi da donne, in quanto le si ritiene assolutamente alla pari con gli uomini nella comprensione di ciò che è giusto e nella decisione se commettere o meno un delitto. Dal punto di vista del diritto di successione, non ci sono limitazioni alla possibilità di ereditare il patrimonio dei genitori, per le figlie, rispetto ai figli.
Dove invece ci sono palesi discriminazioni nei confronti delle donne, è proprio dove il ruolo della moglie e madre dovrebbe offrire la maggiore sfera di influenza, e cioè nel diritto di famiglia. È il marito che sceglie dove si stabilirà la casa coniugale, e la donna deve seguirlo. Il marito viene perseguito per adulterio, solo se porta l’amante in casa o comunque se rende evidente la sua relazione (come se il Codice tutelasse nella donna solo l’aspetto di “sputtanamento sociale” dell’adulterio maschile!). Perfino il consenso al matrimonio di figli e figlie viene negato o concesso sostanzialmente sulla base del parere del solo marito. Questi esempi, ed altri che Labriola elenca, rappresentano norme da modificare per il bene di tutta la società, non solo delle donne che ne vengono colpite.
Affrontando poi la questione della partecipazione delle donne alla vita politica, Labriola critica Platone ed Aristotele, le cui affermazioni contrarie a tale partecipazione non sono mai suffragate da dati di fatto, e ritiene che l’aumento di peso delle donne nella vita economica, andrà di pari passo con il raggiungimento dei diritti politici. Che questo possa accadere nel breve termine però Labriola lo nega recisamente, essendo ancora l’attuale organizzazione sociale “troppo maschile”. Ed in effetti, ci vollero due guerre mondiali ed una quarantina di anni perché le sue affermazioni sul voto alle donne si trovassero smentite dai fatti; e poi ancora qualche decennio per avere una riforma del diritto di famiglia paritaria tra uomo e donna.
Sinossi a cura di Gabriella Dodero
Dall’incipit del libro:
In questi ultimi tempi, e cioè proprio in questo periodo storico, nel quale tutti i problemi sociali in genere si son venuti facendo più vivi, ad alcuni scrittori è parso di poter negare l’esistenza di una vera e propria questione femminista.
Vario è certamente l’animo di quei diversi scrittori, che negano l’esistenza della questione femminista, come è pur difforme il fine al quale mirano. Secondo alcuni di essi, non sarebbe cosa possibile il raccogliere in un solo complesso tutti i varii problemi, che nascono dall’attuale posizione della donna nel mondo civile. Altri invece sostengono, non si tratti se non di una questione strettamente ed esclusivamente economica: – onde la risoluzione sua dipenderebbe, secondo cotesto modo di vedere, dal miglioramento soltanto della condizione economica della donna. Degli altri ancora ammettono sì, che il miglioramento della posizione del sesso femminile avveratosi di già risponda nel suo insieme a delle esigenze – come essi dicono – razionali; ma ritengono, inoltre, che il ciclo di evoluzione sia oramai compiuto, per ciò che s’attiene al riconoscimento del valore della personalità della donna nell’ordinamento giuridico. Secondo questi ultimi, dunque, la posizione attuale della donna corrisponderebbe proprio e precisamente alle cosiddette esigenze razionali; cosicchè qualsivoglia attività nuova, che venga spesa ora in favore del progresso femminile, non sarebbe se non l’espressione di uno spirito, o anarchico, o utopistico.
Scarica gratis: La donna nella società moderna di Teresa Labriola.