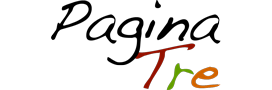Prosegue in maniera approfondita, in questo testo di Vittorio Bertoldi, il superamento degli aspetti statistici riguardo ai termini che esprimono un’idea – caratteristica di molti studi di suoi contemporanei – per giungere invece a poter collocare il termine preso in esame in un complesso insieme del quale fa parte l’organismo vitale, la sua psicologia, la sua collocazione all’interno della storia della cultura, della geografia linguistica. La glottologia diviene quindi strumento di comprensione della complessità dei contrasti fra diverse correnti culturali nell’ambito di un territorio specifico, del loro andamento storico e delle loro interazioni. Ogni singola innovazione linguistica si intreccia, quanto meno indirettamente, con aspetti storici e spirituali che forniscono base a questa innovazione.
Naturalmente le tracce dei punti di riferimento culturali del Bertoldi si individuano con una certa facilità: Schuchardt ribadiva sempre di attenersi alla «storia delle cose» perché la ricerca linguistica potesse avere concretezza; Gilliéron sottolineava come la distribuzione geografica di un vocabolo potesse essere fondamentale testimonianza storica; Jud ricostruiva le sovrapposizioni di variazioni lessicali di lingua nell’area romanza in parallelo alle variazioni di civiltà studiando il fenomeno linguistico nella sua distribuzione geografica.
Bertoldi raccoglie tutto questo e procede mettendo in evidenza l’aspetto psicologico individuale che si può ritrovare dietro a ogni innovazione linguistica. Nel suo rimanere ancorato all’analisi empirica egli ricerca tuttavia la traccia della spinta creatrice senza dissociarla dalla tradizione della quale fa parte. Già nel suo testo del 1939 Questioni di metodo nella linguistica storica, aveva delineato la propria prassi e la propria teoria, secondo le quali il fenomeno linguistico è essenzialmente fenomeno storico e di conseguenza il fine precipuo della linguistica è quello di contribuire alla storia della cultura attraverso la storia della parola. Ogni fenomeno linguistico trova la sua origine prima nell’atto creativo di un individuo, ma diviene atto di sintesi espressiva e insieme comunicativa inserendosi nel sistema di suoni e simboli comune a una data famiglia di parlanti.
Essendo ogni fatto linguistico un fatto culturale, la soluzione di qualunque problema etimologico presuppone l’accertamento dei valori significativi della parola e lo stato culturale che rispecchia. In base a questo asserto la ricerca etimologica può porre in secondo piano l’aspetto formale della parola rispetto a quello concettuale. Non è tanto quindi l’origine prima della parola che attira l’attenzione di Bertoldi ma soprattutto la serie dei suoi mutamenti successivi. Ne consegue che tra i due aspetti, individuale e sociale, Bertoldi si soffermi soprattutto sul secondo sottolineando il posto che la parola creata individualmente si conquista nell’ambito del patrimonio tradizionale, sempre condizionato dal clima culturale in cui essa fiorisce o declina.
Questo testo, che è del 1949, quindi della piena maturità dello studioso, riprende con insistenza tutti questi temi, studiando anche gli impulsi fantastici che sono alla base della parola, evitando con maestria gli eccessi dello storicismo e provando ad individuare in quale punto la linguistica psicologica si innesta su quella storica. Rilievo importante assumono l’onomatopea e i mezzi ritmici della creazione infantile e popolare la quale consente al meglio di studiare le forme elementari dell’invenzione linguistica, nelle quali la fantasia crea le proprie immagini con la riproduzione di suoni e ritmi che l’hanno maggiormente colpita.
Nonostante questo testo, come altri del Bertoldi, sia solo uno spunto iniziale di un cammino che sarà successivamente lungo e articolato, è tuttora una base solida per giungere dallo studio della parola significativa a quello dei suoni astratti e fornisce il filo conduttore per seguirne le trasformazioni nello spazio e nel tempo. Anche rileggendo e ristudiando l’opera di Bertoldi possiamo riuscire a collocare la parola in una complessa unità del periodo, non distaccata da tutti quegli elementi che contribuiscono a renderla varia ed espressiva.
Sinossi a cura di Paolo Alberti
Dall’incipit del libro:
Il linguaggio è prerogativa dello spirito umano. Nella sua essenza più pura, il linguaggio umano è attività creatrice dell’immaginazione. E quest’attività fantastica, insita nel linguaggio umano, lo contraddistingue, elevandolo al di sopra d’ogni sorta di linguaggio riconosciuto o riconoscibile in altri esseri viventi. Forme particolari di linguaggio sono state attribuite, com’è noto, ad alcune specie della fauna. Il cane si fa intendere dal suo padrone. Fino a un certo punto si può dire dunque che il cane usa un suo proprio linguaggio. Il latrato ha un valore espressivo diverso dal guaito; latrato o guaito resi spesso ancor più efficaci da movimenti, da gesti, da smorfie. A sua volta il cane capisce il cenno dell’uomo, distinguendone di caso in caso il fine espressivo, di richiamo o di congedo, d’elogio o d’ammonimento, di sprone o di minaccia. E tanto la voce umana di richiamo o di comando (cuccio!) quanto la voce canina (bau-bau!), stilizzate e adattate in vario modo a seconda delle varie tradizioni (ital. cúcciolo «cane ancora piccolo»; lat. BAUBARI, ital. abbaiare ecc.), diventano simboli nel linguaggio umano. Insomma, tra uomo e cane si può istituire una consuetudine reciproca di segni espressivi e comunicativi che porta alimento alla tradizione e che presenta qualche analogia con il modo d’intendersi fra gli umani. Comune ai due linguaggi, umano e animale, è infatti l’emissione di suoni con intenti espressivi e comunicativi. Ma nel linguaggio umano i suoni diventano parole evocatrici d’immagini.
Scarica gratis: Il linguaggio umano nella sua essenza universale e nella storicità dei suoi aspetti di Vittorio Bertoldi.