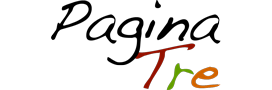Attilio Momigliano è stato certamente tra i critici che nella prima metà del XX secolo più attivamente e proficuamente si sono occupati dell’opera di Carlo Porta. In questo studio, pubblicato, in seconda edizione largamente riveduta, nel 1923 nella nota collana “Profili Formiggini”, Momigliano sottolinea in primo luogo la volontà del Porta di inserirsi nella tradizione della grande poesia in dialetto milanese, che pure annoverava già nella seconda metà del Settecento autori notevoli come Carlo Maria Maggi o Domenico Balestreri autore di una famosa traduzione in dialetto della Gerusalemme liberata (testo che è stato recentemente rieditato a cura di Felice Milani).
Ma la peculiarità e la forza di Carlo Porta risiede nella raffinatezza stilistica abbinata a strutture narrative solide. Le sue opere migliori sono infatti vere e proprie novelle in poesia, e per questo si avvale da un punto di vista metrico della sestina e dell’ottava. Momigliano rileva come Porta, figlio della tradizione illuministica lombarda, parta da un presupposto razionalistico dal quale scaturisce un impegno civile e sociale più che politico: suo obiettivo è mettere al centro della propria opera, e portare così alla ribalta della letteratura e della storia, i “poveritt” cioè quella parte della piccola borghesia e del popolo abituato a subire senza mai osare una ribellione. In questo senso l’uso del dialetto diventa una necessità, lo strumento più efficace per esprimere i sentimenti reali dei protagonisti delle sue storie. Scelta difesa nella polemica con Giordani sull’uso del dialetto e senza mancare l’occasione di indirizzare al Giordani stesso dodici sonetti satirici. Momigliano sottolinea la vena satirica di Porta indirizzata soprattutto in direzione di nobili e preti e conclude per una sostanziale unità d’ispirazione dei due “filoni” satirici:
«In fondo nel Porta la rappresentazione delle nobili e dei preti costituisce un tutto solo. Nell’insieme il meglio della grandezza portiana consiste nell’aver dato forme artistiche a questo mondo retrivo, trasfondendovi le sue idee senza tradurle direttamente nella solita sentenziosità della maggior parte dei satirici.»
E individua anche la composizione poetica dove questa mirabile sintesi satirica raggiunge la sua vetta:
«questo sonetto [Sonettin col covon] ha un’importanza grandissima perchè esso contiene l’idea da cui scaturisce tutta la sua satira antinobiliare, anticlericale ed anticlassicista, e dimostra la salda unità del suo spirito satirico.»
C’è da sottolineare che Momigliano contesta con decisione l’ascendenza dell’ispirazione di Carlo Porta da Giuseppe Parini – pur essendo evidente una certa sovrapposizione in una sua poesia con la “vergine cuccia” pariniana –. Il confronto con Parini – dice Momigliano – è consueto ma inutile: la sola fonte di Porta è la vita dei suoi tempi. Ci sono tuttavia tre autori che Momigliano cita nei quali trova una sorta di collegamento con l’opera di Porta: il primo è Maupassant per il quale Porta è identificato come una sorta di precursore:
[…] eravamo ancora molto lontani dal realismo e dalla pornografia profondamente morale del Maupassant, e nessun grande artista ci aveva ancora insegnato a veder la tristezza della così detta vita allegra, a sentire un palpito umano sotto carni logorate da abitudini immonde.»
il secondo è Friedrich von Hagedorn
«Gli stessi caratteri milanesi sono in «On striozz» – un racconto tradizionale, attinto più direttamente dal Hagedorn, dove tutto è diventato meneghino e portiano –»
e il terzo è Stendhal:
«Non si poteva meglio rappresentare quello che appunto ai tempi del Porta lo Stendhal notava nei nobili: l’avarizia”».
In tutti i casi Momigliano sottolinea sempre con forza l’originalità dell’ispirazione del poeta milanese, per il quale riesce a delineare anche con chiarezza la sua posizione verso la religione; la satira anticlericale ebbe sempre un carattere più morale che religioso, e la posizione religiosa che ne emerge è quella liberata da ogni superstizione, vista nell’ottica illuminista; non c’è accanimento (come per esempio nella poesia romanesca di Gioachino Belli) riguardo ai principi della fede, ma solo contro i falsi credenti e le strumentalizzazioni politiche della religione. Ciò non impedì tuttavia al canonico Luigi Tosi di censurare vergognosamente – sui manoscritti – i passi della poesia di Carlo Porta che gli parevano contrari all’ortodossia.
Il testo di Momigliano è corredato in appendice di una bibliografia delle opere di e su Carlo Porta, ovviamente fino al 1923. Oggi ne abbiamo a disposizione certamente altre e più complete, tra le quali l’edizione curata da Dante Isella che è presente in questa biblioteca Manuzio (https://liberliber.it/autori/autori-p/carlo-porta/poesie/).
Dice infine Momigliano:
«[…] egli contribuì potentemente, prima del Manzoni, a liberar la nostra letteratura dalla retorica.»
A proposito di Manzoni mi sembra giusto ricordare che lo stesso, indirizzando una lettera a Fauriel il 23 gennaio 1821, elogiando il Porta e il suo “talent admirable” aggiungeva il rammarico che gli fosse mancata «une langue cultivée pour placer celui qui la possédait absolument dans les premiers rangs». Oggi che la questione della lingua, almeno nei termini che tanto stavano a cuore al Manzoni, può dirsi superata, possiamo senza dubbio indicare Carlo Porta tra i massimi poeti italiani della sua epoca e il breve testo di Attilio Momigliano gli rende pienamente giustizia.
Sinossi a cura di Paolo Alberti
Dall’incipit del libro:
Per molti anni anche il centro di Milano, come altre parti della Lombardia, ebbe un caratteristico poeta della strada: il bosin. Recitava i versi più prosaici che abbia mai fatto il popolo italiano, ma era una figura singolare. Era, più che un cantastorie, un cronista ora della politica, ora dei pettegolezzi, e soprattutto la voce dello spirito lombardo inclinato alla satira morale e alla caricatura. Invasioni, mutamenti di governo, feste pubbliche, soprusi, tendenze retrograde e tendenze progressiste, abiti scollacciati o troppo vistosi, costumi lascivi, amor del lusso e della bettola, tutti i motivi grandi e piccoli che potevano offrire argomento di biasimo, passavano ne’ suoi distici quasi sempre zoppi e mal messi come il cantore che li andava ripetendo sull’angolo delle vie e che un oscuro tipografo ritraeva rozzamente sul frontispizio della bosinada.
Ora il centro di Milano non ha più nessuna caratteristica sua, e anche il bosin è confinato nei quartieri popolari. Ma nell’ultimo quarto del secolo decimottavo, quando nacque Carlo Porta, il bosin era ancora un’istituzione; e forse non fu mai così fecondo come tra la fine del 700 e il principio dell’800, quando visse il maggior poeta meneghino.
Scarica gratis: Carlo Porta di Attilio Momigliano.