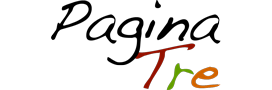Intervista a Lanfranco Moder Vicari, co-direttore artistico del Grande Teatro di Lido Adriano che porta in scena il poema indù
Un inno alla pace, un rito collettivo; quello di un teatro che continua ad interrogarsi sulle motivazioni da cui scaturiscono le guerre attraverso la riflessione induista, passando per Simone Weil. Un coro capace di incrociare le suggestioni sonore orientali a quelle del rap che “come una bacchetta incantata dirige la marea”.
Le energie maturate nell’ambito del Cisim di Lido Adriano, trasformatesi, a partire dal 2023, grazie ai direttori artistici Luigi Dadina e Lanfranco Moder Vicari e al drammaturgo algerino Tahari Lamri, in un’esperienza di teatro comunitario, giungono al terzo anno di vita, portando in scena la Bhagavadgītā, Il canto del divino, testo sacro indiano composto in sanscrito tra il III secolo a.C. e il I secolo d.C.

Un poema epico in circa 700 versi che parla di senso del dovere e necessità di distacco dai desideri personali, focalizzato sul dialogo tra il Krishna, divinità suprema, e il guerriero Arjuna, nel momento in cui questi sta per iniziare il combattimento contro la fazione nemica, nella Battaglia di Kuruksetra, dove dovrà uccidere anche membri della sua stessa famiglia che sono tuttavia usurpatori.
A interpretare i due personaggi, non sono stati scelti due attori ma la stessa comunità teatrale composta da 80 persone, attori professionisti e non, di ogni nazionalità, età e background culturale, guidati secondo le modalità attinte dalla pluridecennale esperienza del Teatro delle Albe di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Il lavoro finale è frutto di un’intensa attività laboratoriale dove i ruoli tra chi dirige e viene diretto sfumano sempre di più, come racconta Lanfranco Moder Vicari, che abbiamo intervistato in occasione del debutto il primo giugno scorso.
Come è nata l’idea di portare in scena la Bhagavadgītā e come si è sviluppato il progetto?
L.M.V.: “Il testo è stato scelto dal regista Luigi Dadina e dal drammaturgo Tahar Lamri durante il debutto dello spettacolo dell’anno scorso, il Panchatantra, che era una raccolta di favole in lingua indiana poi tradotta in arabo. Questo invece è un testo sacro che Tahar ha riscritto in alcune parti per renderlo più accessibile. Dopodiché tra noi è iniziato un carteggio e il progetto è maturato in corso, concomitante alle novità che stavano accadendo all’interno della comunità del Grande Teatro.
Tra queste il consolidamento della collaborazione artistica di Spazio A, formato dagli artisti Camilla Berardi, Marco Montanari e Marco Saccomandi che collabora con noi fin dall’inizio e ora è passato all’aiuto-regia.
Da poco, inoltre, è nata la Brigata artistica solidale composta da una ventina di partecipanti di età compresa tra i 20 e i 70 anni con funzioni organizzative, permettendo una sorta di decentramento, oltre ad aggiungere al lavoro finale il contributo di sensibilità diverse.
Una di loro, ad esempio, Elena, concepiva il testo come guerrafondaio. Krishna in effetti invita Arjuna a non ritirarsi dal conflitto e ad adempiere al suo dovere, ma questo non significa giustificare la guerra. Il testo indiano affronta questioni esistenziali come il conflitto tra dovere e compassione, il rapporto tra individuo e universo, temi che rimangono tuttora attuali. Abbiamo quindi collegato questo aspetto a quello della Resistenza in Italia durante la seconda guerra mondiale e agli importanti sbocchi istituzionali che hanno portato alla stesura della Costituzione.

Nel condurre i laboratori, poi, ci siamo accorti che ai bambini potevano essere affidate le parole sagge del Krishna e agli adolescenti e adulti invece, quelle del guerriero Arjuna. È stato bello notare come i più piccoli pronunciassero con tanta naturalezza frasi impegnative e filosofiche, che sentivano proprie pur non avendo la maturità intellettuale per comprenderne completamente il significato, mentre la volontà di prevalere, il senso di ingiustizia e di rivalsa erano decisamente più nelle corde dei grandi.
Abbiamo scelto anche di non risolvere il testo, sia perché la Bhagavadgītā è un testo che porta a riflettere sulle illusioni umane quando si inizia una guerra, che è quella di proiettare sull’altro i propri conflitti interiori, sia perché non crediamo avesse molto senso mostrare scene di guerra e violenza.

I due schieramenti rimangono divisi dal fiume che è rappresentato dal pubblico che assiste. Una scelta legata all’individuazione dell’acqua come elemento cardine, sia dello spettacolo sulla guerra, sia del Grande Teatro di Lido Adriano in sé che è nato proprio nel 2023, anno dell’alluvione, che ci ha rimandato al senso di distruzione e di morte che abbiamo visto intorno a noi e alla paura di non poter più proseguire con lo spettacolo. Diciamo che nel nostro territorio l’alluvione è stato l’elemento che più ci ha avvicinato alla sensazione della guerra, che non abbiamo più vissuto da 80 anni”.
I partecipanti allo spettacolo però provengono da varie parti del mondo dove purtroppo i confitti ci sono
L.M.V.: “Sì, quest’anno abbiamo una ragazza ucraina fuggita dalla guerra e due ragazzi tunisini con vicissitudini drammatiche nella loro rocambolesca esperienza per raggiungere le coste italiane. Abbiamo poi, come già nei due anni precedenti, i partecipanti della Cooperativa sociale Teranga, ospitati nei Centri di accoglienza, che dobbiamo ringraziare per la forte esperienza che ci regalano tutte le volte, per la loro disponibilità ad affidarsi a noi, pur non comprendendo la lingua. Quest’anno molti di loro vengono dal Bangladesh, anche questo un Paese attraversato da conflitti e ingiustizie”.

Parliamo delle musiche, adesso, che sono state composte da Francesco Giampaoli. Tu come hai sviluppato i testi?
L.M.V.: “È stato complicato adattare il testo di una canzone su un testo sacro-filosofico, soprattutto perché non avevo immagini di riferimento a cui ispirarmi. Nel 2023, con il testo sufi del persiano Farid-Ad-din-Attar Il verbo degli uccelli c’era il tema del volo; nel Panchatantra, l’anno scorso, c’erano le favole.
Nella Bhagavadgītā l’immagine-simbolo è quella del dialogo tra il guerriero e Krishna. Abbiamo quindi deciso che a Jessica Doccioli, la cantante, si sarebbero assegnate le parti del Krishna mentre le mie, quelle rap, sarebbero state di Arjuna. Fondamentale poi la parte del coro che si è ampliato, passando a 16 componenti e assumendo un ruolo molto più rilevante.
Riguardo le musiche, Francesco Giampaoli, dopo una gestazione di diversi mesi in cui ha le ha composte, ispirandosi alle sonorità indiane, ce le ha inviate. A quel punto il lavoro si è sviluppato su due livelli: da un lato, considerando, come accennavo prima, il ruolo del coro, e dall’altro, dandolo in pasto alla band con un altro tipo di impatto. Quest’anno il primo pezzo che canto, una volta aperto lo spettacolo, recita così: Ogni volta si parte da zero/nel nulla che chiami mistero”.

Rispetto a tre anni fa, quando è nato il Grande Teatro di Lido Adriano, cosa si è evoluto e cosa è rimasto uguale?
L.M.V.: “Per me rimane sempre un’esperienza umana e artistica molto forte, come all’inizio. Credo sia lo stesso anche per molte altre persone e che anzi, si possa dire che si sia evoluta l’esperienza di teatro comunitario diventando un vero e proprio organismo, in cui tutti, anche chi non partecipa allo spettacolo, ma rimane dietro le quinte, è una parte fondante di quello che accadrà sul palco.
Avviene grazie ad un’autorganizzazione molto profonda dei partecipanti. Molti di loro, ad esempio, hanno deciso di prendere le ferie dal lavoro per potersi dedicare allo spettacolo e mettendo a disposizione le proprie competenze. Credo che rispetto al primo anno ci sia una maggiore motivazione. Per molti questa è una seconda famiglia, dove poter però parlare un’altra lingua, uno spazio per conoscersi fino in fondo”.

Come riuscite ad entrare in sintonia con così tante persone diverse tra loro?
L.M.V.: “Più di tutto aiuta ascoltarsi, non pretendere che la comunità esista o lavori per noi. Quando tutto è impostato secondo il principio che ognuno darà ciò che può e nel modo in cui può, tutti i tasselli vanno a posto in modo spontaneo.
Questo aspetto influisce su due livelli nello spettacolo: da un lato, c’è una cura in ogni aspetto di quanto sarà portato in scena. Ad esempio nella parte musicale, che quest’anno ha lavorato con un gradiente di professionalità che non era per niente scontato, fa sì che si possa tendere verso mete ambiziose, verso quella che è la verticalità artistica.
Dall’altro, il fatto che molti siano attori non professionisti e che tuttavia si impegnino a dare il massimo, fa sì che si crei un forte senso di appartenenza per cui l’andare in scena, che rappresenta un salto nel vuoto, nel caso si cada, si cade tutti insieme. Questo accentua la dimensione orizzontale e comunitaria, che non fa perdere di vista i propri limiti”.
Veniamo alla parte scenografico-illustrativa curata da Nicola Montalbini e Silvia Montanari. Si è parlato di una sorta di stratigrafia delle immagini disegnate sullo sfondo, in modo da dare continuità anche sul piano visivo
L.M.V.: “Esatto, in tutte e tre le edizioni, dell’illustrazione non viene distrutto nulla completamente. Alcune parti, quando lo spettacolo finisce, vengono lasciate di proposito. Dalle edizioni precedenti ad esempio sono rimasti alcuni uccelli creati dai bambini graffiando sul muro, mentre quest’anno abbiamo lasciato l’immagine del Krishna che con un piede distrugge e dall’altro c’è la natura che ricresce, secondo il concetto del Samsara per cui tutto nel cosmo è un continuo susseguirsi di nascita, morte e rinascita, in un ciclo senza fine”.
Le suggestioni orientali sono molto forti, tant’è che si può parlare di una vera e propria trilogia. Continuerete ancora in questa direzione in futuro?
L.M.V.: “Stiamo pensando ancora all’Oriente, soprattutto nella dimensione del viaggio non solo spirituale e artistico, ma anche fisico in senso stretto, o forse anche nel senso di un ritorno, accorgendoci di quanto lo sguardo sul mondo da quella direzione sia molto efficace, ma ovviamente per adesso è ancora tutto in divenire”.
a cura di Anna Cavallo