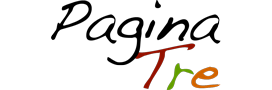L’opera teatrale Alcibiade di Felice Cavallotti è un dramma storico che si concentra sulla figura complessa e controversa di Alcibiade, l’eminente statista, oratore e generale ateniese vissuto nel V secolo a. C., due volte esiliato e due volte richiamato come salvatore di Atene. Cavallotti, noto per il suo impegno politico e per i suoi ideali democratici, utilizza la figura di Alcibiade per esplorare temi universali come l’ambizione, il tradimento, l’esilio, la fede politica e il conflitto tra individuo e Stato.
Il dramma si articola attraverso le fasi salienti della vita di Alcibiade, evidenziandone la straordinaria ascesa e la successiva caduta rovinosa. L’opera lo ritrae inizialmente come un giovane brillante e carismatico, pupillo di Pericle, amato dal popolo ateniese per le sue doti intellettuali e militari. La sua presunzione e la sua eccessiva sicurezza nelle proprie capacità, tuttavia, prefigurano la sua tragedia.
Nella sua spiritosa prefazione, Cavallotti racconta le circostanze – la latitanza per sfuggire ad un arresto per le sue opinioni politiche – in cui lavorò all’opera, e attesta con precisione che la stesura fu terminata “ai trentuno di agosto alle quattro in punto” del 1873. Dopo qualche rifiuto, l’opera fu rappresentata il 31 gennaio 1874 al teatro Manzoni di Milano, e non ebbe il successo in cui l’autore sperava. Lo stesso anno, Cavallotti pubblicò un libello Alcibiade, la critica e il secolo di Pericle : Lettera di Felice Cavallotti a Yorick figlio di Yorick, già presente nella nostra biblioteca, in cui difendeva la sua opera dalle numerosi e feroci critiche ricevute. Più tardi (1884) preparò un’edizione “per la stampa” dell’opera, che è quella che presentiamo, rimaneggiata ed arricchita da un ricchissimo apparato di note.
Questa seconda edizione differisce significativamente dalla precedente perché nello stesso testo l’autore ha potuto approfondire la narrazione recuperando anche parti che aveva dovuto sacrificare nella versione destinata alle scene teatrali. L’autore diffida esplicitamente chiunque a servirsi di questa nuova versione per la rappresentazione dell’opera. Ma la macroscopica differenza è la presenza di note, che in volume pareggiano quasi il testo teatrale e che oltre a descrivere il contesto storico in cui si svolge la vicenda biografica dell’eroe, sono preziose per le indicazioni sulla vita e cultura di Atene e della Grecia in generale all’epoca di Socrate. Personalmente ho apprezzato più la lettura delle note che non quella del dramma. Non mancano i commenti politici sulle azioni di Alcibiade, che l’uomo politico Cavallotti utilizza – in maniera sottintesa – per tracciare paralleli tra le vicende dell’antica Atene e la situazione politica italiana o europea del XIX secolo.
Sinossi a cura di Claudio Paganelli
Dall’incipit del libro:
Quanta parte della vita ateniese, quante memorie in questa parola! In Atene, ove leggi e costumi creavano alla donna di famiglia, nel chiuso de’ ginecei, posizione poco dissimile da quella che l’Oriente le assegna ancor oggi nel fondo degli harem, ‒ ove il genio del popolo e il cielo e il clima prepotenti portavano al culto del bello e della Venere sensuale, ‒ la cortigiana doveva naturalmente invadere ed occupare essa sola tutto il posto, o quasi, che nella civiltà di un popolo spetta al sesso più gentile. Un posto ben importante, perchè potesse esser degno di Aspasia! Gli affetti della famiglia, santi a Sparta (alla maniera de’ tempi), e santi a Roma, lasciano luogo, fra le tepide notti del cielo jonico, ad affetti più liberi: le Andromache, le Penelopi, le Antigoni già sono d’altri lidi e d’altre età; argomento di meraviglia ai licenziosi figli dell’Attica le mogli spartane, dominatrici dei terribili mariti, giusta il vanto della sposa di Leonida; e la storia che scrive in pagine d’oro i fasti delle madri e delle spose in riva al Tevere e all’Eurota, dimentica e sopprime, come tampoco non esistesse, la donna di famiglia nel quadro della città e del secolo di Pericle. Ella ci conserva cinti d’aureola il nome della madre dei Gracchi e della madre di Bràsida; narra ai secoli la virtù conjugale di Porzia e di Chelonida; ma non si ricorda in Atene della donna di famiglia che, tutt’al più, per tramandarci il tipo della moglie bisbetica e insopportabile, in quella Santippe che il buon Socrate si teneva per esercitarsi alla virtù della pazienza.
Scarica gratis: Alcibiade di Felice Cavallotti.