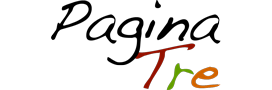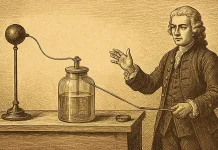Nel 1923 Guglielmo Ferrero raccolse in volume gli articoli che aveva scritto a partire dal 1919 su «Il Secolo», quotidiano democratico milanese, e su alcune riviste estere («L’illustration», «Revue Universelle» e «Heart’s Magazine») a proposito delle conseguenze della Prima guerra mondiale e dei trattati di pace, in particolare del trattato di Versailles.
L’autore sin dai primi articoli, scritti quando ancora la conferenza di Versailles non era ancora conclusa, esprime il suo profondo timore e la sua disapprovazione per gli esiti della Prima Guerra Mondiale e per le condizioni imposte alla Germania con il Trattato di Versailles.
Ferrero analizza come la fine del conflitto e la scomparsa dei grandi imperi (austro-ungarico, ottomano, russo e tedesco) avessero alterato l’equilibrio europeo in modo pericoloso. La sua tesi centrale è che le umilianti e punitive condizioni dettate a Versailles abbiano gettato le basi per nuove instabilità e conflitti, anziché garantire una pace duratura.
L’autore critica la miopia politica dei vincitori, (e in particolare dei loro leader: Clemenceau, Lloyd Gorge, Wilson e Vittorio Emanuele Orlando) sostenendo che la pace imposta, con l’eccessiva severità delle condizioni e l’abbandono dei principi di giustizia fosse più una “tragedia” che una vera soluzione, in quanto non teneva conto delle conseguenze a lungo termine sul piano geopolitico e sociale. Contemporaneamente, il rifiuto dell’Inghilterra di rinunciare al suo dominio sui mari causò l’irritazione degli Stati Uniti e fu una delle cause del suo precoce disimpegno dagli affari europei e del fallimento della Lega delle Nazioni.
Come sappiamo, purtroppo le pessimistiche previsioni dell’autore si sono pienamente realizzate: il risentimento tedesco ha portato dieci anni dopo all’ascesa del Nazismo ed in seguito ad una nuova guerra, peggiore di quella da cui l’Europa era appena uscita.
Sinossi a cura di Claudio Paganelli
Dall’incipit del libro:
La rivoluzione francese fu definita da Napoleone: «una idea che avrebbe trovato milioni di baionette». Noi potremmo capovolgere il motto e definire la guerra mondiale: «milioni di baionette che cercano un’idea».
Una bella mattina, due mesi fa, ci siamo risvegliati in pieno ’48. Non è la repubblica del ’48, con il suo berretto frigio, la gonna e la giubba plebea, il codazzo di operai vocianti e di vessilli scarlatti, quella che si fa avanti nel cuore dell’Europa, tra le rovine fumanti degli imperi germanici? La bandiera rossa che sventola sul palazzo di Potsdam e sul castello di Schoenbrunn non è quella che gli operai di Parigi offrirono, nei primi giorni di marzo del 1848, alla Repubblica francese e che Alfonso Lamartine non osò innalzare sull’Hôtel de Ville? Di sotto ai rottami dei due imperi sfasciati, non sbucano forse al sole, liberi alla fine, i popoli e le città che il ’48 aveva tentato di redimere dal servaggio moscovita, austriaco o prussiano: la Polonia, l’Ungheria, la Boemia, Trieste? L’aquila bianca non ritorna a fare il nido nelle foreste della Polonia e il tricolore non sventola sulla vetta delle Alpi Giulie? Non sono fuggite ventiquattro dinastie; e i soldati, reduci dal fronte, non alzano sulle proprie spalle, acclamandolo sovrano del mondo, il suffragio universale? In mezza Europa la Rivoluzione convoca uomini e donne, ricchi e poveri, dotti e ignoranti, a darsi una libera legge.
Scarica gratis: La tragedia della pace di Guglielmo Ferrero.