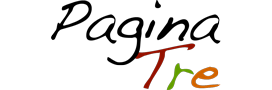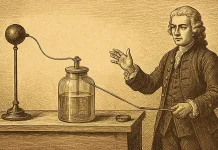Nel 1945 nei «Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà» venne pubblicato per la prima volta il testo di Dante Livio Bianco Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese, una documentazione vivissima del periodo di partigianato vissuto in montagna da lui e dai suoi compagni, tra tutte le difficoltà di una vita durissima, tra continui rastrellamenti da parte dei nazifascisti e nel gelo di due inverni rigidissimi. Il partigiano Livio aveva tenuto, fin dal 9 settembre 1943, un diario dettagliato e puntuale di ogni evento di cui era stato testimone e su questo diario si basa Venti mesi... Questa opera venne ripubblicata all’inizio del 1946, a Cuneo da Panfilo (Arturo Felici), uno dei partigiani che possedeva una tipografia. Emilio Lussu e Gaetano Salvemini, tra gli altri, ne applaudirono la semplicità, l’efficacia, l’antiretorica. Venti mesi… fu poi pubblicato da Einaudi nel 1954 nel volume Guerra partigiana, raccolta di scritti a cura di Giorgio Agosti e Franco Venturi. Questa edizione contiene anche il citato diario in cui Bianco annotò quasi ogni giorno minuziosamente i fatti notevoli dal 5 novembre 1943 al febbraio 1945 e lettere alla moglie e ad amici combattenti, rapporti di guerra e altri scritti d’argomento partigiano. Infine Venti mesi… venne riedito, sempre da Einaudi, nel 1973 in Guerra partigiana, con Premessa di Norberto Bobbio e Introduzione di Nuto Revelli, che è l’edizione da cui abbiamo prodotto questo eBook di Liber Liber.
Nelle Avvertenze, Bianco si scusa per eventuali inesattezze perché il testo, scrive, è stato redatto per la massima parte a memoria. Ma sappiamo appunto che egli aveva tenuto un diario minuziosissimo degli eventi e delle dure condizioni; tuttavia è probabile che non sia stato in grado di contattare altri che erano stati presenti e di riportare le loro testimonianze. Revelli nella ricca ed interessante Introduzione (1973) – che però non comparirà in questo ebook di Liber Liber perché ancora sotto copyright – dà un vivissimo quadro del carattere di Bianco.
Teatro delle vicende narrate è solo un’area del Cuneese, de La Granda, provincia così chiamata perché è la più vasta del Piemonte e una delle maggiori d’Italia. La zona di azione della partigianato cuneese fu incentrata nelle valli verso la Francia che circondano la città: l’area, chiusa a sud dalla Valle Pesio e a nord est dalla Valle Varaita, comprende, in senso orario, la Valle Vermenagna, la Valle Gesso, la Valle Stura, la Valle Grana e la Valle Maira. Queste sette splendide valli furono il luogo in cui fortissima agì la Resistenza a partire dal 9 settembre 1943.
Già l’avvocato Duccio Galimberti (1906 – 1944), che sarebbe diventato la figura più importante della Resistenza in Piemonte, il 26 luglio di quell’anno dal balcone del suo studio, affacciato sulla grandiosa piazza che poi avrebbe preso il suo nome, in un memorabile discorso “aveva proclamato la necessità della guerra immediata alla Germania nazista”.
Bianco cita l’opera e l’insegnamento del suo omonimo Carlo Bianco (in Della guerra nazionale d’insurrezione per bande applicata all’Italia, da un Amico del Paese, Italia 1830, di Carlo Bianco, presente in Liber Liber), per ribadire che:
«prese conclusivamente corpo il proposito sino allora perseguito solo in via eventuale, di dar vita alla resistenza armata «irregolare», a quella che già più di un secolo fa uno scrittore piemontese chiamava la «guerra per bande».»
Quello che soprattutto emerge, almeno all’inizio, è la diversità di atteggiamento nell’impostazione della guerra partigiana: da una parte i partigiani della zona di Boves, definiti i «militari», perché provenienti in maggioranza dai ranghi militari e più legati quindi alla disciplina e alla catena di comando; dall’altra i cosiddetti «politici», attendati all’inizio in Valle Stura, prima a Madonna del Colletto e poi nella borgata Paraloup, dove diedero vita alla Banda «Italia Libera». Di questa seconda ‘anima’ della resistenza cuneese facevano parte Galimberti, Bianco, poi Nuto Revelli e tanti altri che venivano dagli ambienti più disparati: operai, contadini, studenti, professionisti… I ‘politici’ erano meno inquadrati ma particolarmente attenti all’aspetto politico dell’azione: chiunque facesse parte di «Italia Libera» doveva avere perfetta conoscenza di ciò che stava accadendo in Italia, di chi fossero realmente i nemici, degli alti fini di democrazia e libertà che ci si proponeva. E fu questa forza morale che aiutò il gruppo di Bianco a superare tutte le difficoltà.
Insito negli ideali di democrazia e libertà è anche un forte sentimento europeista:
«Siamo contro tutti i nazionalismi e gli imperialismi e, senza per nulla rinnegare l’alto valore umano e storico dell’ideale nazionale e della tradizione patriottica italiana, auspichiamo una federazione di liberi popoli del nostro continente, che lasciando intatta nei tratti essenziali la fisionomia delle singole nazioni, realizzi una vera comunità europea, sola via per assicurare una pace duratura e garantire le migliori possibilità di progresso.»
L’8 giugno del 1947 alla città di Cuneo fu conferita “la medaglia d’oro per il ruolo, da essa gloriosamente sostenuto, di roccaforte, di base di operazioni e di capitale del partigianato.”
Consiglio due video molto interessanti, che illustrano il tema del partigianato nel Cuneese:
- Nella serie «I giorni della montagna», è il video Nascita di una formazione partigiana, 1973. Realizzato dal regista Ermanno Olmi e dal giornalista Corrado Stajano, il documentario racconta la nascita di uno dei primi nuclei partigiani nati nel Nord Italia, «Italia Libera», ad opera di Galimberti e Bianco. – https://www.raiplay.it/video/2022/04/Nascita-di-una-formazione-partigiana-241121b6-2185-475b-b397-a8c12d15dad0.html
- L’altro video, del 2019, dal titolo Italia Libera – Storia di una formazione partigiana, ricostruisce la storia di «Italia Libera», dal 9 settembre 1943 alla Liberazione, anche nei suoi rapporti con le popolazioni locali. Nel video sono presentate anche immagini dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e delle Teche RAI. – https://www.raiplay.it/video/2019/04/La-Grande-Storia-Anniversari-La-Liberazione-ad255a77-3d34-4829-94dd-7dd5d2663c27.html
Sinossi a cura di Claudia Pantanetti, Libera Biblioteca PG Terzi
Dall’incipit del libro:
Il 9 settembre ’43, Cuneo presentava un aspetto di estrema animazione. Vi concorreva non solo l’atteggiamento della popolazione che, data l’eccezionalità dell’avvenimento, era tutta fuori, per le strade, avida di notizie e come presa da oscuri presagi, ma anche, e soprattutto, d’intenso e continuo movimento di autocolonne della IV Armata, che arrivavan dalla Francia e riempivan di truppe la città.
Già fin dalla mattina, per quanto ancor nulla di preciso si sapesse sulle intenzioni e sulle iniziative dei tedeschi, la nota psicologica dominante era stata quella del disorientamento e della preoccupazione: e questa sensazione andava sempre piú confermandosi. C’era per aria un senso di disagio, di incertezza e di timore. La situazione appariva confusa, e man mano che l’afflusso dei militari procedeva, il disordine aumentava. Era abbastanza chiaro, oramai, che non si trattava d’un ordinato ripiegamento, di movimenti predisposti e controllati e diretti, in vista di un qualche organizzato allineamento difensivo. In realtà, i comandi non avevano alcuna idea sul da farsi, e non facevano niente di concreto: si lasciavano andare, e s’abbandonavano anch’essi alla corrente, con una passività ed una rassegnazione impressionanti. Venuto il momento della prova suprema, giunta l’ora delle grandi decisioni, in cui, con o senza ordini superiori, bisogna essere pronti a battersi e, semmai, a morire, tutto l’imponente e perfetto apparato militare si inceppava.
Scarica gratis: Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese di Dante Livio Bianco.