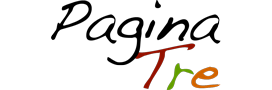L’attività saggistica di D’Arzo è, almeno in una certa misura, riconducibile al suo legame con Emilio Cecchi e in particolare con il testo di quest’ultimo Scrittori inglesi e americani. In questi suoi saggi Cecchi indica Conrad, James, Stevenson – e con particolare forza per quest’ultimo – come esempio e modello di sintesi tra l’immaginario e l’attenzione per la realtà, per il vero.
Se si tengono presenti alcune opere narrative di D’Arzo – penso in particolare a Un ragazzo d’altri tempi – vediamo come il modello di identificazione proposto da Cecchi, che vede centrale la figura del padre assunta come riferimento ideale di identificazione da parte del figlio, venga assunto come proprio tentativo di colmare un vuoto che D’Arzo sentiva in maniera prepotente. Per il padre di Oliviero – protagonista dell’opera sopra citata – l’adesione alla letteratura inglese è soprattutto una scelta umana, che si sfuma con altri elementi ironici proposti da Cecchi che vanno dal fascino al rifiuto, ricordando così le condizioni del rapportarsi alla figura paterna. Scrive D’Arzo in questo suo racconto riferendosi al padre:
«uomo assai colto, di molto spirito, spesso anche finemente ironico (ma più tardi mi accorgerò che questa è la sua unica arma per difendersi e celare la sua fondamentale timidezza): egli ha una predilezione affatto particolare per la letteratura inglese, trovando in essa (a prescindere dai valori artistici) doti di virilità e di fermezza che non si riscontrano in alcun’altra: egli ammira i personaggi delle opere inglesi (anche con quel tanto di convenzionale che tutti essi hanno) come in genere si ammira tutto ciò che noi non potremo mai essere, e perché questi modelli sono immensamente lontani da quelli che egli vede giornalmente per le nostre strade».
L’attività critica di D’Arzo non è certo fondata su una minuziosa analisi di scomposizione e ricomposizione degli scritti degli autori che prende in esame. Anche nella critica prevale in lui la fantasia e il tumultuare delle sensazioni: in altre parole, emerge in questi suoi scritti la sua vena di narratore. In questi saggi quindi non possiamo mancare di riscontrare la sua identità di scrittore che traduce le sue tecniche narrative in ambito saggistico.
D’Arzo volle dare visibilità alla traduzione saggistica delle sue passioni letterarie nel 1945, con tanti inediti nel cassetto e una pubblicazione – All’insegna del buon Corsiero – alle spalle. La scelta dell’editore al quale rivolgersi non fu difficile, in quanto Guanda era già stato interpellato, e le sue reazioni non erano state sfavorevoli, in merito alla pubblicazione di novelle e racconti vari, in particolare L’Osteria per il quale c’era un progetto di pubblicazione. Il primo giugno 1945 esordiva a Parma, editore e direttore proprio Guanda, il periodico “Il Contemporaneo” che accolse quindi con favore le collaborazioni di D’Arzo. Il periodico in questione andava a genio a D’Arzo perché non particolarmente impegnato ideologicamente – anche se non mancava di trasparire l’adesione a un certo solco che tradizionalmente andava dipanandosi tra l’esperienza gobettiana e quella del Partito D’Azione – e perché determinato a riservare alla parte letteraria il compito trainante per la rivista stessa. Non a caso Guanda affidò quasi subito a D’Arzo la responsabilità di selezionare il materiale letterario riservato al periodico.
Il primo saggio pubblicato su “Il contemporaneo” è Invito a Conrad che fu diviso in due puntate tra il dicembre 1945 e il gennaio 1946. Seguono poi i saggi sullo shakespeariano Polonio, sul Robinson di Defoe, su Kipling che rimase fermo alla prima puntata a causa della cessazione della rivista. I saggi di D’Arzo vengono quindi pubblicati prima su il “Ponte” – che ristampa il saggio su Conrad – e subito dopo su “Paragone” diretto da Roberto Longhi il quale per D’Arzo era un punto di riferimento culturalmente importante. La sezione letteraria del periodico ben s’intonava con l’eclettismo caro a D’Arzo, indulgendo a toni intimistici non lontani dalle esperienze dell’ermetismo; non a caso tra i collaboratori figuravano Bo, Macrì, Luzi, Bigongiari. Troviamo quindi i saggi su Stevenson, James, Lawrence. Altri saggi vengono pubblicati su alcuni quotidiani come “Il gazzettino di Venezia”, “Il giornale dell’Emilia” e altri. Il saggio su Maupassant, che chiude questa raccolta, comparve nel 1952 su “Il Raccoglitore”, supplemento quindicinale delle lettere ed arti della “Gazzetta di Parma”.
Prosegue con questi saggi, composti e pubblicati tra il 1945 e il 1952, la lettura di D’Arzo degli scrittori anglo-americani e francesi che rispecchia il suo gusto e il suo estro da narratore più che da critico; sembra quasi che, parlando degli scrittori dei quali tratta, si rispecchi in questi e nei loro personaggi cercando elementi di identificazione soprattutto con la solitudine della propria coscienza. Questa sua attitudine all’identificazione lo porta comunque a risultati eccellenti. Va ricordato almeno, per non dilungarsi troppo, la lettura che D’Arzo offre per il Robinson di Defoe. Qui non viene certamente rifiutata la condizione solitaria in quanto tale ma piuttosto la “moda” della solitudine, la facile libertà collegata a un naturismo snobistico e – oggi più che mai – di massa.
Emerge quindi una visione del Robinson molto diversa da quella offerta, per citare i più famosi, da Marx nel Capitale, da Joyce nell’Ulisse, da Virginia Woolf nella Signora Dalloway. Troviamo se mai ripresa l’interpretazione darziana da Piero Citati (in Il té del cappellaio matto) dove il romanzo di Defoe viene definito non certo come il libro in cui «il meraviglioso viene addomesticato, contabilizzato», ma «una lunga, grave, disperata interrogazione intorno ai misteri della Provvidenza”. In questo Robinson, come anche in altri personaggi di romanzi dei quali D’Arzo tratta in questi saggi, possiamo trovare quello che a ciascuno di noi probabilmente è capitato nei momenti di possibile incomprensione della vita. Quando la distanza che riscontriamo con il prossimo, anche se apparentemente minima, diviene invece un mare con insormontabili onde e le azioni più semplici pare che debbano essere affrontate con la quieta tranquillità del naufrago. Come scrive Paolo Lagazzi
«Questo sentire intride in lungo e in largo l’opera narrativa di D’Arzo, e si dichiara di continuo (come in una ricerca disperata e impareggiabile di conferme) nei suoi saggi, da quello su Villon […] a quello su Conrad, dei cui personaggi il tratto comune sarebbe appunto l’esilio colpevole dalla vita; da quello sul colonnello Lawrence […] a quello su Hemingway: il cui personaggio-tipo appare a D’Arzo “l’uomo venuto da via, da molto lontano, che abita il mondo come altri una stanza d’albergo” […]»
D’Arzo rientra in questo modo nel novero dei lettori ideali, ai quali si rivolge e dei quali si sente parte, realizzando così il suo gioco di mimetismo che si concretizza progressivamente nella realtà.
Sinossi a cura di Paolo Alberti
Dall’incipit del libro:
Al di là di ogni più o meno arbitraria o gratuita conclusione (e quanto scrivere e dire in questi tempi), resta che il nemico primo di ogni scrittore giovane è lui stesso, e la lusinga di una bella pagina ha un tale potere, una tale suggestiva attrazione su di lui, che il vincerla del tutto, giungendo infine a signorilmente scordarsene e ignorarla, è conquista, in realtà, molto difficile: a punto che si fa quasi necessaria una serie di continua violenza su di sé e che lo scrivere dovrebbe essere considerato pertanto, sulle prime, un impegno morale verso noi: e osservare sempre la pagina e noi stessi, si dovrebbe, con antipatia propria non dico, questo no, ma piuttosto un’armata diffidenza, una sorta di lucido rigore. E non è per pretesa di scoperta che si vuole qui affermare come – fino a quando una nostra lontana fanciullezza ci sorriderà pensierosa nel ricordo, a tal punto che ci compiaceremo di scorgervi ed inventarvi il mito ad ogni passo, e il miracolo si addomesticherà tanto da farsi addirittura quotidiano –, mai si potrà giungere a narrare.
Scarica gratis: Opere. Saggi di Silvio D’Arzo.