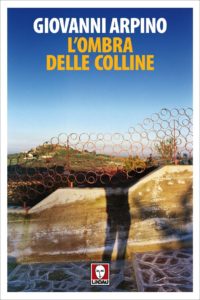 Nato il 27 gennaio 1927, l’autore non ha avuto una lunga vita (morì il 10 dicembre 1987), ma la sua produzione letteraria fu numerosa e spaziò dal romanzo, alla poesia, al teatro, ai libri per ragazzi. Il suo esordio avvenne presso Einaudi con il romanzo «Sei stato felice, Giovanni», del 1952 e da allora i suoi lavori hanno sempre ricevuto un’accoglienza positiva tanto della critica quanto del pubblico. Due illuminanti saggi gli ha dedicato Giorgio Bárberi Squarotti: «Giovanni Arpino narratore delle Langhe» (qui: http://www.ilditoelaluna.net/squarotti_arpino.htm) e «Per Arpino» (in «Le colline, i Maestri, gli Dei», Santi Quaranta, 1992). Della vasta produzione, segnaliamo per primi i titoli che hanno ricevuto premi letterari: «L’ombra delle colline», del 1964, vinse il premio Strega; «Il buio e il miele», del 1969, vincitore del premio Moretti D’Oro; «Randagio è l’eroe», premio Campiello nel 1972; «Il fratello italiano», vincitore del Super Campiello nel 1980. Altri romanzi: «Gli anni del giudizio», del 1958; «La suora giovane», del 1959; «Un delitto d’onore», del 1960; «Una nuvola d’ira», del 1962; «Un’anima persa», del 1966; «La sposa segreta», del 1983.
Nato il 27 gennaio 1927, l’autore non ha avuto una lunga vita (morì il 10 dicembre 1987), ma la sua produzione letteraria fu numerosa e spaziò dal romanzo, alla poesia, al teatro, ai libri per ragazzi. Il suo esordio avvenne presso Einaudi con il romanzo «Sei stato felice, Giovanni», del 1952 e da allora i suoi lavori hanno sempre ricevuto un’accoglienza positiva tanto della critica quanto del pubblico. Due illuminanti saggi gli ha dedicato Giorgio Bárberi Squarotti: «Giovanni Arpino narratore delle Langhe» (qui: http://www.ilditoelaluna.net/squarotti_arpino.htm) e «Per Arpino» (in «Le colline, i Maestri, gli Dei», Santi Quaranta, 1992). Della vasta produzione, segnaliamo per primi i titoli che hanno ricevuto premi letterari: «L’ombra delle colline», del 1964, vinse il premio Strega; «Il buio e il miele», del 1969, vincitore del premio Moretti D’Oro; «Randagio è l’eroe», premio Campiello nel 1972; «Il fratello italiano», vincitore del Super Campiello nel 1980. Altri romanzi: «Gli anni del giudizio», del 1958; «La suora giovane», del 1959; «Un delitto d’onore», del 1960; «Una nuvola d’ira», del 1962; «Un’anima persa», del 1966; «La sposa segreta», del 1983.
Nella mente di Stefano Illuminati, il protagonista de «L’ombra delle colline», si riaccende il ricordo della morte di un soldato tedesco a cui, negli anni della guerra, aveva sparato con la pistola calibro 6,35 sottratta al padre colonnello, una pistola che lui e l’amico Francesco si scambiavano a turno.
È un avvio quasi impalpabile; di terragno sono soltanto le impronte di buoi, cani, volpi, intravisti nel ricordo su di un sentiero tra i boschi. Il tempo di guerra batte spietatamente i suoi colpi e torna a riconsegnare i tratti salienti di quella dolorosa esperienza.
Stefano si porta addosso un’ossessione e un’inquietudine che forse discendono anche da quel lontano ricordo. L’amore per Laura («Lu») si è trasformato e assomiglia più ad una amicizia rassegnata, quasi spenta, che la ragazza cerca di mantenere viva come l’ultimo, disperato appiglio a cui ancora può legare un barlume di felicità. Arpino scava nel dolore, non ne fugge, anzi sembra compiacersi di renderlo dolente ed ostinato protagonista della vita. Mosso dall’ansia di fare qualcosa di significativo ed esemplare, Stefano, che ha appena trentatré anni, è roso dal male oscuro della sofferenza e della delusione. È uno sconfitto ancor prima di cominciare ad agire. Sconfitto nello stesso momento in cui il suo pensiero positivo prende forma, sopraffatto dall’altro paralizzante e cupo: «tu la sai la confusione d’età che hai dentro, i pensieri incauti di adolescente che si sfarinano contro la stanchezza del vecchio già pronta ad invaderti fino alle unghie, e li senti i grani di polvere nel motore, che stridono, gli fanno perdere colpi […]»
La scrittura ha in sé una cantilena malinconica, una umiltà dettata dal dolore. La grande festa nella casa del nonno e poi la sua morte da patriarca venerato, scorrono in realtà come lugubri rintocchi. Sono ancora quelli della guerra, di cui è difficile dimenticarsi. Essa si trasforma per il protagonista, che l’aveva accolta come un gioco «esilarante», in una cappa che tarpa le ali, usurpatrice di una esaltazione naturale alla felicità. Sente dire dalla domestica Caterina: «Questa è una guerra che porterà disgrazia a tutti […]» Arpino scrive bene, puntuale ed efficace. L’affresco della vita in villa, dove si sono insediati i soldati, accosta magistralmente le raffinatezze di una famiglia agiata alle rozzezze e al disordine provocati dai militari che si preparano a partire per il fronte francese. Lo stesso dicasi delle adunate dei balilla e della visita di Mussolini a Piacenza o delle giornate trascorse in caserma con il padre colonnello. Sono raffigurazioni autobiografiche saporose, vivide, colte nella loro essenzialità. Nulla appare sprecato nella scrittura.
Intimorito e ossessionato dalla figura del padre, un uomo ligio al dovere e severissimo soprattutto con se stesso, Stefano percepisce, soprattutto attraverso di lui, ma ancora vagamente, i cambiamenti che stanno per incidere sulla società. Vive in un mondo che già l’avvio della guerra sta allontanando. Questo mondo è tenace, vorrebbe resistere, la madre accudisce la casa nel rispetto della tradizione, si preoccupa di procurarsi le scorte per poter sopravvivere, convinta di potercela fare: «Dobbiamo metterci sotto […]» Ma Stefano pensa: «tutto, giorni e persone, stava diventando più distorto e feroce, e ce ne accorgemmo in giugno, una volta tornati alla casa in collina.» La fine di Doro, il contadino a cui muore il maiale e per disperazione si getta nel pozzo, è il segnale forte di una più grande sventura che sta per accadere nel mondo. È la narrazione, anche, del punto di confine tra una società antica e la nuova che è annunciata dalla guerra, condotta dall’autore con la sapienza e la sensibilità dei dettagli e delle cesellature più rappresentative: «Quest’universo non era uno spazio vuoto e senza echi, ma una foresta intricata, viva, una popolazione di fatti e presenze e sostanze, e insieme era l’urlo che il domani mi mandava incontro, uno squillo tremendo ma a tratti gravido d’una gioia che penetrava la pelle. Ero incredibilmente felice e non potevo dirlo. Mi sentivo i denti acuti e pronti di un animale cacciatore, una giovane volpe rossa di due anni, finalmente alle soglie di un mondo da scoprire e far suo.»
Il caos e lo smarrimento dell’8 settembre 1943, così ben descritti in poche lucide e tragiche immagini, segnano il momento di un tale trapasso. Il padre di Stefano, il colonnello, sconfitto e umiliato con la resa ai tedeschi, ne è l’espressione più amara: «Sa qual è la sua unica malattia? Che non può più comandare, ecco tutto! […] Abituato a far correre il prossimo, a metterlo sull’attenti!, adesso che non ha più nessuno sotto, è come un gatto senza le unghie […]»
Interessante il racconto dell’esperienza militare che Stefano fa come volontario nelle file dei repubblichini di Salò. È tra i marò a La Spezia e sente per la prima volta parlare dei partigiani. Un commilitone gli dice che sono «i borghesi pagati da Badoglio». È un’esperienza che mostra l’altra faccia della medaglia della nostra guerra civile: «Divisi in tre squadre di venti uomini l’una, dopo una corsa in camion attraverso la città buia, attaccammo per diversi sentieri la massa oscura delle colline.» È notte e vanno in cerca di partigiani che hanno attaccato «un posto di blocco e forse incendiato una casa.»
Dura poco quell’esperienza, ma le pagine la illuminano con il toccare le corde del primo entusiasmo e della delusione finale. Ci accorgiamo così che i cambiamenti che sono nell’aria stanno già agendo sul giovane Stefano. Il tedesco che ha ucciso allorché per la prima volta ha avuto in mano una pistola e ha voluto dimostrare all’amico Francesco che non aveva paura di sparare, si sta trasformando – con la sua continua presenza nel ricordo del protagonista – nel simbolo personale del mutamento, della fine, ossia, di un periodo tormentato che sta per risolversi in un altro del tutto nuovo.
È un romanzo i cui colori sono dati dalle ombre, colori scuri, a volte decisamente neri («le colline sono ormai nere oltre la strada e le case.»; «Al di là del parapetto, contro la buia parete della collina»; «Alle nostre spalle la trincea d’ombra degli alberi che costeggiano Tanaro è diventata massiccia e oscura.»; «I campi si vanno oscurando»; «Il giardino è ormai un intricato labirinto di forme oscure»; «sento l’oscurità che si dilata e muove in gorghi sempre più vasti»: sono solo alcuni esempi); è un futuro, quello di Stefano, che bussa in lui, ma ancora non si delinea, è intriso di timore, di incertezze. La sua ragazza, Lu, nel corso del viaggio che da Roma deve condurli in Piemonte, pur avendo promesso di non importunarlo con le sue lagne, lo assilla morbosamente, spinta dalla sua personale ricerca di certezze. Di tali certezze, Stefano pare non sentirne bisogno; al contrario di Lu, sembra piuttosto voler vivere alla giornata costrettovi da una filosofia nichilista e accidiosa. Lu non capisce perché Stefano non la sposi e non voglia avere un figlio, e Stefano evita di rispondere («Mi cade la faccia tra le mani»). In albergo sono soliti dormire in camere separate. Si scopre che entrambi condividono una pena: l’aborto voluto di una loro creatura: «C’era, lei! C’era, già fatta! Perché non l’abbiamo lasciata venire […] Avrebbe tre anni adesso, sarebbe una così bella bambina […]» Ma a Stefano non piace più questo mondo e non vuole sentirsi responsabile di una nascita; è ancora convinto che «non vale la pena di riprodursi in un mondo come questo».
Pur essendo trascorsi gli anni tragici della guerra, essa ancora lo perseguita con la paura, la insicurezza, le angosce. La guerra ha dimezzato un uomo che pur non avendo ferite esteriori, ne ha assorbito il morbo disgregatore. Il risalto che viene dato (con uno stile qualche volta meno asciutto e originale, più di maniera) al rapporto con Lu apparirebbe inutile e deviante se non contenesse un tale significato. Vi sono affinità più robuste di quanto si possa immaginare tra questo male sotterraneo di Stefano e il male oscuro del protagonista dell’omonimo romanzo di Giuseppe Berto, uscito nello stesso anno, il 1964.
Nemmeno l’essersi trovato, insieme con l’amico Francesco, nel gruppo di partigiani che entrarono in Torino vittoriosi, lenisce la sua sofferenza. Confidandosi con Lu, in una confessione interiore tutta sua, la malinconia dei ricordi diviene la punta scoperta del suo malessere esistenziale. Nei giorni della resa dei conti a fine guerra, lo spettacolo delle atrocità commesse gli ha gravato gli occhi di visioni disumane e indimenticabili: la ragazza che si era data ai tedeschi appesa nuda ad un balcone; lo spretato spia, detto l’Eremita, giustiziato con una raffica di mitra da uno sconosciuto presso la sua baracca in collina. Stefano si è smarrito, il suo entusiasmo per la vita si è spento. Anche l’amore non riesce a mettere radici nella sua anima. La sua confessione a Lu, logorroica, querula ed insopportabile Lu, è una silenziosa invocazione di aiuto, che forse non potrà mai arrivare a compiersi: «Per raggiungere questa mia forma d’oggi, che tu vuoi, che circondi e difendi, mi sembra d’aver attraversato centinaia di metamorfosi prive di senso. Il bruco che non solo si promuove a farfalla, s’invilisce e ricade bruco, ma è costretto ad essere anche salamandra, e poi tigre, e poi tafàno […]»
Ciò che lo rode ora è che la guerra, la caduta del fascismo, non hanno prodotto i risultati sperati e hanno lasciato le cose come prima. Coloro che avrebbero potuto cambiarle si sono fermati, addirittura compromessi. L’amico Francesco, che incontra di nuovo una volta giunto al paese per vedere suo padre, è ancora più deluso di lui. La loro è la conversazione di una sconfitta e di una resa. Francesco gli dice: «Chissà. Forse potremmo essere contenti così come siamo, se non sapessimo ciò che siamo stati […]» È il male oscuro che Stefano (ed anche l’amico) si porta dentro e che stenta a risolversi nella speranza. L’amico è molto esplicito sull’avvenire: «Non avremo un’altra Primavera come quella là. E allora: ferma i buoi!» Arpino finisce così per denunciare uno stacco netto, deciso che avrebbe dovuto esserci tra il prima e il dopo, e non c’è stato. Fa dire a Francesco: «Non abbiamo saputo fare giustizia, e ormai nessuno ce la può regalare.»
La visita al padre, il colonnello, così riservata e taciturna, diventerà la sola cerniera che possa legare di nuovo intorno alla sua vita la sua compagna e il desiderio di riprendere un cammino interrotto: «Per ora, già chiaro risulta questo vantaggio: non ci sarà condanna per l’impresa che risultò impossibile, per la qualità non raggiunta; saremo condannati solo se rifiuteremo d’esprimere il bene segreto che ci accende nell’umile alba d’ogni giorno […]»






