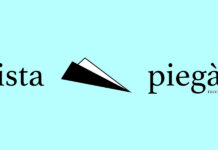1. Se è vero che ogni anno le circa tremila case editrici italiane sfornano circa cinquantamila nuovi titoli (il dato è di qualche anno fa, e forse va rivisto al rialzo), allora è lecito supporre, sulla base di un calcolo di massima fondato su rapide occhiate ai settori di uno di quei grandi supermercati che sono ormai diventate le grosse librerie (in uno di quegli immensi deserti di carta senza piste e senza oasi, ancora più aridi e soffocanti nell’afa agostana incombente sulla città semideserta), che meno di un decimo di essi approdi sugli scaffali delle distribuzione e della vendita («distribuzione e vendita», proprio come se si trattasse di prodotti alimentari o d’altra natura – «materiali librari», dunque, come dice il gergo biblioteconomico, destinati al consumo, alla metabolizzazione, alla marcescenza, alla degradazione, all’espulsione, alla dispersione).
2. Alla luce di ciò, e visto che, a tutt’oggi, purtroppo, poco più di un decimo circa del mercato librario passa attraverso i canali più liberi, diretti e diversificati della rete, dell’editoria digitale o della vecchia vendita per corrispondenza, è possibile confermare, e razionalizzare, l’intuitiva percezione che almeno il novanta per cento dei libri stampati (e la quasi totalità di quelli contraddistinti da un qualche valore culturale, e dunque da un certo grado di complessità, e per ciò stesso rivolti ad un pubblico esiguo ed elitario) appartenga alla cosiddetta «editoria sovvenzionata», ovvero prefinanziata da un ente pubblico, dai feudali fondi «ex settanta per cento» gestiti dai baroni accademici con criteri non sempre trasparenti ed equi (e spesso destinati ad un sottobosco di piccole case editrici cresciute all’ombra degli atenei, e sovente di proprietà di amici e parenti degli stessi prelodati baroni), o, più semplicemente e più frequentemente, dagli autori medesimi.
3. Se quei libri fossero distribuiti, forse verrebbero venduti (cosa peraltro improbabile per la saggistica accademica, sempre specialistica e settoriale, e spesso di valore scarso o nullo), e dunque non necessiterebbero di sovvenzioni. Ma essi non vengono distribuiti proprio perché non si vendono, o meglio perché i distributori e i librai suppongono, ragionevolmente, che non si venderebbero.
Un singolare e diabolico circolo vizioso: libri che non si vendono perché non vengono distribuiti, e non vengono distribuiti perché non si vendono. Un nietzscheano serpente che rischia di strangolare, anzi effettivamente strangola, fin dal primo vagito, ogni discorso culturale; e che continuerà a strangolarlo, a meno che non arrivi un improbabile Zarathustra a schiacciargli al testa.
4. Si dirà (e si sente spesso ripetere) che se la gente non legge testi culturalmente significativi, e dunque, in genere, complessi e impegnativi, la colpa è della scuola, che non sa trasmettere la passione e l’amore per la lettura, il sapere e il pensiero.
Io non credo. Se solo una cerchia limitatissima, quasi nulla di persone (non più di centomila in tutta Italia, direi, e la stima è forse generosa) si accosta, o si riaccosta, ai classici della letteratura, ai testi filosofici e ai libri di critica e di saggistica che su quei capolavori si fondano, cercando di interpretarli e di attribuire ad essi nuovi significati e nuove sfumature, la colpa non può essere solo della scuola, a meno che non si voglia ammettere che quasi tutti gli insegnanti siano incapaci (il che peraltro non è impossibile).
Evidentemente, di per sé, testi letterari, poetici, filosofici, scientifici (che non siano limitati, questi ultimi, ad una sciocca, aneddotica o libellistica divulgazione e riduzione in pillole) sono rivolti, per la loro stessa sottile e complessa natura (e già lo erano, a ben vedere, con rarissime eccezioni, nelle epoche in cui furono scritti), ad un pubblico elitario.
5. Né la colpa è, o è solo, del sistemamediatico, sebbene effettivamente esso, fondato sull’immagine ben più che sulla parola (e in genere contraddistinto, quando si avvale della parola, da un linguaggio ancor più vuoto e insulso di quello visivo – tanto che dalla televisione, ma anche dai nuovi media e dai tanto celebrati social network, escono frasi perlopiù, a ben vedere, prive di senso, o semanticamente opache, neutre, indifferenti, irrilevanti, limitate allo stereotipo, al cliché, alla parola d’ordine arbitraria, pretestuosa, priva di contesto e di pensiero, o addirittura al mugugno, al farfuglio inarticolato, ancor più vano di quello animale, che almeno a suo modo qualcosa comunica, qualcosa dice), tenda di per se stesso a distogliere dalla riflessione, dal raccoglimento, dalla meditazione, dal pensiero.
6. Neppure si deve credere che, in passato, quando la civiltà televisiva e mediatica non esisteva, e il mondo era (o così almeno si è inclini a supporre) più poetico, più luminoso, più pieno, ancora popolato di ideali, di miti, di aure trascendentali, i capolavori della letteratura e del pensiero circolassero (anche molto dopo l’invenzione della stampa) in centinaia di migliaia di copie.
Quando la figlia di Manzoni si rallegrava, in una lettera, della grande diffusione, e della larga eco, ottenute dal romanzo del padre, si riferiva ad un’edizione che non superava le mille copie. Riviste come Il Conciliatore, Solaria, La Voce, che stando ai manuali avrebbero contribuito a diffondere presso un fantomatico «pubblico borghese» i nuovi fermenti della cultura europea, raggiunsero al massimo, rispettivamente, un’ottantina di copie, circa settecento, un migliaio.
7. Un giovane e valido poeta si è ucciso, di recente, perché nella società di oggi «i poeti non contano più nulla». Esenin (caso rarissimo, e molto russo) era acclamato dalle folle. Ma si impiccò in un cesso. I poeti si uccidono soffocati dall’oscurità, dall’anonimato, dalla mancanza d’eco – o, viceversa, per la troppa eco che distorce la loro voce, per la troppa luce che abbaglia il loro sguardo, e finisce per oscurare e confondere, come assenzio, le parole e le pagine.
8. Dell’edizione in folio di Shakespeare, croce e delizia dei filologi, esistette dapprima un migliaio di copie, di lentissimo e difficilissimo smercio. Dopo un incendio, ne sopravvisse una trentina. Le trenta persone che comprarono quelle copie salvarono Shakespeare dalla distruzione (come Augusto salvò l’Eneide dal fuoco, Max Brod tutto Kafka a parte i racconti, sola sua opera da lui riconosciuta in vita, Petrarca il Decameron, che Boccaccio pensò di far sparire per scrupoli religiosi sopraggiunti in tarda età, spentisi ormai i suoi ardori, o venuta meno la possibilità di appagarli).
9. La quasi totalità degli studenti, con un sorriso idiota, si rammarica dei mancati roghi (ignorando che quelli che bruciavano i libri si chiamavano Hitler, Stalin, Mao): studenti pronti essi stessi a bruciare simbolicamente Dante e Virgilio dopo la maturità. La colpa non è loro, né della scuola, né della televisione.
Non c’è nulla da fare. Quei grandi scrivevano per pochi. Per un’aristocrazia dello spirito di cui si entra a far parte per inclinazione naturale, per il salutare o funesto influsso dell’ambiente familiare, a volte (come credono i più, beffardi e infastiditi, sdegnosi e invidiosi) per mancanza di altre gratificazioni – ma alla quale si è, in genere, oscuramente e luminosamente predestinati, per sorte o condanna, secondo o contro il proprio volere, per immensa gioia e ardente sofferenza.
10. I classici. Nelle grandi librerie si trovano, cercando bene, camuffati in uno scaffale remoto, quasi ospiti sgraditi e spaesati, spesso impilati vicino al suolo onde scoraggiare il lettore che non voglia piegarsi ed inginocchiarsi di fronte a quella svilita grandezza, a quell’altezza sprofondata.
Si ha, quasi, la sensazione che il sistema editoriale abbia paura dei classici. Se il pubblico si abituasse a meditare Platone, Virgilio o Shakespeare (o anche Derek Walcott o Wole Soyinka, per non dare un’impressione di eurocentrismo – ma anche loro, l’uno caraibico, l’altro nigeriano, guardano a Omero, Dante, Virgilio, Shakespeare, Euripide come a maestri e modelli), forse maturerebbe la propria vocazione, se ne ha una, affinerebbe una sensibilità, un gusto, un discernimento talida consentirgli di non lasciarsi più passivamente imporre, dal rodato meccanismo pubblicitario, qualunque libro di narrativa di consumo e d’evasione abbia vinto, per un motivo o per l’altro, lo Strega, o sia stato esaltato dalla televisione o dal Corriere, ma al contrario di poter scegliere a ragion veduta, di divenire, da consumatore, ricercatore, evolvere da fruitore a pensatore, da acquirente ad interprete.
11. «I classici che devi leggere per l’estate, da noi li trovi con lo sconto». Tale, più o meno, lo slogan di un grande editore. Quel dovere dice tutto, e uccide sul nascere ogni piacere, giacché anche l’atto più piacevole della vita, se dovesse essere compiuto ad ore, e secondo modalità, prestabilite ed imposte da un’autorità, diverrebbe un tormento. Ha ragione Pennac: il verbo leggere, come il verbo amare, non tollera imperativi.
12. Ma che cos’è un classico? Un poeta in cui una data civiltà raggiunge e testimonia il suo più alto grado di compiutezza, di ricchezza spirituale, di maturità, secondo Eliot. Un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire, secondo la definizione forse un po’ tautologica di Calvino. Un poeta autocosciente, riflessivo, consapevole, che contiene in sé un critico e ascolta la sua voce, i suoi suggerimenti, i suoi sproni e le sue censure, e lo fa collaborare alla stesura delle proprie opere, secondo Valéry.
Io credo che un classico sia un segno del destino. Uno scrittore necessario, senza il quale il mondo (almeno quello della bellezza e del pensiero, non quello della produzione o della borsa) sarebbe più povero. Uno scrittore le cui parole stesse sono necessarie, predestinate,insostituibili, come dettate da una voce superiore, simili all’eco, sempre imperfetta, di un più alto Verbo.
Un autore, un artista le cui opere, in quanto tali, in quanto opere, e nella loro relazione, sia pur mediata dalla forma e dallo stile, con l’epoca e il contesto, nessun altro avrebbe potuto crearemeglio, o diversamente.
La nostra epoca ha obliato e rimosso i classici nella stessa misura in cui ha eclissato il sacro, oscurato l’essere necessario ed immutabile, e disincantato il mondo, rendendolo forse più chiaro, più comprensibile, più rassicurante, ma insieme certo più povero.
13. Altro circolo vizioso. È, o meglio si reputa, necessario imporre, prescrivere come una medicina amara, la lettura dei classici, perché quasi nessuno vorrebbe, spontaneamente, leggerli (spesso neppure i presunti intellettuali, molti dei quali, del resto, oggi preferiscono occuparsi di telefonini e telefilm).
E, per converso, quasi nessuno vuole leggerli proprio perché la loro lettura viene imposta, spesso in età troppo acerbe, a menti non ancora mature e formate ‒ le quali peraltro, con ulteriore, insolubile paradosso e circolo vizioso, forse potrebbero essere aiutate proprio dai classici a maturare.
14. La chiarezza. L’epoca (e con essa il mercato che da un lato ne è specchio, dall’altro contribuisce a modellarla e a determinarne i caratteri, non si sa quale delle due cose in misura maggiore e più cogente) esige frasi brevi, rapide, concise, parole semplici, chiare, immediate, che «arrivino dritte al cuore» o che «tengano alta la tensione» ‒ che, insomma, sollecitino e soddisfino istinti ed inclinazioni animali, primordiali, preculturali, anteriori ad ogni riflessione. Eppure, Sallustio, maestro di brevitas e di velocitas, non è fra i bestseller. Si rischia di confondere la chiarezza, la concisione e l’efficacia con la banalità e la povertà di pensiero.
15. Nonostante tutto, ai limiti, ai margini, anche nelle sperdute ed ombrose province dell’impero di cemento e calura, esistono spazi provvidenziali e quasi magici in cui libro, la parola scritta sono ancora pensiero, coscienza, memoria, libertà. Sono le librerie antiquarie, e le librerie di «rimanenze» e di «resi», quei piccoli preziosi porti sepolti che accolgono materni i libri dimenticati, vinti dal tempo, rigettati dal mercato a cui in passato qualcuno tentò invano, generosamente, utopisticamente, follemente, di affidarli perché raggiungessero, quasi per miracolo, la metatemporale, astorica élite per cui erano pensati. Nelle vie secondarie, lontano dal corso, dal passeggio, dalle «vasche», dalle luci delle vetrine, della vanità, della gratificazione epidermica.
Ci si arrivava per caso, oziando, fuggendo il rumore e la calca, portati dai pensieri, trascinati dai propri passi peregrini e inutili, «come uomini battuti dal vento» cui si apra d’improvviso una porta, per citare un poeta.
In quelle librerie (che ormai, schiacciate dalla grande distribuzione e dalla diabolica «centralizzazione degli acquisti», ormai estesa ‒ fatto gravissimo, e letale per quella bibliodiversità che è libertà e varietà di pensiero ‒ anche alle biblioteche, stanno via via scomparendo, o rifugiandosi nell’innocuo e sotterraneo spazio della rete) raramente si trovano libri di scarso valore culturale. Lì sopravvivono, o sopravvivevano, i classici ‒ anche i «classici minori» ‒, i poeti, i filosofi, la saggistica letteraria, storica, filosofica, antropologica, i libri d’arte e d’archeologia, i testi del pensiero più inquieto, difforme, dissidente, come i nichilisti autentici e dolenti, i situazionisti più estremi, corrosivi, perduti, gli esoteristi meravigliosamente oscillanti fra genialità e superstizione, erudizione e cialtroneria, sistematicità cosmica e delirio visionario.
Fatto paradossale ma non troppo, è raro, rarissimo che un libro idiota resti invenduto. Esso trova sempre il suo pubblico. Più probabile che stenti a vendere un capolavoro, o un libro perlomeno complesso, impegnativo, problematico, denso di significati. Un libro siffatto, quando non finiva dai remainders, andava al macero. Ora, con la progressiva scomparsa dei remainders, le alternative saranno il macero, la distruzione, o il nulla, la mancata nascita, l’aborto prematuro.
16. Forse la rete può salvarci, salvare un patrimonio seriamente in pericolo ‒ come ben sanno i ricercatori e i bibliofili, i fantasmi bibliografici, i libri assolutamente introvabili, e di fatto ad oggi perduti, anche se spesso moderni, a volte addirittura recenti, sono più frequenti di quanto non si creda ‒ e salvare, in definitiva, la varietà, la diversità e la libertà del pensiero.
Assurdo, per inciso, e contrario a quella stessa libertà di mercato su cui si basa e con cui si giustifica la mercificazione del libro, è vedere una vetrina, o due vetrine della maggiore libreria di un capoluogo interamente occupate da un solo libro ‒ indipendentemente dal fatto che si tratti di Saviano o di Moccia, ma molto peggio in quest’ultimo caso.
Forse, direbbe Heidegger, proprio la Tecnologia ci salverà dalla Deiezione.
L’editoria sovvenzionata, che grava economicamente sugli autori o ‒ nel caso della saggistica universitaria, acquistata quasi esclusivamente dagli studenti a ciò costretti ‒sulle finanze pubbliche (le quali peraltro sopportano sprechi ben più indegni), diverrà sempre più editoria gratuita, universalmente diffusa attraverso la rete, disponibile in tutto il mondo, accessibile ai poveri (dunque, ad esempio, agli insegnanti) e ai non vedenti, attraverso le sintesi vocali.
Il libro cartaceo sopravvivrà attraverso il printing on demand, l’editoria su ordinazione, che porrà fine agli ignobili maceri, poiché non ci saranno più copie invendute (non esisteranno più, com’è logico, copie cartacee di libri che, per una ragione o per un’altra, nessuno vuole comprare). La ricerca sarà liberamente, totalmente ed istantaneamente fruibile e disponibile, tramite l’»accesso aperto», come raccomandano, una volta tanto saggiamente, la Dichiarazione di Berlino e la Dichiarazione di Messina.
17. Ultimamente, in un libro di carta (ennesimo paradosso), è stato tessuto l’Elogio degli e-book. Due argomentazioni soprattutto mi sembrano interessanti: da un lato la fine della distinzione materiale fra il contenuto e il contenente, fra il pensiero espresso in un libro e il libro stesso, inteso come oggetto; dall’altro il nuovo e diverso ruolo che le librerie e le biblioteche potranno assumere.
Sul primo fronte, se l’oggetto cartaceo è il corpo di un libro, il contenuto ne è l’anima. Alla morte o alla quasi morte, alla dispersione, alla perdita, all’irrecuperabilità, o all’estrema rarità, di un libro, alla difficoltà di consultarlo o di riprodurlo anche a causa di norme bibliotecarie troppo restrittive, o all’esiguità della sua diffusione cartacea per ragioni di mercato e distribuzione, farà riscontro l’immortalità della sua anima, del suo contenuto immateriale, incorporeo, puro.
Il testo, sullo schermo, è pura luce, puro pensiero; si trasfonde direttamente dal pensiero dell’autore a quello del lettore, senza più la mediazione, che è troppo spesso un ostacolo, del libro come oggetto. Un librò sarà, letteralmente, il pensiero di colui che lo legge e lo interpreta. Esso sarà, in forma più pura, incondizionata, diretta, coerente, ciò che in fondo è, per certi aspetti, sempre stato:una virtualità di significati che si traduce in atto solo nel momento dell’interpretazione, e attraverso di essa.
L’editoria, com’è consuetudine dell’«industria culturale», ha reagito all’innovazione non in modo positivo, cogliendone le possibili aperture anche promozionali (per fornire solo un esempio, il fatto che le opere del collettivo Wu Ming siano integralmente presenti in rete in forma gratuita non ha impedito la loro vendita in decine di migliaia di copie cartacee), ma, al contrario, provvedendo subito a porre ostacoli (licenze, certificati, privilegi, identificazioni, programmi di lettura piuttosto macchinosi).
Quanto più rigidi sono gli ostacoli, ed elevati i prezzi, tanto più è facile che il diritto d’autore (concetto, peraltro, ormai obsoleto nell’era digitale, se non come soggettivo, e preziosissimo, diritto di essere autore, di esprimersi liberamente, senza le censure ideologiche del totalitarismo e senza neppure quelle, utilitaristiche, e forse ancor più rigide, dettate dal mercato) venga violato.
Librerie e biblioteche saranno, o torneranno ad essere, quello che dovrebbero: spazi di incontro culturale, di presentazione e scambio di idee, in cui saranno prestati o venduti non più oggetti cartacei da consumare o mandare al macero, ma, essenzialmente, «informazioni» proprio nel senso cibernetico, sequenze numeriche, stringe o codici che consentiranno di accedere al patrimonio culturale, o meglio che lo materializzeranno, immaterialmente, nella forma incorporea dello schermo e dell’immagine. Sul fatto burocratico o mercantile prevarrà la pura luce del pensiero, perennemente ricreato dalla mente che lo pensa.
Si può solo immaginare quali scenari, affascinanti ma anche inquietanti, quasi da neo-alienazione post-industriale, potrebbero essere dischiusi, sotto questo profilo, dai progressi dell’intelligenza artificiale.
Del resto, già negli Anni Sessanta Nanni Balestrini scriveva, o meglio faceva scrivere, un poema, Tape Mark, tramite un prototipo di calcolatore elettronico, il quale, con la sua artificiale intelligenza, preconizzava ciò che oggi sta accadendo. «Mentre la moltitudine delle cose accade nell’accecante / globo di fuoco, esse tornano tutte / alla loro radice, si espandono rapidamente, finché non mosse / le dita lentamente quando raggiunse la stratosfera / e giacque immobile senza parlare, trenta volte / più luminoso del sole, cercando di afferrare». È proprio verso quella luce rovente ed incorporea che ci stiamo forse avviando.
18. E infine tu, lettore, che sei arrivato qui inserendo nel motore di ricerca misteriose alchimie di rare parole dense di significato, di storia, di cultura ‒ tu sei, come diceva un grande critico, «della mia stessa razza». Molto probabilmente, appartieni anche tu a quella che un tempo fu forse un’élite intellettuale, ora è una minoranza ignorata, disperata e brada (non esagero, poiché per alcuni, per pochi invero, la cultura è vita, il pensiero è la parte di noi più durevole e pura). Un abbraccio, mon semblable, mon frère.