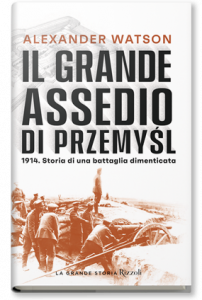A. Watson, Il grande assedio di Przemyśl, 1914. Storia di una battaglia dimenticata, Rizzoli, Milano 2021, euro 24,00.
La recente invasione delle forze armate russe dell’Ucraina ha riportato agli onori delle cronache Przemyśl, città polacca del Voivodato della Precarpazia, primo luogo di approdo per migliaia di profughi in fuga dal conflitto e scenario dell’infelice comparsata di un leader politico italiano.
In realtà, oltre le contingenti ragioni dell’attualità, permanenti motivi di natura geopolitica – una geopolitica spesso bistrattata, ma inesorabilmente pronta a far sentire il proprio peso – hanno negli ultimi due secoli elevato Przemyśl a snodo centrale della storia politica e militare europea.
Anello di congiunzione tra Oriente ed Occidente, linea di sutura tra mondo cattolico, greco-ortodosso ed ortodosso, e capoluogo distrettuale di una regione, la Galizia orientale, etnicamente composita (polacchi, ruteni, ebrei, tedeschi), alle vicende belliche della città dedica pagine avvincenti lo studioso britannico Alexander Watson con Il grande assedio di Przemyśl, 1914. Storia di una battaglia dimenticata (Rizzoli, Milano 2021).
Non privo di qualche sbavatura nella traduzione, il volume, di circa 400 pagine, completato da due appendici dedicate alla struttura delle forze armate austro-ungariche e da un corposo apparato di note (oltre 60 pagine), è percorso da una tesi forte, complemento della nota analisi di Timothy Snyder sviluppata in Terre di sangue. L’Europa nella morsa di Hitler e Stalin (Rizzoli, Milano 2011), della quale, quella di Watson, aspira ad essere un prologo in scala ridotta sul microcosmo di Przemyśl.
In sintesi, il denominatore comune interpretativo dei capitoli riporta al ruolo della Grande guerra come tragedia originaria del ‘900 europeo. Tragedia capace di predisporre e incubare quelle condizioni di deumanizzazione del nemico, di ideologizzazione dei conflitti, di radicalizzazione etno-nazionalista dei gruppi, di diffusa violenza di massa verso soldati e civili, di barbarie antisemita, e di sospensione etico-morale degli individui, che le vicende successive del XX secolo avrebbero portato alle estreme conseguenze nelle bloodlands orientali con tutto il loro carico di stragi e lutti.
Riepiloga Watson: nonostante la fine delle ostilità nel novembre del ’18, e «malgrado gli imperi si fossero disintegrati, la violenza continuò, mutando e radicalizzandosi ulteriormente. Non ci sarebbe stato alcun ritorno alla sicurezza e alla tolleranza, per quanto chiassose e litigiose, dell’era pre-1914. Le biografie della generazione che combatté a Przemyśl urlano questa perdita di sicurezza e l’odio endemico, la malvagità e il massacro che presero il suo posto» (p. 35).
Nelle contese lande di Przemyśl, tra le fortezze del più importante baluardo difensivo di cui la Duplice monarchia dispone ad Est, laddove gli eserciti austro-ungarico, zarista e germanico cozzano l’un contro l’altro selvaggiamente tra il settembre del 1914 ed il maggio del 1915 stravolgendo la vita locale, l’Europa osserva con orrore, in anteprima, uno scorcio del proprio funesto avvenire. Un avvenire per molti aspetti addirittura difficile da immaginare. «Lunghi decenni di pace e progresso – nota Watson – avevano fatto credere alla popolazione che gli orrori della guerra appartenessero al passato. Invece la barbarie del XX secolo (…) affondava le radici proprio nell’epoca moderna» (pp. 162-63).
Le novità imposte dal conflitto e la rottura con le forme del guerreggiare passato, del resto, non si fanno attendere. Per i commentatori più attenti, fin dall’autunno del ’14 sul fronte orientale la guerra assume un’inedita e pericolosa dimensione ideologica (p. 134) che, a cascata, coinvolge ogni aspetto della quotidianità bellica di soldati e civili.
Fallito un primo attacco austro-ungarico nel settembre dopo l’esito sfavorevole delle due battaglie di Leopoli, manovra conclusa col ripiegamento delle truppe fino a Cracovia, Przemyśl si trova a fronteggiare con le sue sole forze «l’esercito più potente del pianeta», quello zarista (p. 101), il quale, presa Jaroslav il 22 settembre, cinge d’assedio la città dal 28.
Nel quadro del generale arretramento dell’armata austro-ungarica, la resistenza di Przemyśl e delle sue truppe – 130.000 uomini con 21.000 cavalli – gioca un ruolo militare decisivo per almeno due ragioni. In primo luogo, perché blocca lo slancio offensivo delle schiere nemiche immobilizzandone presso la città ingenti forze. In secondo luogo, e qui torniamo alla tesi forte del volume, poiché rappresenta uno scudo contro il radicale piano promosso dai russi di riorganizzazione etnica del territorio, primo tassello di un più ampio progetto diretto «a cambiare il volto dell’Europa orientale» (p. 134).
Mentre nella Przemyśl sotto assedio la situazione si fa ogni giorno più incerta – le paranoie securitarie degli ufficiali stimolano a scovare traditori e spie ovunque; il pregiudizio antisemita contamina classi e figure in precedenza immuni – i reggimenti zaristi possono dar corso ai propri piani: procedere con la pulizia etnica (p. 257) e la russificazione della popolazione autoctona, decapitando le istituzioni culturali e l’intellighenzia per rimodellare «la Galizia secondo la visione russa» (p. 137); incoraggiare, attraverso la martellante propaganda panslava, la disgregazione dei reparti austro-ungarici, i quali, in effetti, con l’inizio di gennaio 1915, contano un numero progressivamente maggiore di diserzioni tra i soldati di origine rutena.
A favorire i piani russi è lo stato d’eccezione bellico. Solo in questa cornice emergenziale si legittimano le radicali misure repressive prese contro le popolazioni civili. Misure che se attuate in precedenza, avrebbero sicuramente incontrato la condanna delle opinioni pubbliche internazionali e, forse, la disapprovazione di quella russa.
Storico attento, secondo Watson la strategia dell’occupazione zarista inauguratasi nel gennaio del 1915, promotrice di una prima deportazione di massa dei civili galiziani (p. 147), anticipa «i futuri piani totalitari» (p. 149) dei nazionalsocialisti e dei sovietici, con una decisiva differenza. Simile negli intenti, la pianificazione zarista, pur nell’inflessibile aggressività, mai si spinge a praticare il genocidio sistematico delle popolazioni locali (p. 145), diversamente da quanto registrato in queste terre con l’erompere della Seconda guerra mondiale.
Se la situazione nei villaggi attorno a Przemyśl rimasti in mano russa è disperata, nella fortezza isolata le condizioni non sono certo migliori.
Col trascorrere dell’assedio, la menzionata paranoia sicuritaria degli ufficiali austro-ungarici tocca nuove vette di preoccupante irrazionalità, non risparmiando le truppe. Influendo negativamente sulla gestione delle risorse militari, il comando della fortezza avvia una sorta di pulizia etnica interna ai reggimenti (p. 84), mascherando con fatica il sospetto verso i ruteni, della cui fedeltà si sospetta apertamente. Del resto, nella narrazione di Watson, i soldati ed i civili ruteni appaiono come un vaso di coccio in mezzo ai consolidati gruppi nazionali austro-tedeschi, ungheresi, polacchi e russi, dai quali ultimi sono divisi, al di là della comune matrice slava, da quella fede greco-cattolica che nell’Europa orientale, più della lingua, è il vero tratto distintivo dell’identità collettiva (p. 138). E proprio i ruteni, con gli ebrei, sono il gruppo galiziano destinato a pagare il prezzo più alto allo stato bellico, nei termini dello sradicamento, dell’imprigionamento extra legem e delle esecuzioni sommarie.
Il progressivo peggioramento delle condizioni morali dei civili e delle truppe è inscindibile dal parallelo aggravarsi delle condizioni materiali di vita della fortezza. Mentre «il tema cruciale dello stato mentale della popolazione rimasta intrappolata nella città» (p. 178) preoccupa gli ufficiali implicati nel controllo dell’ordine pubblico, con l’arrivo della stagione invernale 1914 la denutrizione e gli assideramenti (p. 216) si replicano come problemi d’ordine quotidiano per i pochi sanitari in servizio. La povertà – osserva Watson – «produsse a Przemyśl scenari da guerra totale» (p. 216) con l’aumento spaventoso della mortalità e della morbilità. «Al volgere del nuovo anno», col colera che infuria, «tutti nella fortezza avevano un solo pensiero: il cibo» (p. 191).
Paradossalmente, nello spazio ristretto e sovraffollato della città accerchiata, la solitudine dei civili e dei soldati – il cui pensiero corre ai familiari lontani, dei quali si ignora spesso la sorte – diviene una condizione generalizzata (p. 168). Consapevole del problema, l’ufficialità di Przemyśl non manca di promuovere delle iniziative per contrastare il declino morale delle unità in armi. Tra queste una spicca in particolare. Come segnala Watson, «il primo vero servizio di posta aerea al mondo» (p. 179) nasce nella città di quei mesi per spezzare l’isolamento imposto dall’anello armato russo. Per quanto limitato, il successo del servizio lenisce, anche se per pochi fortunati, l’esperito senso di angoscioso abbandono. E tuttavia, la posta aerea, come altre parallele iniziative, solo in parte riesce a rivitalizzare l’animus pugnandi di soldati che, più si osservano intorno, più si convincono di non voler fare la fine degli eroi inutili (p. 214).
Con l’approssimarsi della primavera ed il graduale rinserrarsi dell’assedio, inasprito dalle sortite delle truppe russe verso obiettivi limitati ma sufficienti a mantenere in costante stato d’allerta i reparti austro-ungarici, la situazione, già al limite del sopportabile, peggiora ulteriormente.
L’incremento dei bombardamenti genera il panico, diffondendo terrore ed un senso di vulnerabilità difficilmente contrastabile (p. 51). Przemyśl è attraversata da decine di voci incontrollate – e qui è difficile non ripensare alla lezione blochiana sulle false notizie di guerra – le quali, per nulla casuali, riflettono «le speranze e le paure» (p. 166) di coloro che si trovavano senza via di scampo.
Nel mese di marzo, l’unità psichiatrica della fortezza registra con apprensione «un forte aumento delle malattie mentali» (p. 216). Nello stesso tempo, medici ed ufficiali sgomenti rilevano «la totale apatia di cui erano affetti gli uomini» (p, 215). Un’apatia che, preludio al lento scivolare dell’individuo verso la morte accolta come liberazione, per ricollegarci alla tesi principale di Watson, sembra presagire il Musulmanner dei campi di concentramento nazionalsocialisti.
Il deteriorarsi delle condizioni di vita materiale trasforma i corpi gonfi per la fame dei pazienti dell’ospedale in uno spettacolo macabro eppure non più sconcertante per la cittadinanza. Il dilagare della prostituzione, espediente estremo contro la fame, il reiterarsi di forzati casi di amore surrogato (omosessualità, p. 170), il crescere delle disuguaglianze materiali e della corruzione di chi può impiegare qualche modesto risparmio, portano al collasso «ogni tipo di solidarietà all’interno della fortezza» (p. 196).
Quando mancano poche settimane alla resa, nella città si vive una lotta di tutti contro tutti, almeno per quel che riguarda civili e militari subalterni. Perché il discorso, per gli ufficiali in genere, e per gli ufficiali superiori in particolare, è differente, e presenta aspetti non poco controversi.
Gli intangibili privilegi di classe riconosciuti ai graduati superiori, gli stessi di cui si avvarranno in prigionia in un’Europa governata da élites mortalmente nemiche, ma accomunate dal condiviso ferreo classismo, non solo non vengono meno nella città assediata con situazioni censurabili (come si elenca con puntiglio), ma permettono a maggiori, colonnelli e generali di fronteggiare in forme adeguate le penose condizioni dell’approvvigionamento e della morbilità locale.
In questo contesto da redde rationem – puntualizza Watson: nel marzo del ’15 nessuno ignora più l’imminente fine di ogni resistenza (p. 218) – l’opzione scelta dei comandi austro-ungarici per capovolgere la situazione ha dell’inverosimile.
Incalzato dall’arroganza di un’armata russa pronta ad intavolare trattative solo sulla base della resa incondizionata, lo Stato maggiore della Duplice monarchia ordina, con non meno arroganza, di lanciare un’offensiva con i pochi reparti della fortezza ancora in grado di combattere. Un’offensiva che non dovrà muovere verso Ovest per spezzare l’assedio e marciare in direzione delle truppe austro-ungariche acquartierate presso Cracovia. Ma, informazione a ragione nota a pochi eletti, dovrà sorprendentemente irrompere verso Est, allontanandosi dalle linee di difesa amiche, nella speranza di generare un effetto sorpresa in grado di scatenare la subitanea rotta delle schiere zariste.
Come sottolinea Watson, è una scelta suicida. A nessun ufficiale cui è noto il piano di battaglia sfugge che i reggimenti «non sarebbero mai tornati. Morte o prigionia erano inevitabili» (p. 221).
Come inevitabile è il fallimento dell’operazione scattata alle prime luci del 19 marzo, costosissima in termini di vite umane e materiali. Solo a seguito di tale fiasco allora, a nemmeno 48 ore di distanza, il consiglio di difesa della città si risolve a capitolare, non prima però, radunate le ultime sfinite truppe, di ordinare l’autodistruzione dei forti, dei depositi di munizioni e di viveri, e di tutti gli equipaggiamenti potenzialmente riutilizzabili dalle armate zariste. Tra incendi, esplosioni e caos generalizzato, Przemyśl osserva la propria apocalisse. «Non si saprà mai – chiude lo storico britannico – quante persone morirono quella notte solo per lo choc nervoso» (p. 239).
L’occupazione russa della città, assurta a simbolo della volontà di resistenza imperial-regia, è un duro colpo per Vienna. L’imperatore Francesco Giuseppe «per due giorni interi (…) pianse in modo inconsolabile» (p. 247); «ma peggiore delle conseguenze militari – precisa Watson – fu il colpo che la caduta della fortezza inferse al prestigio asburgico. Fu enorme. La resa era una penosa dimostrazione al mondo della debolezza austroungarica» (p. 247). La stessa decisione dei predatori italiani (Watson dixit, p. 248) di abbandonare la neutralità non sembra estranea alle ripercussioni degli avvenimenti del lontano fronte orientale.
Se il piano dove si misurano con più gravità gli effetti del tracollo asburgico è quello simbolico, non è casuale che proprio a partire da questo si muovano i primi tentativi di rovesciarne gli esiti nella narrazione e nell’immaginario collettivo.
Figli di un impero secolare carico di gloriose gesta avvertito però agli sgoccioli, gli epigonali cenacoli militari asburgici si mostrano caratteristicamente ipersensibili alla faccenda, esprimendo la spiccata volontà di manipolare strategicamente l’immagine che di sé e del proprio operato gli studiosi del futuro proporranno.
Si tratta di un’autoconsapevolezza storica circa il proprio peso nella definizione dei destini europei che, fin dai primi mesi della guerra, l’ufficialità austroungarica coltiva, e dentro la quale si inscrive anche il tentativo di montare intorno a Przemyśl e ai suoi indomiti difensori una mitopoietica spendibile sia sulla stampa (p. 129) che, più in generale, a livello politico.
Proiezione esemplare di questa ufficialità è Franz Conrad von Hötzendorf (1852-1925), il capo di Stato Maggiore dell’esercito asburgico, il cui ritratto Watson, invero, con troppa enfasi tende a far scadere nel caricaturale (p. 152 e p. 199). Meditando sugli scopi dell’ultima, suicida offensiva del marzo 1915, Conrad si dimostra sì cosciente di dover chiudere con una débâcle la partita aperta con le armate zariste. Ma una débâcle da caricare quantomeno di alone leggendario. «Un’ultima e gloriosa corsa verso la morte» (p. 220), testimonianza dell’irrefutabile fedeltà delle truppe alla Casa d’Austria.
Non diversamente da Conrad si comporta il comandante della fortezza, il generale Hermann Kusmanek von Burgneustatten (1860-1934). Nella città in fiamme a poche ore dalla capitolazione, trascorre il tempo compilando un comunicato solo nominalmente destinato ai subalterni, ma in verità diretto ai posteri, con la celebrazione del proprio eroismo di soldato dell’imperatore pronto al sacrificio finale (p. 224) – prigioniero dei russi, il borioso Kusmanek sopravviverà alla fine delle ostilità.
Alle apprensioni epiche degli ufficiali al comando si contrappongono le ben diverse preoccupazioni della truppa. Per loro, la resa della fortezza equivale al prevedibile inizio di una durissima prigionia, che in taluni casi si protrae per anni. Solitamente confinati all’interno della Russia, tali uomini fanno nuovamente i conti con la fame, con l’impossibilità di contattare i familiari, con la solitudine, col lavoro forzato, e con condizioni sanitarie terribili. Dissenteria, tifo e colera faranno strage tra i soldati semplici catturati (p. 252).
Per altro, effetto imprevisto, i pregiudizi etnici degli ufficiali zaristi aiutano alcuni dei prigionieri asburgici ad evitare le prove più ardue. Fedeli ad un modus operandi applicato nei villaggi occupati durante l’assedio, i soldati russi inaugurano una politica della detenzione che intende favorire alcuni gruppi nazionali a scapito di altri. In quest’ottica, «magiari, tedeschi ed ebrei furono separati e inviati nei campi più duri», mentre «serbi e rumeni con uniformi dell’Honvéd, considerati popoli amici, furono selezionati per un trattamento privilegiato» (p. 251).
La capitolazione della fortezza e la cattura di migliaia di soldati non rappresentano, comunque, la fine della storia. Per Przemyśl la chiusura del sipario è lungi da venire.
Con la ripresa delle operazioni all’Est delle truppe germaniche, anche i territori galiziani sono nuovamente investiti da manovre e scontri cui partecipano migliaia di uomini e centinaia di pezzi d’artiglieria.
Nel contesto di quella che passa alla storia come l’offensiva di Gorlice-Tarnów del maggio 1915, Przemyśl diviene uno degli obiettivi strategici delle truppe agli ordini di August von Mackensen (1849-1945) impegnate a ricacciare le armate russe oltre Leopoli.
La manovra d’assalto, progettata e guidata sul campo da ufficiali tedeschi non privi dell’esperienza maturata nelle grandi battaglie dei materiali delle trincee occidentali, «fu qualcosa di mai visto sul fronte orientale» (p. 262). Un preliminare violentissimo bombardamento della moderna artiglieria germanica – che annovera tra i suoi calibri la Grande Berta, un obice da 420 mm – apre la strada alle truppe bavaresi che tra il 29 maggio ed il 03 giugno riconquistano Przemyśl.
Il ciclo infernale (p. 270) innescatosi nel settembre del 1914 può dirsi, apparentemente, concluso. Per il resto della guerra la città, formalmente pacificata, rimane «sotto il dominio asburgico prima di passare, al crollo dell’impero nel 1918, a una nuova e indipendente repubblica polacca» (p. 263).
Tuttavia, come più volte anticipato da Watson, la conclusione delle ostilità nel novembre, con la scomparsa dalle carte d’Europa dei tre imperi che si sono disputati sanguinosamente la Galizia orientale, non inaugura un’era di pace. Al contrario – e qui torniamo alla tesi basilare del volume – le eredità della guerra sono pesantissime e di lungo corso.
L’ambizione russa «di sterminare culturalmente la popolazione ucraina, il velenoso antisemitismo e la deportazione di intere comunità» (pp. 149-50) non scompaiono dall’orizzonte del possibile, patrocinando le brutalità di una Seconda guerra mondiale contraddistinta da ancora più ferocia e disumanità.
Per la popolazione ebraica, la duplice drammatica esperienza della deportazione di massa con non meno di 50.000 persone coinvolte (p. 149), e della pubblica umiliazione inferta loro tra ‘14 e ’15 dai soldati zaristi, prefigura vicende ben più tragiche, quali gli indicibili massacri nazisti del 1939-45.
Parimenti l’odio, il sopruso e l’irriducibile contrasto nazionalista che oppongono comunità a comunità non tramontano (p. 264), alimentando una sete di vendetta reciproca che riemergerà, strumentalizzata, durante gli anni dell’occupazione nazista – la Wehrmacht riprende Przemyśl nel settembre del ’39 – e successivamente al tempo della riconquista russo-sovietica.
In conclusione, appunta Watson, nonostante sopravviva alla guerra guerreggiata, nel microcosmo di Przemyśl un’intera generazione si perde. Non cancellata o distrutta; ma annichilita nel corpo e nella mente, «lasciata alla deriva nel brutale mondo postbellico» orientale degli anni ‘20 e ‘30 (p. 32), di cui patisce, ancora una volta, tutta l’inumana furia.
Una passata violenza carica di dolori, ambizioni di rivalsa e lutti, di cui gli attuali fatti russo-ucraini attestano il trascorrere sostanzialmente vano.