(voce di SopraPensiero)
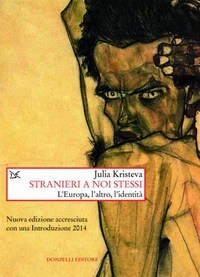 Quest’estate l’ho passata all’insegna dello straniero. Per tanti motivi. Anzitutto, sulla spiaggia maremmana – vuoi la crisi, o il periodo, o il clima di una stagione che tutto sommato è stata fresca – c’erano più immigrati che bagnanti. Centinaia di proposte al giorno, centinaia di risposte negative (e non avrebbe potuto essere diversamente: da quando mi hanno rubato la borsa sotto l’ombrellone, un paio d’anni fa – ahimé proprio nell’amata Toscana – non porto più soldi con me quando vado al mare). Poi tornavo all’appartamento, e mi immergevo di nuovo negli stranieri: sono capitato in un villaggio affollato di tedeschi, svizzeri, francesi, dove i pochi italiani come noi si affannavano a cercare di farsi intendere parlando in inglese, con poco successo, da una parte e dall’altra (però era divertente, soprattutto all’inizio, entrare nel campetto di calcio nel bel mezzo di una partita, guardare il primo che capitava a tiro con lo sguardo, muovere l’indice da me a lui tre o quattro volte e dire: «Match?»). È stata l’estate in cui ho incontrato Aziz, africano con la bancarella di artigianato nel centro di San Vincenzo, che mi ha cambiato la banconota da 5 euro in monetine, con cui ho pagato il parcheggio. È stata l’estate della donna nera e bellissima che ci è passata davanti più e più volte al giorno carica di merci da ogni braccio, con un canestro in equilibrio sulla testa e un fagotto dietro alla schiena, nel quale se ne stava avvinghiato e appeso il suo meraviglioso bambino.
Quest’estate l’ho passata all’insegna dello straniero. Per tanti motivi. Anzitutto, sulla spiaggia maremmana – vuoi la crisi, o il periodo, o il clima di una stagione che tutto sommato è stata fresca – c’erano più immigrati che bagnanti. Centinaia di proposte al giorno, centinaia di risposte negative (e non avrebbe potuto essere diversamente: da quando mi hanno rubato la borsa sotto l’ombrellone, un paio d’anni fa – ahimé proprio nell’amata Toscana – non porto più soldi con me quando vado al mare). Poi tornavo all’appartamento, e mi immergevo di nuovo negli stranieri: sono capitato in un villaggio affollato di tedeschi, svizzeri, francesi, dove i pochi italiani come noi si affannavano a cercare di farsi intendere parlando in inglese, con poco successo, da una parte e dall’altra (però era divertente, soprattutto all’inizio, entrare nel campetto di calcio nel bel mezzo di una partita, guardare il primo che capitava a tiro con lo sguardo, muovere l’indice da me a lui tre o quattro volte e dire: «Match?»). È stata l’estate in cui ho incontrato Aziz, africano con la bancarella di artigianato nel centro di San Vincenzo, che mi ha cambiato la banconota da 5 euro in monetine, con cui ho pagato il parcheggio. È stata l’estate della donna nera e bellissima che ci è passata davanti più e più volte al giorno carica di merci da ogni braccio, con un canestro in equilibrio sulla testa e un fagotto dietro alla schiena, nel quale se ne stava avvinghiato e appeso il suo meraviglioso bambino.
Penso a loro, e al bel libro di Julia Kristeva (Stranieri a noi stessi, ed. Donzelli) che ho appena finito di leggere e che parla di Europa, di politica, di religione e, ovviamente, dello straniero: l’idea fondamentale è che siamo noi stessi in quanto abbiamo un’identità riconoscibile (anche l’Europa ne ha una, magari difficile da afferrare in poche parole, ma ben chiara a contatto con gli altri – la Russia, ad esempio – o nel sentimento di chi «si sente» europeo), ma che questa identità non è affatto statica come tanti nazionalismi e razzismi ancora oggi cercano di farci credere, bensì in evoluzione permanente; la nostra identità cambia incessantemente, giorno dopo giorno, istante per istante, sotto gli scossoni della globalizzazione ma soprattutto al contatto con gli altri e con la loro diversità (che l’Europa, in cui sono presenti più lingue che nazioni, offre tanto generosamente). La nostra identità «cresce» (in questo senso «cambia») insieme a noi, come noi siamo sempre noi anche se diversi da ieri (più vecchi di un giorno, tanto per cominciare; più saggi, forse, certo più brizzolati). In questo ciascuno è «straniero a se stesso», sempre in parte nuovo, e sempre nuovamente in grado di relazionarsi con l’altro, lo straniero, appunto. Che non dovremmo certo cercare di emulare banalmente scordandoci di chi siamo; ma che nemmeno dovremmo fagocitare pretendendo che diventi in tutto e per tutto uguale a noi (lo straniero può integrarsi; non disintegrarsi, per poi risorgere a nostra immagine e somiglianza). Lo straniero non ci chiede di rinunciare alla nostra identità: ci offre solo l’opportunità di ampliarla (fenomeno che accade comunque, indipendentemente da quello che desideriamo: l’uomo non è impermeabile alla realtà, checché creda o desideri).
Kristeva, che nel discutere di questi temi nel contesto europeo odierno non trascura di considerare l’apporto delle tre grandi religioni monoteiste – il cristianesimo, l’ebraismo e l’islam – mi fa pensare all’estate; al fatto che ogni volta che parliamo dello straniero, è di noi che stiamo parlando (di quell’altra parte di noi stessi che lui è e che ci ricorda); e all’Europa: che 28 nazioni, straniera l’una all’altra, hanno deciso di mettere su e di portare avanti. Sognando magari, come cantava qualcuno (che era comunista), «una libertà diversa da quella americana».
J. Kristeva, Stranieri a noi stessi. L’Europa, l’altro, l’identità, ed. Donzelli, 2014, pp. 207, euro 30.






