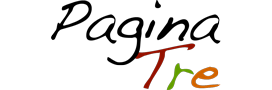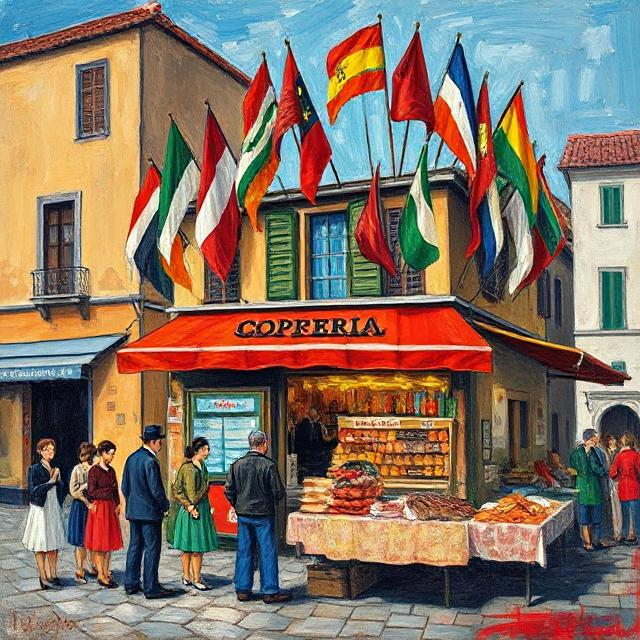Mentre la politica italiana si divide tra nostalgie missine e memorie comuniste, emergono interrogativi più profondi: come si formano i modelli di leadership? Quali pratiche educative possono prevenire l’esacerbarsi dell’aggressività sociale e politica?
La politica italiana è spesso paragonabile a una salsamenteria, un luogo dove il sapore della storia permea ogni scelta e ogni allineamento internazionale. Dietro il bancone, due eredità politiche apparentemente inconciliabili, quella di Giorgia Meloni, figlia del Movimento Sociale Italiano (MSI), e quella di Elly Schlein, erede del Partito Comunista Italiano (PCI), sembrano confrontarsi su temi diversi, ma in realtà attingono dalla stessa dispensa transatlantica. Tuttavia, dietro questa dialettica storica si cela una questione più ampia e fondamentale: la gestione dell’aggressività nei modelli di leadership e nella società.
La dinamica politica è spesso un riflesso di istinti più profondi e di pulsioni che si radicano nella natura umana, in particolare in quella maschile, dove l’80% delle manifestazioni di bullismo endogeno si verificano tra individui dello stesso sesso, spesso amplificate da dinamiche sociali di potere e competizione. Questa tendenza non è solo frutto di costruzioni culturali, ma ha una base biologica riconducibile alla presenza di ormoni di aggressività, che caratterizzano la dimensione maschile in molte specie mammifere e dunque anche nell’uomo.
Se l’aggressività pulsionale è una componente della realtà umana, essa è anche governabile attraverso strumenti pedagogici e sociali adeguati. Nella politica, come nella società, il problema non è tanto l’esistenza dell’aggressività, quanto la sua gestione. La storia del MSI, con la sua progressiva adesione all’atlantismo, e quella del PCI, con il suo dialogo con gli Stati Uniti, non sono altro che manifestazioni di un contenimento strategico della propria identità originaria per garantire la sopravvivenza politica.
Meloni oggi ripercorre le orme di quel pragmatismo adattivo, cercando un equilibrio tra la sua retorica sovranista e l’ineludibile fedeltà agli Stati Uniti. Schlein, dall’altra parte, raccoglie un’eredità che ha visto il PCI passare dal radicalismo ideologico a un graduale inserimento nelle dinamiche occidentali. Entrambe le posizioni, per quanto apparentemente contrapposte, sono espressioni di una dialettica politica che non si discosta dalle leggi della pedagogia del contenimento: governare le pulsioni aggressive attraverso strumenti culturali e diplomatici.
Se l’educazione è in grado di contenere l’aggressività nei giovani attraverso il dialogo, la dialettica verbale e lo studio delle forme più miti della cultura umana – come le arti, la letteratura e le scienze – allora la politica dovrebbe fare altrettanto. Non si tratta di idealismo culturalista, ma di una necessità strutturale: senza un’adeguata gestione delle pulsioni aggressive, la leadership politica rischia di diventare un’arena di competizione brutale, dove la violenza simbolica si traduce in instabilità sociale e diplomatica.
In fondo, la salsamenteria geopolitica in cui si muovono Meloni e Schlein non è altro che un banco di prova per una questione più ampia: come possiamo costruire modelli politici ed educativi capaci di governare le pulsioni aggressive e trasformarle in forza costruttiva? La risposta non sta solo nella storia o nella geopolitica, ma nelle aule scolastiche, nei percorsi formativi e nelle strategie educative capaci di preparare cittadini e leader a un dialogo maturo, capace di superare la mera competizione per il potere.
Nel frattempo, la politica continua a riempire il carrello della spesa con le sue scelte abituali, tra pragmatismo e opportunismo. Ma se davvero si vuole uscire da questa salsamenteria, forse è tempo di guardare oltre i vecchi schemi e iniziare a costruire un nuovo menu educativo e politico, capace di spezzare il ciclo dell’aggressività e della reazione automatica alle sfide della storia.