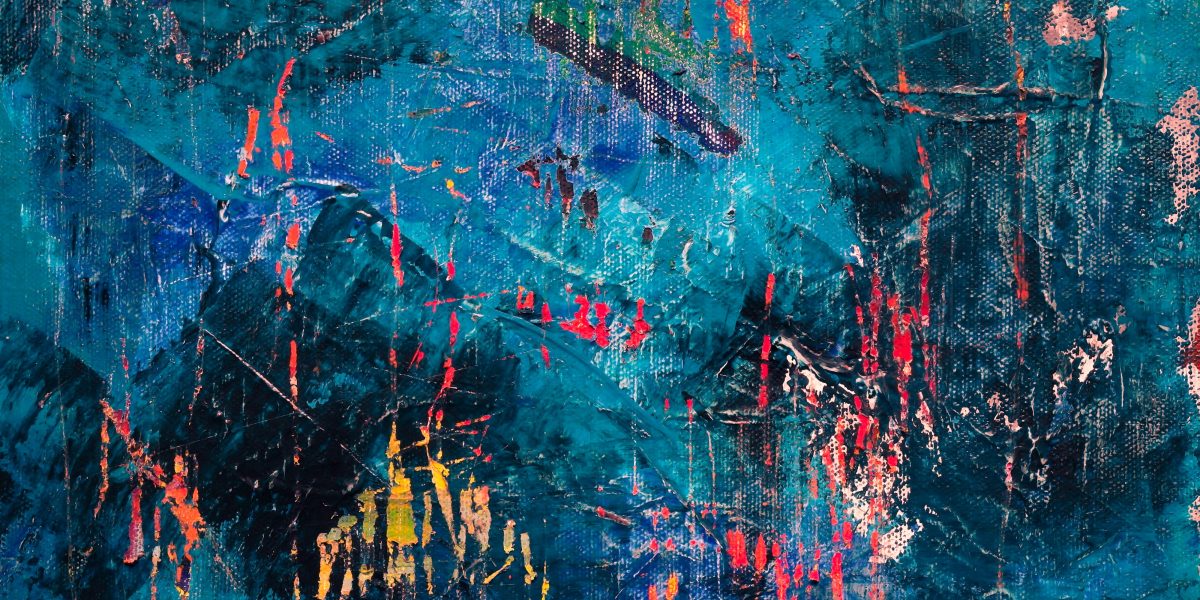Sono le otto del mattino quando alla fine esci e ancora non ci credi.
E’ il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, c’è il sole, e ancora non ci credi.
Il cancello si richiude alle tue spalle, ti guardi intorno. Libero. Ci credi, cazzo.
Di fronte a te c’è tuo fratello, il piccolo, con un sorriso bianco come le nuvole. Vi abbracciate. Lo senti solido e reale. Gli chiedi di guidare il motorino, metti la borsa con le tue cose in mezzo alle gambe e ve ne scendete lentamente dalla montagna, facendo curve molto larghe. C’è mare da tutti i lati, agitato e scuro, e l’aria è fredda. Arrivati giù c’è un altro cancello, chiuso, e per un attimo ti viene paura che si siano sbagliati, o che abbiano cambiato idea. Immagini divise blu che sorridono e scuotono la testa, stringi forte le mani sul manubrio del motorino e quando anche questo cancello si apre sei davvero fuori, sul lungo pontile che ti collega alla terraferma. Tiri il mezzo già sul pezzo non asfaltato, lo scooter sobbalza sui sanpietrini e ti lasci alle spalle la montagna e l’istituto penale minorile di Nisida, e non c’è molto altro da dire. E’ di nuovo Napoli, e te ne rendi conto subito aspirando forte l’odore di libertà. Tuo fratello da dietro ti fa un sacco di domande e ti passa una sigaretta accesa. Fai due tiri, te la ficchi fra mignolo e anulare per afferrare la manopola del gas a pugno stretto, come sei abituato, poi te la fai scivolare dalle dita. La brace è dispersa dal vento, il mozzicone finisce per terra e voi schizzate via. La tua vita, come quella sigaretta: prima l’hai accesa, poi l’hai fumata, e prima di metà l’hai buttata.
Fuorigrotta, Piazza Sannazzaro, il Corso Vittorio Emanuele, scendete per Spaccanapoli e finalmente sei al Centro Storico. Ti infili nel labirinto di vicoli come in una rinascita. Il tuo ti accoglie in un abbraccio di suoni e colori che ti erano stati rubati. Vieni schiaffeggiato da un misto di rabbia, senso di colpa e felicità. A casa ti aspettano tutti: le due sorelle, tuo zio, i tuoi cugini, i nipoti, tua nonna. Tua madre non c’è più da tanti anni. Tuo padre è carcerato pure lui, e non uscirà tanto presto. Come entri dalla porta ti fanno un sacco di feste. Tuo zio si affaccia al balcone e spara qualche botto per salutare il ritorno. Ti sembra di tirare il primo vero grande respiro da quando sei entrato in carcere quattro anni fa. Nisida è forse il posto più bello di Napoli, ma nessuno la conosce perché nessuno ci può salire, su quella montagna a strapiombo sul mare. Solo i gabbiani, i ragazzini carcerati e chi gli fa la guardia. Quando da dietro le sbarre vedevi il mare azzurro e i riflessi del sole sull’acqua ti veniva un tale groppo in gola che pensavi è meglio un carcere da cui non si vede niente, solo cemento e sbarre di ferro, ombre grigie e porte di piombo, perdere tutto e dimenticare tutto, fino a quando non si esce. La bellezza negata a portata di sguardo è una tortura che aumenta la pena, un’apnea lunga minuti, ore, giorni, mesi, anni, e non c’è molto altro da dire. La stanza che dividi con tuo fratello è rimasta uguale, ci sono ancora tutte le tue cose e le foto alle pareti. Sei cresciuto in fretta e alcune le cambierai. Ma non ora. Ora ti servono per riancorarti alla tua vita. Sorridi al tuo poster di Maradona che palleggia alla presentazione al San Paolo. Uno degli scrittori che è venuto a fare il laboratorio vi ha detto che non c’è mai stato nella storia del calcio un intero stadio pieno solo per vedere due palleggi di un giocatore appena acquistato. Solo a Napoli quando arrivò Maradona. Tuo fratello ti raggiunge e si siede sul letto con te. Allora, ti chiede, com’è stato? Ti guarda con curiosità, a bocca mezza aperta e con gli occhi spalancati. Sai che vorrebbe sentire storie di risse e equilibri, di privazioni e forza d’animo. Vuole vedere l’uomo nuovo che torna da Nisida. Ti accorgi che ti immagina diverso, migliore, più duro, come se il carcere ti avesse appuntato in petto qualche medaglia. Non sa che tu pensi di aver trovato solo dubbi e pazienza. Sorridi e cambi discorso. Gli dai un buffetto. Gli disordini i capelli. Lui ti scosta la mano sbuffando. Fa la voce grossa. Finite a fare la lotta e a ridere abbracciati, come due bambini.
Sotto la doccia sei solo un’altra volta. Ti strofini bene per lavare via la puzza del carcere. Non sapresti spiegarlo a nessuno che non è stato recluso, forse non è nemmeno un odore, è come una patina di tristezza e di chiuso, un peso leggero e denso che ricopre la pelle e i capelli; qualcosa, comunque, che vuoi toglierti di dosso.
Sono tutti in cucina, divisi in due gruppi. Da un lato, ai fornelli, le donne cucinano i fagioli in una grossa pentola e parlano del più e del meno appoggiate al piano della cucina. Dall’altro lato della stanza i maschi a tavola confezionano dosi di cocaina. Bilancino, forbici, buste di plastica, accendini e schede telefoniche. La tua famiglia vive di questo. Tuo nonno era contrabbandiere, negli anni ’80 solcava i mari di notte sullo Squalo 28 facendo a gara con i motoscafi della Guardia di Finanza, ed era un eroe per tutto il quartiere. Altri tempi. Negli ultimi vent’anni l’attività di famiglia è diventata lo spaccio di cocaina. La cocaina è vita e morte, benessere e problemi. La comprate a 100 grammi alla volta per non fare la spesa troppo spesso e perché così risparmiate. La tagliate, la confezionate e la vendete al dettaglio in bustine da 50, da 30 o da 10 euro. Non la conservate mai tutta insieme e mai negli stessi posti per troppo tempo. La nonna impugna la cucchiarella di legno con le mani nodose e mescola sempre con lo stesso ritmo e sempre nello stesso verso. Intorno a lei tutte le donne di famiglia. La nonna dice che se cambi verso mentre mescoli, la roba si sciupa e va a male. La nonna dice un sacco di cose di questo genere e tutti tendenzialmente le credono. Si tratta di quel sentenziare tipico, frutto di considerazioni prive di qualunque dimostrazione, tramandate di generazione in generazione, la cui origine è persa nel tempo e che nessuno mette in dubbio: certezze che ti si appiccicano addosso e che anche tu ripeterai convinto negli anni. La nonna ti chiama vicino a sé. Ti racconta che una volta, mentre tu stavi dentro, stava facendo il ragù e i maschi stavano lavorando come adesso con la roba. Ha bussato la porta e tutti si sono agitati perché era una giornata di controlli e di perquisizioni. Lei ha detto non vi preoccupate e buttate tutto qua dentro. Allora tuo zio ha preso e ha buttato la coca nel ragù. Hanno aperto la porta e invece che la polizia era Nunziatina, la vostra vicina che non ci sta tanto con la testa. Allora la nonna ha preso col coppino un po’ di ragù e ha detto “Nunziatì, vuò assaggià? E’ ‘na specialità!” E tutti quanti si sono messi a ridere, mentre Nunziatina si guardava intorno con gli occhi a palla senza capire niente. “Sti quattro canteri dei parenti tuoi mi hanno costretta a buttare tutto, e invece secondo me co nu poco e’ pubblicità o’ rrau’ a cocaina se puteva vennere a dieci euro a piatto.” Tua nonna è una gran donna e tu la adori. Vi sedete a tavola per mangiare e lei continua a tenere banco, a cazziare tutti, a parlare di tutto, a raccontare storie vecchie e nuove. Anche le storie tristi quando le racconta tua nonna ti strappano un sorriso. Lei è la Napoli che si avvia a scomparire, una Napoli polverosa e fiera che fa fatica a tenere il passo con tutto quello che cambia. “State tutti quanti semp’ ca capa dint a stu smarfòn, ma dich’io, nun ci putimm verè a televisione tutte quante assieme?” Tua nonna non ha mai avuto un cellulare e non ne capisce senso e utilità. Confonde le funzioni degli apparecchi fra loro, cerca sul citofono i tasti per comporre un numero di telefono, cerca di abbassare il volume del televisore col telecomando dello stereo. Il pranzo a casa è una cosa che ti eri quasi dimenticato. Tutti vogliono sentirti parlare di Nisida, ma tu non ne hai troppa voglia, è una cosa fatta, passata, e dentro di te pensi che non ci vuoi più tornare, anche perché la prossima volta sarebbe Poggioreale, e Poggioreale non è Nisida. Non hai voglia ma qualcosa racconti, mentre finisci di raccogliere il sugo col pane. Parli degli altri ragazzi che erano dentro, alcuni conosciuti, di famiglie importanti, altri mai visti e mai coperti, di qualche episodio buffo, e di qualche faida che si è trascinata fino a dentro le mura di Nisida, ma mentre parli in realtà pensi alle maestre, che vi hanno trattato come dei figli, al torneo di calcetto, e ai laboratori di arte presepiale, di pasticceria e soprattutto di ceramica, quello che hai frequentato tu.
I bambini a un certo punto scappano fuori a giocare. Il più piccolo scalpita, ha avuto un quad 150 per Natale e non si è ancora stancato di provarlo. Tuo zio ti racconta che ha fatto l’affare tramite l’amico di un amico e l’ha pagato 1500 euro e tu pensi benedetta cocaina che ci fa togliere pure gli sfizi. C’è un regalo anche per te, aspetta sotto l’albero da due giorni. E’ una maglietta nera di Gucci e la indossi subito. Dopo pranzo arrivano due ragazzi che non conosci. Sono clienti abituali, tua nonna li fa accomodare e prepara il caffè. Loro si siedono a chiacchierare del tempo, del fatto che fa più freddo perché c’è il vento Buran, tua nonna gli offre gli struffoli ma loro dicono no, che hanno già mangiato troppo alle feste. Prendono il caffè e poi mettono 150 euro sul tavolo e tuo zio gli consegna tre bustine. Sono tutti allegri. Tua nonna li accompagna alla porta, quando torna verso il tavolo tuo zio si sta mettendo i soldi in tasca, tua nonna lo ferma prende 50 euro e te li mette in mano. Ti da un bacio in fronte e dice bentornato e buon Natale, guagliò, vatti a divertire.
Tu e tuo fratello uscite col motorino. Napoli è tutta apparecchiata, illuminata e profumata. I fumi dell’inverno sembrano il respiro dei teschi di bronzo incastonati nelle facciate delle chiese, avvolgono i profili barocchi degli edifici rovinati e i vestiti mezzo lana e mezzo acrilico appesi ai ganci sulle bancarelle, appannano le vetrine dei negozi di dolci, si mischiano alle esalazioni delle friggitorie da asporto e si fermano poi a qualche centimetro da terra, come un tappeto, unendosi ai vapori degli escrementi dei cani. I turisti camminano avanti e indietro imbambolati per i vicoli, perdendosi in continuazione e sbalordendo di fronte alla sciatta naturalezza con cui Napoli gli si offre. In piazzetta vedete vostro cugino con il quad. Ha otto anni e il quad è grosso, lui sembra quasi scomparire nel sedile. Per arrivare al manubrio deve allungare al massimo le braccia sottili, ma non si perde d’animo. Fa salire i suoi amici a uno alla volta per fargli fare il giro, sgasa, fa rombare il motore, sale sui marciapiedi accelera, inchioda, terrorizza i passanti. Uno scugnizzo di Napoli a otto anni già non è più un bambino. La città con due anime. Unite e divise a metà, sottratte e poi raddoppiate. Ti tornano in mente le cose che ti raccontavano le maestre in carcere. Ricordi la sorpresa che hai provato la prima volta che ti sei reso conto che capivi tutto quello che ti spiegavano. Vedi che tuo cugino sta cercando di fare il cavallo con il quad. Gli altri bambini lo guardano ammirati e invidiosi. Lui si sforza ma non ce la può mai fare. Non vuoi rovinargli la festa ma è troppo piccolo e il quad ha quattro ruote ed è pesante. Vi avvicinate, tuo cugino è contento, ti presenta agli altri bambini. Sei uscito oggi e quindi sei un personaggio. Fai scendere tuo cugino e il suo amico e gli fai vedere come impennare. Spinta all’indietro con i reni e colpo di gas, in contemporanea, e le due ruote davanti si sollevano. Ve ne andate fra applausi e fischi, lasciandoli a giocare. Tuo fratello ti porta a salutare i tuoi amici. Ti accolgono con baci e abbracci, fratemo qua, fratemo là. Ti vogliono offrire il caffè o la birra, ti passano gli spinelli, ti fanno vedere i nuovi tatuaggi. Ci sono quasi tutti, e fanno le stesse cose di prima e di sempre, tranne Rosario che è stato arrestato e sta a Poggioreale (quando lo nomini scuotono la testa e fanno il gesto delle cinque dita aperte a ingabbiare la faccia) e Peppe che è andato a vivere in Inghilterra. Pare che faccia il lavapiatti in un ristorante al centro di Londra e ha una fidanzata con i capelli rossi. Londra te la immagini scura e piovosa con palazzi grigi molto alti, gli autobus rossi e i taxi neri, come hai visto in qualche film. Tuo fratello riceve una telefonata. Ti dice che deve andare a fare una consegna e che se vuoi lo puoi aspettare lì, ma tu preferisci accompagnarlo. Sali sul motorino dietro di lui e ti incazzi. Una consegna. Tu sei appena uscito di carcere e lui già deve fare una consegna. Non basta che vengono a casa? Dove ce l’ha, nelle mutande? E la capa? Dove ce l’ha? Mmiez’ e’ ppall? Tuo fratello ascolta tutto e poi dice tu sei appena uscito ma comunque bisogna campare. Vuoi scendere? Ti recupero dopo. No, che non vuoi scendere. “Andiamo a fare sta cazzo di consegna”, gli dici. Il cliente aspetta a Salvator Rosa, in piedi, vicino alla fermata dell’autobus. Non l’hai mai visto, è nervoso e si soffia nelle mani per il freddo. Quando vi vede riconosce tuo fratello e si avvicina sorridendo e facendo gesti. Tuo fratello non ti presenta e mentre infila la mano nelle mutande tu guardi da tutte le parti per controllare se ci sono guardie. Fate veloce e mentre ve ne andate insulti ancora un po’ tuo fratello, ma alla fine stai allegro, sei tornato alla tua vita, sei libero, canticchi Pino Daniele, Napoli è bellissima, puoi fare il cazzo che vuoi, e non c’è molto altro da dire.
Stai pensando a cosa vuoi fare quando un motorino con due tizi sopra vi affianca e vi fa segno di accostare. Uno dei due te lo ricordi. E’ della famiglia De Simone, una famiglia dei Quartieri con la quale, se ti ricordi bene, avete buoni rapporti. Tuo fratello accosta fluido e rimanete seduti sul mezzo. Quello di dietro scende e si avvicina. Ti vede e ti saluta con un cenno. Sei appena uscito e c’è un po’ di riguardo nei tuoi confronti. Però il tizio passa subito a tuo fratello e gli dice che qua non può vendere. E’ la seconda volta che glielo dice. O divide a metà con loro o non può vendere. Non glielo vuole dire una terza volta. Dalla cinta di quello che è rimasto sul motorino spunta il calcio di un ferro. Lo vedi di smerzo, per abitudine. Tuo fratello dice “guagliù vuie c’avite fa campà.” Quello risponde “si vuò campà ti ‘e mparà a ‘o ffà.” Lo chiama “muccusiè.” Tuo fratello dice “nu’ spustà ‘ca vocca” e fa il gesto di scendere dal mezzo. Tu lo fermi e metti pace. “Che cazzo”, dici, “sono appena uscito e queste sono questioni che si risolvono davanti a un caffè, più in alto di noi.” Quello sul motorino dice “che cazzo ne sai tu addò se risolve ‘sta questione”, e comunque loro l’avvertimento ve l’hanno dato. Ve ne andate tranquilli. Tuo fratello ti fa un riassunto dei nuovi equilibri del Sistema e delle spartizioni del territorio. Tu ti guardi intorno allungandoti all’indietro sul sellino, sai che sono tutte cose a cui ti dovrai riabituare in fretta, ma per il momento sorridendo fra te e te dici “a me ‘sta discussione m’ha fatt arrizzà o’ cazz’”.
Tuo fratello ti lascia sotto il palazzo e dice “ti vengo a prendere fra un’ora”. Sali le scale un po’ emozionato: non scopi da quasi quattro anni. Arrivi sul pianerottolo, ti aggiusti un po’ i capelli con la saliva, ti sistemi la felpa abbassando la zip fino al centro del plesso solare lasciando in vista un triangolo della maglietta di Gucci, prendi un respiro pieno e pulito e bussi. Lei apre in vestaglia nera e scarpe coi tacchi, bruna, bellissima e profumata. “Tesoro, e tu che ci fai qua”, ti chiede sorridendo, “non stavi a Nisida?” Tu ti imbarazzi perché la conosci, è Jessica, faceva la commessa dal gelataio a piazza Dante, la sai benissimo, tuo fratello l’ha fatto apposta e non te l’ha detto, per questo sorrideva quando ti ha lasciato sotto al portone. Lei ti dice “non fare quella faccia, avvicinati, so’ contenta che sei venuto, ti ho sempre voluto scopare”. Ti abbandoni, ti immergi e affondi. Quando riemergi mentre ti rivesti lei ti racconta che dal gelataio guadagnava 700 euro al mese, ora ne guadagna anche 700 al giorno. Ha solo il problema che non si può fidanzare, perché nessuno vuole una fidanzata che batte, e allora vuole mettere un po’ di soldi da parte e poi smettere, fidanzarsi, sposarsi, farsi una famiglia. Quando vi salutate lei ti bacia sulle labbra mettendoti una mano sulla nuca e non vuole i 50 euro che le offri. “E’ il mio regalo di bentornato”, ti dice. “Se ti è piaciuto torna e la prossima volta paghi.”
Scendi le scale a due alla volta, felice e leggero. Tuo fratello ti aspetta giù, seduto sul mezzo, sorridente, con una canna d’erba fra le labbra. Te la passa e mette in moto. Sfrecciate contromano fra le luci che tremolano, gli odori che cambiano di vicolo in vicolo, il vento in faccia e le voci che come in un imbuto si incontrano e si fondono in una sola, quella che ti ha cullato da quando sei nato, quella che ti suona nelle vene, nei muscoli e nelle ossa. Vi fermate in un bar dove qualche volta andavi prima di essere arrestato. Ti scorrono in mente all’improvviso le immagini dell’arresto: Carmine che insiste e ti convince, tu non sei amante, ne hai fatti solo altri due qualche anno prima, non ti piace, in fondo non ne hai bisogno, la tua famiglia fa spaccio, una cosa fatta bene, senza violenza, una questione di domanda e offerta, ma le cose a volte in questa città vanno così, in una specie di inerzia attiva in cui può accadere qualunque cosa, e così ti prepari, ti tiri tre strisce di coca in venti minuti, prendi il coltello, ti allacci le scarpe strette, scendi di casa. Carmine ti passa a prendere col Beverly, il sorriso storto stampato in faccia come un tatuaggio sbagliato. Senza pensieri iniziate il giro lenti e attenti, come due squali. Scartate bersagli senza criterio, solo per continuare a girare, per caricarvi come molle, per aspettare di essere pronti. A un certo punto, quando lo siete, vedete una coppia a via San Sebastiano. E’ tardi, sono le tre di notte, camminano barcollando, sembrano ubriachi, lei ha la borsa di pelle verso l’esterno, vi sembra facile: vi accostate, tu afferri la borsa e tiri forte con uno strattone. Ma lui non è ubriaco o comunque è molto forte e veloce, acchiappa la borsa, si mette in mezzo, spinge, ansima, ha le braccia dure come la pietra, ti tira un pugno, ti prende in pieno, tu e Carmine cadete a terra, il mezzo a contatto con l’asfalto fa scintille, la ragazza grida, una finestra si apre di schianto, senti un colpo di clacson, da qualche parte un cane si mette ad abbaiare, l’adrenalina pompa, sfili la gamba da sotto il Beverly, salti in piedi, sei una molla, il cuore ti martella nel petto, tiri fuori il coltello e colpisci due volte verso il basso, cercando l’impatto con il bersaglio grosso. Alzate il motorino, lo mettete in moto, sbandate due volte, scappate senza borsa. Non parlate finchè non vi separate sotto casa tua. Hai la bocca impastata e la gola secca. In cucina ti attacchi al rubinetto e bevi un litro d’acqua. La nottata finisce così e poi è tutta storia di sfortuna, destino, caso, quella roba là. Il ragazzo fortunatamente non muore, gli hai mancato di poco l’arteria femorale. Ma comunque si scatena la caccia all’uomo, vi prendono in due giorni. Carmine quando lo interrogano dice la verità, non ce l’hai con lui, non hai intenzione di andarlo a cercare, né per male, né per bene. E’ una cosa passata, non ci sono conti in sospeso. Lui non ha avuto nemmeno la fortuna di andare a Nisida. Aveva 22 anni ed è andato dritto a Secondigliano. Non vuoi sapere più niente di lui. Questo è, così è andata, te la sei cercata e non c’è molto altro da dire. Le immagini di te che accoltelli (è strano come ogni volta tu ti veda come se fossi fuori dal tuo corpo, con stupore e tenerezza vedi il pugno chiuso, le nocche bianche intorno al manico di plastica del coltello, i denti digrignati, le labbra secche spaccate, gli occhi iniettati di sangue, i capelli sudati, una pallina di saliva in gola, il braccio che carica, colpisce, affonda), le immagini tremano, si diradano, sfumano, e torni nel bar con tuo fratello come se precipitassi. Intorno a voi ci sono gli altri clienti, sagome confuse e sfocate che poco alla volta riprendono dimensioni, contorni e colore. La musica (lo sai?) è un ragamuffin di Ini kamoze e si diffonde nel locale in tutti gli angoli a volume molto alto. Quello che sai è che non ti paralizzi quando vedi entrare due tizi coi caschi integrali e le pistole in mano. Ma nemmeno ti muovi. Rimani immobile sullo sgabello fino a che non cominciano a sparare. Allora ti butti a terra tirandoti tuo fratello e ti stendi sul pavimento chiudendo gli occhi e tenendolo a terra. In pochi secondi è tutto finito, vi alzate, vi guardate intorno. Incroci gli occhi degli altri clienti. C’è una sospensione di fumo nell’aria. Lo scambio di sguardi continua, poi ci si guarda intorno nel locale. Non si vedono danni apparenti. Nessuno è ferito. Il titolare si avvicina alla parete e passa il dito su quattro fori, poi si volta verso di voi e alza le spalle. Gli altri un po’ alla volta recuperano i loro bicchieri. La musica riparte, il fumo si dirada. Il titolare si rivolge al suo barman: “Gennà, che dici?” Gennaro risponde: “Michè e che t’aggia dicere? Comunque ci conviene chiamare, perché a finale poi qualcuno parla, lo vengono a sapere e facimm’ peggio perché passiamo dalla parte del torto”. Il titolare annuisce stancamente e dice “la serata è chiusa, chiamali, ià.” Gennaro compone il 113, mentre il locale si svuota abbastanza velocemente. Anche tu e tuo fratello scivolate fuori di nuovo nella notte, di nuovo su due ruote. “A chi cercavano?”, chiedi, “mica cercavano a te?” “Non penso proprio”, dice tuo fratello, “secondo me era ‘na cosa contro al locale, oppure si so’ sbagliati”. ‘Sta città nun ‘a capisco cchiuuù”, gridi al cielo come un lupo, e ti dimentichi di essere proprio tu la prima cosa che non conosci e non riesci a capire. Una cosa in frantumi che va ricomposta. La città invece è compatta, i suoi pezzi rotti legati insieme strettamente. Napoli è Napoli: si incazza ma non esplode, assorbe tutto, tutto sopporta, si piega ma non si spezza, come un giunco nella tempesta.
La notte sogni frantumi. Decine di pezzi di specchio in frantumi che rimandano la tua immagine divisa e mal ricomposta, sparsa per la stanza. Ti aggiri scalzo facendo attenzione a non tagliarti e osservando i riflessi del tuo volto ora lungo, liscio e sottile, ora grasso e incarognito. Ti chini per guardarti meglio nel pezzo più grande e poi ti svegli di soprassalto. Tua nonna ti strappa al sogno, ti strattona e grida: “‘o Terremoto! O’ Terremoto!” Scatti giù dal letto, afferri tuo fratello per il pigiama, lo scaraventi fuori dalla stanza, prendi al volo due giubbotti, due paia di scarpe e in un minuto tutta la famiglia è fuori di casa. Vi radunate giù al vicolo, che un po’ alla volta si riempie. Vedi anche Jessica, e vi sorridete. Ti guardi: le scarpe slacciate sotto il pigiama rosso di lana, il bomber nero chiuso fino al collo, gli occhi di sonno. Ti frughi nelle tasche del bomber e trovi un cappello di lana e cinque euro stropicciate e pensi che ci vuole una bella colazione al bar e sei indeciso se offrirla a Jessica o a tuo fratello. Ti sistemi il cappellino in testa, allisci la banconota fra le dita e mentre capite che non è il terremoto ma solo un pezzo di cornicione franato, e il vicolo si popola di gente in vestaglia, mentre vi scambiate le prime frasi di circostanza, mentre la comunità si riconosce e si rassicura, e tutti guardano verso l’alto, verso il balcone da cui si è staccato il pezzo di pietra, e in alto puoi vedere solo il cielo ma non il sole perché nei vicoli i palazzi sono fitti, una muraglia di tufo, cemento armato e panni stesi ad asciugare, tu pensi per un attimo, chissà perché, alla finitura dell’ultima ceramica che hai fatto a Nisida, una piccola caraffa da latte, decorazione verde su bianco, pensi alla nuova vita che avrà quell’ oggetto fatto da te con le tue mani, e te ne rimani lì, padrone a metà del tuo tempo, impalato, con cinque euro in mano, più curioso che spaventato, fortemente pregiudicato, segnato, terremotato, inutilmente disturbato, svegliato di soprassalto da un sogno frantumato. Vivo.
Fine.