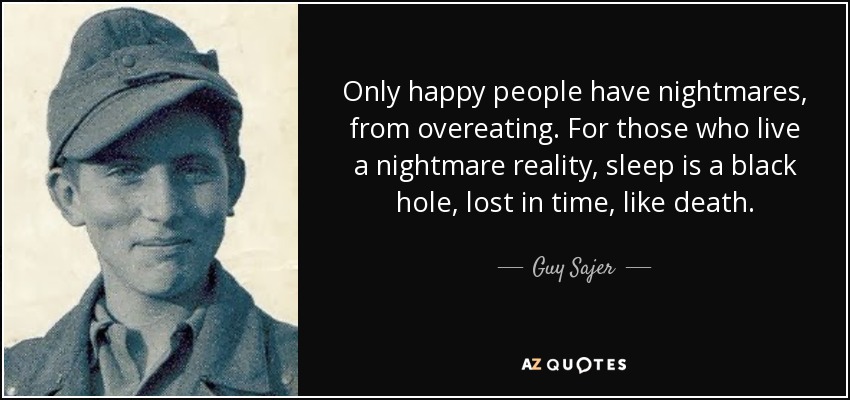Podcast: Apple Podcasts | RSS
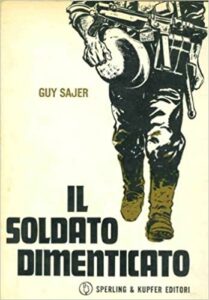
Guy Sajer, Il soldato dimenticato, Sperling & Kupfer Editori, Milano 1972, pp. 446, ISBN 2019022100498
Sono sbalordito. Dalla dolorosa lettura di questo libro, intendo.Un racconto terrificante, ma molto utile a superare gli stereotipi del soldato tedesco creati da una moltitudine di film. L’autore, questo va ammesso,è un soldato un po’ atipico.
Guy Mouminoux era nato a Parigi il 13 gennaio 1927. Suo padre era francese del Massiccio Centrale. Sua madre, che da nubile si chiamava Sajer, era invece tedesca, della Sassonia. Abitavano in Alsazia e, quando questa regione fu incorporata al Reich, Guy venne arruolato nell’esercito tedesco. Non aveva ancora sedici anni.
Atipico anche perché Guy – che aveva assunto per l’occasione il cognome della madre, Sajer – entra nell’azione quando ormai l’esercito del Reich ha esaurito la sua spinta d’assalto. La sua sarà una ritirata di quasi tre anni attraverso le steppe orientali.
A parte qualche concessione adolescenziale, né lui né i suoi compagni mostrano tracce della retorica di regime, né di accanimento sui civili o sui prigionieri. Tema del racconto sono piuttosto le inenarrabili sofferenze, la paura, l’angoscia, la disperata volontà di sopravvivere.
Il racconto ha inizio il 18 luglio del 1942. Dopo il primo addestramento, a metà settembre arriva in Polonia, inquadrato nei servizi ausiliari (19° Kompanie Rollbahn): scorte ai treni e rifornimenti. E in queste funzioni conosce il fronte del Don in piena battaglia. Già lì (siamo a p. 72 di 441) è costretto ad ammettere: «Dovrei finire qui il mio racconto, perché credo di non essere capace di riferire tutto come si dovrebbe. Coloro che non hanno vissuto momenti simili leggeranno queste righe come si legge un qualsiasi dramma, impietosendosi, certo, ma senza veramente capire. Non si può capire quello che è divenuto inspiegabile. Perciò questo mio balbettamento è privo di interesse per quel lato del mondo in cui mi trovo ora. […] Tenterò di cogliere e di tradurre l’abisso dell’aberrazione umana, quello che non avrei mai potuto immaginare, quello che mi sembrerebbe impossibile se non lo avessi provato…». Non era che l’inizio.
Nella primavera 1943 è già un veterano (da pochi mesi ha compiuto 16 anni!) e viene inquadrato nella Divisione di fanteria motorizzata ‘Gross Deutschland’, truppe scelte.
Non c’è nessun tentativo – direi, anche, nessun interesse – a fare di sé un eroe. Anzi, impietosamente racconterà, nella seconda parte del libro, la paura paralizzante che lo colse nell’unica occasione in cui fu a capo di un gruppo di uomini (18, contro 70 tank sovietici). Il motivo per cui chiede dignità sono le sofferenze subite. E questo intende raccontare. «La Divisione Gross Deutschland fece spesso prodigi che furono citati ufficialmente all’ordine del giorno. Dovunque apparisse, i combattenti delle trincee riprendevano speranza e, con il nostro aiuto, mettevano in fuga il nemico. Così, generalmente, andarono le cose, ma naturalmente non si parlò mai delle nostre difficoltà, del nostro accerchiamento, della disperazione dei soldati costretti ad abbandonare il loro materiale in quell’oceano di fango. E neppure si parlò delle successive ricostruzioni di quelle unità, per sostituire i Reggimenti annientati. Non si parlò dello Steiner, né del capitano Wesreidau volatilizzato, dell’aiutante e della sua Sezione fatta prigioniera e troppo tardi liberata dal nostro Kommando, della disperazione profonda che piombò sui fanciulli cresciuti in fretta che eravamo, costretti alla prospettiva di affrontare un secondo inverno in guerra, del ponte umano sul Dnieper, dell’abbandono di interi Reggimenti di uomini congelati, della terra bruciata, delle settimane di terrore a Tchernigov, delle nostre mani spaccate dal gelo e della nostra funerea rassegnazione dinanzi all’idea della morte. I generali hanno scritto, più tardi, racconti sintetici sul complesso degli avvenimenti. Hanno situato le catastrofi, hanno scritto una frase o dieci righe sulle perdite subite per malattia o per congelamento. Mai, che io sappia, danno alcuna importanza alla desolata angoscia del soldato spesso abbandonato a una sorte che si cerca di risparmiare persino a un cane rognoso. Mai hanno evocato le ore di agonia e di miseria…» (pp. 209-210)
Come è naturale in un libro di memorie, le vicende personali raccontate non permettono di chiarire il quadro d’insieme. Né è sua intenzione farlo. «Da queste righe si trarrà soltanto un’idea generale della situazione, ma nessun particolare, né ho intenzione di scrivere per tracciare carte topografiche degli avvenimenti della guerra germano-russa. Non è questo che mi importa e che mi assilla, ma il pensiero delle incredibili difficoltà che noi landser dovemmo superare. Dei nostri spostamenti e delle zone di operazione non ho mai avuto se non un’idea approssimativa e sarei certamente incapace di tracciare con esattezza una linea del fronte in una qualsiasi fase della guerra. Questo spetta ai dissolti Stati Maggiori. Io posso, invece, descrivere, poiché non ho dimenticato nulla, il minimo particolare di certi momenti. Basta un odore a risvegliare in me tutto un passato tragico che spesso mi lascia pensoso e inerte per lunghe ore» (p. 216).
Ed è proprio questo che, mi pare, aiuta a superare gli stereotipi cui accennavo prima. Anche perché il racconto di Sajer non risparmia nulla, neppure le brutalità commesse sotto la spinta di una folle paura. Raccontando della pazzesca battaglia di Bielgorod, ammette: «Eravamo istupiditi, vessati, stanchi, annientati fisicamente, e soltanto con i nervi tesi all’estremo ci permettevamo di affrontare il rischio continuo […] O loro o noi, non vi era scampo. Quando alla fine della nostra avanzata ci lasciammo cadere sfiniti in fondo a un fossato, ci guardammo a lungo l’un l’altro, con occhi sbigottiti e infelici, prima che uno di noi potesse articolare una parola. […] Proprio in momenti come quelli tutto diventa più amaro e pesante. A poco a poco riprendevamo coscienza e incominciavamo a renderci conto con angoscia di tutto quello che era accaduto. […] Troppi particolari atroci, inesplicabili. Bruscamente irrompeva nei nostri pensieri qualche spaventoso gesto e ci faceva fremere fino alla radice dei capelli. A quelle evocazioni, tutto il mio corpo diventava insensibile ed ero tentato di ammettere uno sdoppiamento della mia personalità. Non potevo credere di averlo fatto, sapevo di esserne incapace, non perché mi considerassi migliore di un altro, ma perché sapevo che non si può fare tutto questo quando si è ragazzi cresciuti in una vita normale come chiunque di noi. No, non potevo crederlo. Impossibile, impossibile! Eppure domani di dovrà ricominciare» (p. 184 e 186)
Di battaglia in battaglia, di orrore in orrore, lo spirito inaridisce. «L’orizzonte è vuoto di ogni promessa» (p. 355). Miracolosamente per tutta la guerra un gruppo di commilitoni, ormai diventati fratelli, rimane vivo e unito. Questa è una delle forze di sopravvivenza che impedisce il suicidio. Non certo la certezza dell’idea. Nel settembre 1944 la loro unità è arretrata nel sud della Polonia, in fase di riorganizzazione. «L’ufficiale, che continuava il suo discorso, parlava di controffensiva, di ripreso dominio della situazione, di riorganizzazione e, perché no, di vittoria. Quest’ultima parola non aveva più senso per nessuno. Benché non potessimo concepire la disfatta che seguì, non potevamo più in ogni caso sperare nella vittoria. Sapevamo che saremmo stati costretti a fare ancora un enorme sforzo da qualche parte, su posizioni previste e organizzate, ma non dubitavamo di riuscire ad arrestare il nemico dinanzi alle porte della Germania» (p. 371).
E invece le terribili battaglie in Lituania e nella zona di Danzica fanno crollare questa certezza. E quando l’unità si sposta a occidente, l’amara sorpresa. Per quanto incredibile, solo nell’aprile del 1945 Sajer e i suoi compagni apprendono dell’avanzata da ovest degli anglo-americani; e anche – cosa che lo dilania nello spirito – che con loro combatte il ricostituito esercito francese.
Quando la guerra si concluse, Guy aveva da poco compiuto 18 anni («Si invecchia presto in tempo di guerra» – p. 331). Tornò a vivere in Francia, dove a lungo dovette subire sospetti e pregiudizi. Iniziò una lunga carriera di disegnatore e sceneggiatore di fumetti con lo psuedonimo di Dimitri, o anche di Dimitri Lahache.
Nel 1952, durante una lunga malattia, iniziò a scrivere i suoi ricordi. Impiegò cinque anni e 17 quaderni scritti e illustrati a matita. Ma non servì allo scopo che si era proposto: «Adesso io so che la mia angoscia non se ne andrà via con queste righe, attraverso le quali avevo tanto sperato di liberarmi. Mi rendo conto, purtroppo, che questa angoscia mi seguirà fino sull’orlo della tomba» (p. 191). Dieci anni dopo, amici e colleghi lo convinsero a pubblicarlo. Il libro vide la luce in Francia nel 1967 e da allora è stato tradotto in 38 lingue (in Italia uscì da Sperling & Kupfer nel 1972) e ha venduto più di 3 milioni di copie.
Pagine terrificanti, dicevo in apertura. Che fanno soffrire. Così come mi fa soffrire l’aperta ribellione a Dio, che ritiene responsabile di non essere intervenuto a impedire l’inferno. Del resto, afferma l’autore, è proprio così che va letto un libro di guerra che sia vero: «Troppa gente fa conoscenza con la guerra senza il minimo affanno: si legge tranquillamente in una poltrona o nel proprio letto di piume, il sedere al caldo, la storia di Verdun o di Stalingrado, senza comprendere, e il giorno dopo si riprendono i propri proficui affarucci di sempre… No, questi libri bisogna leggerli nella scomodità, con sforzo […]. La guerra va letta in piedi, vegliando fino a tarda notte, anche se si ha sonno. Come la scrivo io stesso, finché non spunti l’alba, e la mia crisi d’asma abbia ceduto prima di me» (p. 216)