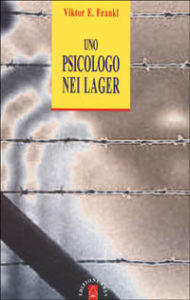 Viktor E. Frankl, Uno psicologo nei lager, collana «Anima & psiche» n° 4, traduzione di N. Schmitz Sipos, Edizioni Ares, Milano 2009 (ventesima edizione), pp. 160, euro 15,00. Codice ISBN: 978-88-8155-046-3
Viktor E. Frankl, Uno psicologo nei lager, collana «Anima & psiche» n° 4, traduzione di N. Schmitz Sipos, Edizioni Ares, Milano 2009 (ventesima edizione), pp. 160, euro 15,00. Codice ISBN: 978-88-8155-046-3
N. 119.104. Così, con il solo numero di prigioniero nel campo di sterminio di Auschwitz, voleva presentarsi Viktor E. Frankl pubblicando Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (lett.: «Dire sì alla vita, nonostante tutto. Uno psicologo nei lager»): un modo per non concentrare eccessivamente l’attenzione su di sé e sulla sua esperienza. Solo in fase di correzione di bozze gli amici riuscirono a convincerlo che l’anonimato avrebbe tolto valore alla «confessione».
E proprio il libro che non avrebbe dovuto dargli notorietà è oggi tradotto in più di venti lingue; nei soli Stati Uniti si contano oltre ottanta edizioni e più di tre milioni di copie vendute. Per ben quattro volte è stato dichiarato dalle università americane «libro dell’anno» e la Library of Congress ne ha indicato l’edizione statunitense come uno dei 10 libri più influenti d’America.
Viennese d’annata 1905 (morirà nel 1997) mostra subito grande e precoce profondità. La sua passione per la psicoanalisi lo porta, ancora adolescente, ad intraprendere uno scambio epistolare con lo stesso Freud, che intravede in lui una spiccata predisposizione per tali studi; decide di inoltrare un suo scritto sulla mimica dell’affermazione e della negazione alla «Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse», che lo pubblica nel 1924. Frankl scrive anche per la rivista di Alfred Adler, un altro discepolo di Freud, ma i rapporti con quest’ultimo terminano dopo circa due anni. In tale occasione decide di fondare l’«Akademische Verein fur medizinische Psychologie». Da vicepresidente della suddetta associazione tiene un discorso in cui per la prima volta parla di «logoterapia». Per questo metodo, ideato da Frankl, si è parlato di «terza scuola viennese», dopo quella psicanalitica di Freud e quella della psicologia individuale di Adler, entrambi, al pari di Frankl, viennesi ed ebrei.
Questa teoria, che Frankl giunse a formulare sulla base di approfonditi studi psichiatrici, neurologici e filosofici, ma ancor più su una vastissima esperienza terapeutica, si basa sul convincimento che la causa della maggior parte delle neurosi vada ricercata nella perdita del senso della vita, nell’incapacità di dare significato all’insieme della propria esistenza normale e a talune circostanze particolarmente difficili: un problema ripetutamente definito come «il male del secolo XX». Una terapia che, armeggiando di continuo con le mete e i fini della vita e accentuando come elementi fondamentali la libertà e la responsabilità, sopperisce a questa fame di significato («logos»).
Frankl si è dunque addossato il compito di riumanizzare la scienza psicologica e psicoterapeutica, infirmata da una visione parziale e materialistica dell’uomo, proprio laddove è urgente prendere in considerazione la globalità dell’uomo, e dunque comprenderne la natura.
Una parte importante di queste intuizioni nacquero o furono confermate in quegli anni terribili di prigionia, che affiorano in queste poche ma preziose pagine, condotte senza risentimento, garbatamente, con una felicità narrativa quasi insospettabile in uno psichiatra. Tutte caratteristiche sorprendenti, se si ricorda che questo libro fu dettato in nove giorni, nel 1946, ancora in pieno sfacelo fisico e soprattutto a poche ore dalla notizia della morte, in altri lager, dei genitori, del fratello e soprattutto dell’amatissima moglie, lasciata, ventiquattrenne, incinta di pochi mesi.
Frankl si pone qui in sieme come soggetto di dolore e oggetto di indagine, riuscendo a calibrare il necessario coinvolgimento personale con il rigore del distacco scientifico. «Questo studio – subito avverte – non è dedicato ai grandi tormenti – già sovente descritti, anche se non sempre creduti – ma alle molte piccole sofferenze; in altre parole, a questo problema: come si è rispecchiata la vita quotidiana nell’anima del prigioniero medio, rinchiuso in un campo di concentramento?» (p. 25).
sieme come soggetto di dolore e oggetto di indagine, riuscendo a calibrare il necessario coinvolgimento personale con il rigore del distacco scientifico. «Questo studio – subito avverte – non è dedicato ai grandi tormenti – già sovente descritti, anche se non sempre creduti – ma alle molte piccole sofferenze; in altre parole, a questo problema: come si è rispecchiata la vita quotidiana nell’anima del prigioniero medio, rinchiuso in un campo di concentramento?» (p. 25).
Così veniamo condotti per mano nel labirinto dell’animo umano sottoposto a violentissime pressioni, psicologiche prima che fisiche. L’internato, dopo lo choc iniziale, comincia a scivolare verso un’apatia che rischia di farlo morire interiormente: la vita psichica si riduce a uno stadio primitivo, concentrandosi con tutte le forze nel disperato tentativo di salvare la vita fisica; nulla che non contribuisca all’immediato mantenimento in vita interessa più al prigioniero medio, non la solidarietà, non il dolore degli altri, non le offese né le umiliazioni, in una indifferenza e in un’apatia che, se rappresentano un meccanismo di autodifesa della psiche, pur sempre sono brutali.
Ma anche in una situazione-limite come la vita nel lager, l’uomo può soffocare questa apatia, è ancora libero di diventare un internato tipico o piuttosto di «essere degno del suo tormento», per dirla con Dostojewski. Imboccare questa seconda via non basterà probabilmente a salvare la vita (Frankl ricorda come in genere sopravvivessero i peggiori), ma allora la sofferenza e anche la morte acquistano un significato altissimo.
Certo, relativamente pochi realizzarono, in piena libertà interiore, quei valori che la sofferenza rende possibili, grazie alla loro grande maturità. «Ma se non vi fosse stato che un uomo solo, basterebbe la testimonianza di quest’uno, per asserire che l’uomo può essere nel suo intimo più forte del destino che gli viene imposto dall’esterno» (p. 117).
Per non lasciarsi cadere, in condizioni così difficili, era ed è necessario un sostegno interiore, un significato per la vita. «Chi ha un perché per vivere, sopporta quasi ogni come», ci dice l’autore citando Nietzsche. Stupende sono le pagine in cui Frankl racconta quando, in mezzo a grandi sofferenze, intuì la presenza di sua moglie, pur lontana e forse morta, la certezza di amare e di essere amato: pagine di fronte alle quali il filoso francese Gabriel Marcel confessa di non essere riuscito a trattenere le lacrime.
Un’opera, questa, che non ci consegna solo il ricordo di una drammatica esperienza vissuta, ma un messaggio all’uomo d’oggi e di tutti i tempi. Dunque non un libro tra i tanti sull’olocausto degli ebrei. Qualcosa di più, e di più profondo, e comunque di diverso. Qualcosa che Gabriel Marcel, nell’introduzione all’edizione francese, definisce «una testimonianza, non diciamo unica, ma di una qualità eccezionale, e al cui cospetto molte altre appaiono solo aneddotiche» (p. 7).






